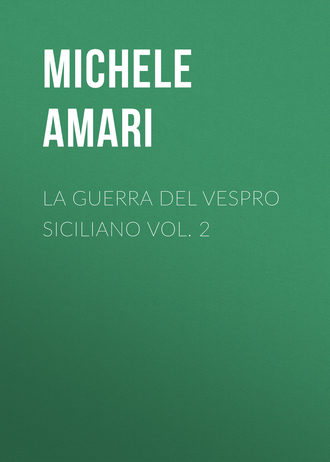
Полная версия
La guerra del Vespro Siciliano vol. 2
E per tal modo tutte le speranze si dileguarono; sendo finita questa generai pace d’oltremonti là dove avean accennato i trattati di Oleron e di Campofranco. Perchè la corte dì Roma, o non potendo beffarsi di Giacomo, o tornando a pensare alle cose d’Italia più che della Soria, non die’ ascolto al ripiego di Giacomo, offrente pagarle tributo per la Sicilia63: e rinnovò gli appresti di guerra contro Aragona64: ove le corti, mal soffrendo sempre il pericol proprio per l’utile altrui, di settembre dell’ottantanove avean mandato ambasciadori in Sicilia, che praticasser anco con Procida, Loria, Alamanno e Calcerando, a’ cui consigli Giacomo si reggea, e chiedesser venti galee siciliane in Catalogna, poichè per ragion della Sicilia si dovea quel reame rituffare ne’ mali della guerra65. A’ nuovi romori dunque, nacquero in Aragona discordie civili tra le corti e ’l re; le corti, inibita ad Alfonso ogni pratica dassè solo intorno la pace, voller che la si trattasse per dodici commissari della nazione66: e vinto Alfonso da necessità e stanchezza, ruppesi il debil filo al quale teneano gì’interessi di Giacomo. Bandito un congresso67 in Provenza, al quale al papa mandava i due cardinali Gherardo da Parma e Benedetto Gaetani68, perchè tra la riputazione della porpora e la capacità degli uomini, ogni cosa andasse a posta loro, alla prima si disse a Giacomo ch’inviasse suoi oratori, o si fece sperare d’ammetterli; ma quand’ei spacciò di giugno milledugentonovanta Gilberto di Castelletto e Bertrando de Cannelli, il re d’Aragona rispondea: si stessero; non gli sturbasser la pace sua; ferma quella, più agevol sarebbe a Giacomo69. Intanto i cardinali legati a diciannove agosto del novanta avean fermato un patto con Carlo II e Filippo il Bello, che fatta la pace con Aragona, ma persistendo la Sicilia, il re di Francia si godesse sempre la decima accordatagli per tre anni, e l’avesse per altri anni due con pagare al papa per le spese della guerra di Sicilia quattrocento mila lire tornesi, che si ridurrebbero a trecento mila racquistandosi l’isola entro un anno e due mesi. Non conchiusa la pace con Alfonso, il re di Francia darebbe dugento mila lire solamente; sarebbe aiutato dal papa contro l’Aragona, e anco da Carlo II, se questi riavesse la Sicilia nella quale dovea principiarsi la guerra70. E’ manifesto così qual pace serbassero a Giacomo: nè allora l’ignorava alcuno. Andò al congresso re Carlo co’ dodici commissari di re Alfonso e delle corti d’Aragona, presenti i due legati del papa, e quattro d’Inghilterra. Adunaronsi in Tarascon; e segnarono il trattato a Brignolles, il diciannove febbraio milledugentonovantuno.
Nel quale umiliossi Alfonso a promettere di chieder perdono al papa, dapprima per legati, indi entro dieci mesi anco in persona; di guerreggiar in Terrasanta; di rendere a Carlo gli statichi, la moneta, i prigioni di guerra; di richiamar tutti i sudditi suoi di Sicilia, e togliere a Giacomo ogni aiuto. S’ingaggiò Carlo in cambio a procacciar l’assentimento di Filippo il Bello e del Valois: vedrebbe la Chiesa di rivocar la concessione del reame a costui, e ribenedir l’Aragona. Lasciossi luogo ad entrar tosto nella pace al re di Maiorca, e a quel di Castiglia, se si potesse71. Il dì appresso i due cardinali intimavan questo trattato a Francia e alla corte di Roma72. Tanto si legge ne’ diplomi. Il Neocastro a queste condizioni aggiugne: riconosciuta l’alta signoria d’Alfonso su Maiorca; fermato censo annuo di trenta once d’oro, che pagasse Aragona alla corte di Roma; stabilito con quali forze dovesse andar Alfonso in Roma e indi in Terrasanta, e in Sicilia a procacciar anche con le armi la sommissione di Giacomo. Fu tolto allora ogni ostacolo al matrimonio d’Alfonso con la figliuola d’Eduardo d’Inghilterra: e un altro poco appresso ne strinse re Carlo per ottener la rinunzia del Valois, dando a Costui in isposa la sua figliuola Margherita, con le contee d’Angiò e Maine73.
Non ebbe tempo Alfonso a raccoglier di questa pace altro che il biasimo. Accrebbelo con fornir munizioni navali a Genova, per l’armamento di sessanta galee agli stipendi di re Carlo; che ripigliato animo alla impresa di Sicilia, di marzo andò in Genova, co’ due cardinali legati, a invitarvi que’ mercatanti guerrieri74. Ma quando più lieto si dipingea l’avvenire ad Alfonso, robusto e sano a ventisette anni, assicuratosi il reame, vicine le nozze con la bella figliuola d’Eduardo, una malattia di tre giorni l’uccise, il diciotto giugno del medesimo anno, pria che si fosse mandata ad effetto alcuna parte del trattato. Per non essere di lui figliuoli, ricadea la corona a Giacomo re di Sicilia. Talchè a un tratto dissipò la fortuna le meditazioni di chi avean intrecciato sì sottilmente la pace; e arrise alla Sicilia, per apparecchiarle più torbidi tempi, e poi maggior gloria. Giacomo, al primo avviso, convocato in fretta un parlamento a Messina, con molto affetto parlò; e, come suolsi sempre partendo, giurò eterno l’affetto, accomiatandosi da’ popoli in Messina, Palermo e Trapani; donde entrò in nave il dodici luglio. Lasciò luogotenente il fratel suo Federigo; una forte armata; assai acquisti in Calabria; e chiara fama di sè. Perchè negli otto anni che resse di presenza lo stato, dapprima vicario, poi re, s’ei fu in qualche incontro ingannatore e crudele, ne fece ammenda con la benignità nell’universale, i larghi ordini delle leggi, la virtù di guerra, le avventurate imprese contro i nimici della Sicilia. Oltre a ciò, sotto il suo governo ristoravasi la nazione a floridità e ricchezza; alleviata dalle tasse, e dalla tirannide che tutto soffoca in disperato letargo; francheggiata da sicurezza di buone leggi, e dalla virtù della rivoluzione che animava ogni parte del viver civile. Per le quali cagioni, accompagnavano amorosamente i Siciliani coi lor voti quel principe, che pochi anni appresso dovea meritare le più disperate maledizioni75.
CAPITOLO XIV
Primordi del regno di Giacomo in Aragona. Raffermata amistà tra Sicilia e Genova. Per quali ragioni allenava la guerra. Fazioni di Ruggiero Loria nel reame di Puglia e in Grecia. Giacomo si volge alla pace. Opinione pubblica in Sicilia; patriotti, Federigo d’Aragona, fazione servile; primi oratori al re. Primo trattato di Giacomo con re Carlo. Celestino V ratifica la pace. Più vigorosamente la procaccia Bonifazio VIII. Pratiche delle corti di Roma e d’Aragona con l’infante Federigo. Nuovi oratori a re Giacomo. Federigo chiamato al regno di Sicilia. Vana prova di papa Bonifazio a impedirlo. Settembre 1291 – gennaio 1296.
Volle re Pietro disgiunti i due reami d’Aragona e Sicilia, che per la distanza di tanto mare, e più per la libertà degli spiriti ed ordini pubblici, mal si potean reggere insieme, nè l’uno avria sofferto la dominazione dell’altro. Però chiamava a succedergli in Aragona Alfonso; Giacomo in Sicilia; quegli per testamento a Port Fangos pria dell’occupazione dell’isola; questi nel parlamento di Messina76: e venendo poi a morte, per fuggir viluppo novello di scomuniche, non fe’ altro lascio delle due corone combattutegli sì acerbamente dal papa; ma probabil è che desse in voce alcun solenne ricordo a tenerle divise per sempre77. Perchè a dieci marzo dell’ottantasei, Alfonso, giovane e ne’ principi d’un regno, piuttosto per compier tale ordinamento politico del padre, che per pensiero ch’aver potesse della morte, istituiva erede Giacomo, sì veramente che lasciasse la Sicilia a Federigo; e dava a Federigo la seconda aspettativa del reame d’Aragona, se Giacomo avesse più a grado la corona dell’isola, o si morisse senza figliuoli; nel qual caso poneva a Federigo ugual legge di risegnar la Sicilia a Pietro, lor ultimo fratello78. Ma Giacomo, che in fatto di principato mai non guardò misura, dapprima rimettea al caso della sua morte senza prole il partaggio delle due corone79; e allontanato di Sicilia, più aperto dinegava quei termini, che non eran legge scritta del padre, nè Alfonso li potea comandare. Non ceduta l’isola dunque; nel coronarsi a Saragozza il ventiquattro settembre del novantuno, protestò ascender quel trono per ragion del suo sangue, non per lascito di Alfonso80. Fortificovvisi con assentir quante più larghe franchezze e guarentige sepper chiedere le corti; con fidanzarsi a una fanciulla di nove anni, figliuola di Sancio re di Castiglia; e fermar di novembre del medesimo anno la pace con questo vicino, stigator delle civili turbolenze d’Aragona81. Raffrenò anco le guerre private; spense i ladroni che infestavano il paese82; spinse suoi maneggi fino a chieder aiuto di danari al soldano d’Egitto, al quale mandò Romeo di Maramondo e Ramondo Alamanno a vantar le sue vittorie e la sua possanza su tutte le corti cristiane della Spagna83: e fin qui rideasi della corte di Roma, fattasi a vietargli, con parole più che fermi colpi, il possedimento dell’Aragona84.
Tornaron vane del pari le pratiche di suscitar Genova a gagliardi aiuti contro la Sicilia, tentate come dicemmo fin dai primi principi di quella guerra, e ripigliate da Carlo lo Zoppo dopo la pace con Alfonso, e or incalzate con maggior calore anche dal papa85. Ma Genova in quel tempo non curava nelle cose temporali l’autorità della cotte di Roma; e quanto alla corte di Francia, se volea tenersela amica per comodo de’ commerci, il medesimo interesse la tirava a restare in pace con Aragona e Sicilia, nè amava una briga con le loro forze navali congiunte e vittoriose, mentre avea a lottare con le rivali repubbliche marittime d’Italia. I guelfi di Genova per vero posponendo, come fanno i faziosi, l’interesse pubblico alle passioni di parte, s’erano indettati con l’Angioino; e privati corsali, in sembianza di far prede su i Pisani, stendean la mano contro i Catalani che con essi navigavano86; e la interruzione de’ commerci tra Genova e Sicilia, avvenuta in questo tempo, mostrava i pericoli della guerra, che l’acume mercantile conosce sì da lungi. Ma come dopo que’ sospetti giunse a Messian un vago romore d’armata allestita in Genova, galee già uscite in corso, prese fatte ne mari di Lilibeo; tutta la Sicilia sen commosse: e rammaricava l’assenza dell’Ammiraglio, inebbriato in Catalogna presso il re87 a comparir primo a corte, cavalcare con grande stuol di clienti, abbattere ne’ tornei le più forti lance di Spagna88. E Federigo, o quegli esperti consiglieri rimasi con esso alla siciliana corte, seppero antivenir questa guerra. Mandano a Genova un oratore, affidato in pubblico a salde ragioni, in segreto alla riputazion dei Doria e Spinola e di tutta parte ghibellina. Il quale nei consigli del comune tornò a mente l’antica amistà con Aragona, con Sicilia; le enormezze della ambizione e avarizia di casa d’Angiò contro Genova: or, mutando gli amici co’ nemici, non credesser pure soggiogar l’isola a un tratto, nè provocar questa guerra senta rovina de’ loro commerci; e pensasser alle avverse bandiere di Venezia e Pisa, che potrebber trovare nuovi compagni. Soverchiata da cotesti evidenti interessi della repubblica ogni briga papale, e venuti allo stasso effetto altri legati del re d’Aragona, si vinse il partito, che rafferma la amistà con Giacomo, si restasse il comune da ogni atto ostile a Sicilia; non fosse lecito a privati armarsi contr’essa sotto quantunque colore89. Per lealtà, e riguardo all’ammiraglio di Sicilia, sì pronto alle vendette, l’anno appresso gli fu resa incontanente una nave carica di grano per Pisa, predata da mercatanti genovesi, con quel pretesto della cerca di merci pisane: e aggiungevi il comune, indennità di lire duemiladugento, ambasciadori a Federigo, che lui e Ruggiero sincerasser della fede genovese. Mantenuta fu questa poi contro la seduzion di larghe promesse, e la riputazione d’un’ambasciata di molti cavalieri di re Carlo, col conte d’Artois e legati della corte di Roma, allo scorcio del medesimo anno novantadue. Perchè i cittadini, sebbene divisi e parteggianti, sì che due anni appresso vennero al sangue, d’accordo rifiutaron ora la lega col re di Napoli, promettendo solo rigorosissima neutralità; tantochè dispettosi, senz’alcun frutto partironsi gli ambasciadori90.
Intanto volgean le cose d’Oriente ad estrema rovina: Acri in primavera del novantuno cadde sotto le armi d’Egitto: e le stragi dei battezzati, gli atroci trionfi degli infedeli91, davano argomento per tutta cristianità a lamentazioni piene di rabbia; correndo le lingue alla corte di Roma, e a’ tesori e al sangue sparsi contro Sicilia nel nome santo della croce. Però fu necessitata la romana corte a gridar addosso a’ maumettisti, tacendo alquanto di noi92. Rattenea ancora il papa un suo segreto pendìo a parte ghibellina, e l’amino tutto posto al vicino intento d’aggrandire i Colonnesi più che alla rimota ristorazione di Sicilia o di Terrasanta. Ed era molto abbassata parte guelfa in Italia, per quelle vittorie di Giacomo e de’ Siciliani93: il reame di Napoli scemo di danari, e di fortuna, e di territorio per le occupate Calabrie, governato da principe non guerriero, e stracco di tanti sforzi, male aiutavasi alla guerra94. La Sicilia non la rincalzava per non averne cagione; ella sicura al di dentro, nè vogliosa d’estender più in terraferma il dominio del suo re. Pertanto in questi due anni, ancorchè fossero corsi i termini della tregua di Gaeta, poco si travagliò con le armi. Turbolente passioni di feudatari, faceano in Calabria or perdere una terra, or un’altra acquistare. Blasco Alagona, capitano per Giacomo, il quale occupata Montalto, e sconfitto e preso Guidon da Primerano, guerriero di nome, già meditava più importanti fatti, per accusa di frode all’erario, tornò subito in Catalogna95. E lo stesso ammiraglio, rivenuto in questo tempo in Sicilia, e uscito a far giusta guerra, la governò debolmente.
Allestite in Messina trenta galee, e sapendo da’ suoi rapportatori nessun armamento farsi ne’ porti di Napoli e di Brindisi, navigò di giugno milledugentonovantadue ver Cotrone, donde Guglielmo Estendard con parecchie centinaia di cavalli era per muover contro i nostri acquisti di Calabria. Il quale, scoperta la flotta, correa co’ cavalli a por l’agguato alle Castella, sotto il capo Rizzuto; e l’ammiraglio addandosene, tolta con seco picciola man di cavalli, spiccò per altra via il grosso delle genti: e sì da due bande assaltarono alla sprovvista l’agguato francese. Estendard, cupidamente cercato a morte da’ nostri, ebbe tre ferite, e il veloce cavallo il campò. Abbattutosi il suo all’ammiraglio mentre incalzava al passaggio d’un ponte, preser tanto fiato i nemici da poter lasciare il campo con minore strage; ma ne cadder molti prigioni; tra i quali un Riccardo da Santa Sofia, che posto a guardia di Cotrone da re Giacomo, l’avea dato agli Angioini, ond’or incontrò il sommo supplizio.
Soddisfatto con questa scaramuccia all’onor dell’armamento, che la Sicilia forniva contro i nimici, Loria voltollo all’Arcipelago, sotto specie di combattere i feudatari francesi della Morea e le armi che teneanvi gli Angioini di Napoli, ma in effetto per saziarsi nelle solite scorrerie96, segnando la strada agli avventurieri che, finita la siciliana guerra dovean flagellare la Grecia con pari valore e avarizia. Corfù, Candia, Malvasia, Scio depredò o messe a taglia, sotto specie che avesser porto aiuto a’ Francesi: tolse a Scio gran copia di mastice; a Malvasia, oltre il bottino, l’arcivescovo, del quale poi ebbe grosso riscatto: e, radendo la Morea, fu a Corone, a Chiarenza; e prima a Modone virtuosamente combattè contro i Greci che gli tesero insidie. Tornatosi a Messina con più riccchezze che schietta gloria, seppe che i corsali di Positano ed Amalfi infestasser le nostre navi mercantesche; ond’ei divisava già con l’infante Federigo, alla nuova stagione portar su quelle spiagge quaranta galee e duemila fanti leggieri, arder barche e ville, e trinceratosi in un monta, dar il guasto a tutta la provincia; se non che trapelò in Napoli il disegno, e del tutto il dileguaro le pratiche della pace97. Perchè Giacomo trovossi in Aragopa nelle necessità medesime d’Alfonso; e alla Sicilia toccò nuovamente ber l’amaro delle dominazioni straniere. Dieci anni d’infelicissima guerra avean provato a’ nimici, che se la Sicilia vincer si potea, si potea soltanto in Ispagna. Ripigliaron dunque i trattati, tronchi dalla morte d’Alfonso; ai quali il re d Aragona tuttavia sforzavano il privilegio dal Valois, l’armi di Francia, le arti di Roma; e vi s’aggiunsero i brogli di Sancio re di Castiglia, che, per fuggir di trovarsi in mezzo a Francia e Aragona guerreggianti, sollecitava gli accordi in palese, a anco nascosamente pe’ partigiani suoi in quell’ultimo reame. Allor Giacomo, fatto accorto dall’espresso voler delle corti e della nazione tutta98, ch’ei tener non potrebbe ambo i regni, pensò lasciar la Sicilia, cagion di tanti travagli, che non rendeagli d’altronde più che l’Aragona nè obbedienza nè danari, pei limiti messi al potere regio, le misurate gravezze, la fatica e spendio della difesa. La morte di papa Niccolò d’aprile del novantadue, la guerra che scoppiò l’anno appresso tra Francia e Inghilterra, la lunga vacanza del pontificato, differirono mi non dileguarono la pace, comandata da interior forza nello stato aragonese. Calovvisi Giacomo più volentieri per profertagli terra e moneta, e soprattutto per isperanza di restar signore dei conquisti sopra Giacomo suo zio, re di Maiorca. Maneggiò il trattato, com’era sua indole, chiuso, ambidestro, dissimulante; sì che ad altri parve che beffasse gli Angioini, lasciando cader la corona di Sicilia dal suo capo su quel di Federigo; ma forse fu il contrario; e certo che avvolgendosi tra le torte vie, n’uscì com’avvien sovente, con infamia e poco guadagno99. La frode ebbe a lottar questa volta con la virtù d’una nazione, che per libertà novella era fatta rigogliosa, non intralciata e discorde; onde fu vinta la frode. La Sicilia, dopo quel felice ardimento, conoscea le sue forze; era piena d’alti spiriti per le guadagnate franchige civili, la nuova prosperità materiale, la provata virtù nelle armi, i molti ingegni esercitati nelle cose di stato quando divenner cose pubbliche. I quali elementi di vigor politico, stavano più nelle città che ne’ baroni; per la riputazion de’ partiti presi da quelle nell’ottantadue, delle grosse forze mandate, per dieci anni interi in oste e in armata, dell’attività e capacità de’ consigli municipali. E per vero le città primeggiarono nella mutazion di stato ch’or maturavasi; ad esse si accostò la più parte dei baroni, non per anco sviata dalla causa siciliana per timori e vizi d’ordine. La generalità dunque della nazione, tenendo alle libertà conquistate nel vespro, e abborrendo dalla dominazione di casa d’Angiò e della corte di Roma, presentava durissimo ostacolo a Giacomo; e tale anco gli era il proprio fratello, l’infante Federigo.
Venne Federigo in Sicilia appena fuor di fanciullo; quivi prestantissimo divenne, non meno all’armeggiare e in ogni esercizio di guerra, che negli studi delle lettere, allora in molto onore appo noi, de’ quali ebbe tal vaghezza, che poetava ei medesimo in lingua romanza, e amico fu dell’Alighieri, pria che lo sdegnoso spirito ghibellino lo sfatasse come dappoco. Ma brioso di gioventù, bello e gagliardo della persona, pronto d’ingegno, di piacevol tratto, a tutti grato ed umano, e fratello di re, caldamente l’amava il popolo, ch’ha femminil andare di passioni; e poteva anco da maturo consiglio augurarsen bene, al vederlo con moderazione e giustizia tener le supreme veci, e con ogni studio procacciare la prosperità del paese, che s’ebbe pace e abbondanza sotto il suo vicariato100. Necessità politica, spesso sentita come da istinto innanzi che netta si divisasse alle menti, fe’ coltivar a Federigo con maggiore studio quelle virtù, e ’l rese più caro al popolo; portandoli entrambi a sperar l’uno nell’altro; e spingendoli a tali termini, che forse niuno si proponeva dapprima. Così la parte patriottica in Sicilia rannodavasi intorno a Federigo, sperando mantenere gl’intenti della rivoluzione del vespro, senza metter giù la monarchia nè la dinastia aragonese; e ne diveniva più solida e più forte.
Contro tal volere della massa della nazione, Giacomo potea trovar sostegno in una sola fazione. Accese le guerre del vespro, gli usciti di terraferma adunaronsi sotto le nostre insegne, massime dopo la esaltazion di re Pietro; cercando fortuna, e sfogo all’odio contro casa d’Angiò, e termine, se si potesse, al doloroso lor bando. Molto con lor pratiche operaron costoro nelle guerre di Calabria; molto stigarono i Siciliani stessi, come nell’eccidio de’ prigioni a Messina nell’ottantaquattro, temendo sempre non allenasse la rivoluzione. Ma più che alla Sicilia, teneano al re, che speravano s’insignorisse della lor patria; e intanto li gratificava di feudi e ufici. In più numero ebbero simile stato in Sicilia uomini catalani e aragonesi, creature della corte, e però, al par degli usciti di Puglia, esosi a’ Siciliani, per gelosia dei premi che gli uni e gli altri usurpavano. A costoro s’univa, perchè non mancano i rinnegati giammai, qualche Siciliano. E con tal fazione servile pensò Giacomo di mercatare la tradigione della Sicilia; a chi profferendo di redintegrarle ne’ beni lasciati in Puglia, senza perdita de’ nuovi acquisti in Sicilia; a chi minacciando lo spogliamente di sue sostante in Ispagna; tutti adescando con promesse, carezze, e inique speranze sotto sante parole. Chi ha appreso il nome di Giovanni di Procida su le novelle istoriche che il danno autor del vespro, maraviglierà a vederlo primeggiare in questa fazione e tener pratiche con lo stesso re di Napoli, s’ignora se di voler di Giacomo, o senza. Ma oltre le parole de’ nostri istorici, ond’ei si scorge pochi anni appresso scopertamente sorto contro i patriotti siciliani e Federigo, e oltre i documenti della restituzion de’ suoi beni nel reame di Napoli, pattuita espressamente tra Giacomo e Carlo II101, avvi, monumento di vergogna al suo nome, uno spaccio di Carlo al siniscalco di Provenza, dato il venti marzo milledugentonovantatrè, perchè libero mandasse a corte di Napoli il siciliano Pietro di Salerno, inviato a Carlo dal Procida, e fatto prigione in Marsiglia102. Cimentato quel gran nome con le forze che ha in oggi l’istoria, sen dileguano i vanti della prima congiura: gli resta la sola feccia di questa seconda contro la Sicilia.
Entrando il novantadue, re Carlo e ’l papa mandarono oratore a Giacomo, Bonifacio di Calamandrano, maestro degli Spedalieri gerosolimitani di qua dal mare103, famoso in arme e assai destro ne’ maneggi di stato. Col quale il figliuol di re Pietro, discepolo di Procida, temporeggiò104 per la sopravvenuta morte del papa; rispondendo, che per essergli i Siciliani compagni nei dritti politici, non soggetti impotenti, ad essi ne riferirebbe: e in vero pensò che, non assentito da loro, rimarrebbe in carte ogni accordo. Inviava dunque a tentar gli animi Gilberto Cruyllas, cavalier catalano, che approdato in Messina il due aprile del novantatrè, conturbò d’ansietà dolorosa tutti i Siciliani. Vagamente spargeasi, divisato pace con Francia e re Carlo, e di riaver la grazia della Chiesa; ma spiegavan queste scure e compilate parole la disarmata flotta, i mercenari licenziati senza pure sgravar le collette, sopra ogni altro, gli stormi di frati stranieri che, chiudendo gli occhi i governanti, svolazzavan sinistri per tutta l’isola, a spiare, novellare, cercare i penetrali delle coscienze, ingerirsi appo nobili e cittadini. Ondechè adunato al venir di Gilberto un parlamento, apparve manifesto il voler della nazione. Pochi vollero assentire; negaron la pace i migliori, com’evidente magagna: e si deliberò che ambasciadori s’inviassero a intender espresso l’animo del re. Furon trascelti a nome di tutto il sicilian popolo, tre Messinesi, Federigo Rosso e Pandolfo di Falcone cavalieri, e Ruggiero Geremia giurisperito, e tre Palermitani, Giovanni di Caltagirone e Ugone Talach cavalieri, e Tommaso Guglielmo. In Barcellona appresentaronsi a Giacomo.
Il quale fe’ loro lieta e famigliare accoglienza, condottili nelle più segrete sue stanze: e parlava, esser cresciuto tra i Siciliani; da loro aver tolto pensieri, costumi, usanze; pensassero s’altro potea bramare che il ben del paese; ed ecco che non da principe, ma come un altro cittadino, con essi triterebbe il negozio, divisato a onore ed util comune. E gli ambasciadori, non presi alle blandizie del re, si guardavan l’un l’altro. Ma il Falcone, accorto e bel parlatore, venne alle prese. Giustizia, dissegli, e verità che l’è compagna, voglionsi nel trattar le sorti de’ popoli: e dolce è ad ogni uomo la parola di pace; ma grossolana favola assai questa, che Roma e casa d’Angiò, dopo dodici anni d’oltraggi, di paure, di sangue, or lasciasser di queto la Sicilia. I sospetti poi toccò di que’ provvedimenti del governo regio in Sicilia; l’aperta frode del profferire all’infante Federigo l’uficio di senator di Roma, per trarlo dall’isola. Nè sperasse il re ferma pace in Aragona, in prezzo de consegnar legato mani e pie’ un generoso popolo; nè sperasse cansar da infamia il suo nome. Se pure, ei ripigliò, il gravava questo combattuto regno, perchè non lasciarlo provveder a sè da sè stesso, dando la corona a Federigo, non per dritto di successione, ma per elezion del popolo, lietissimo auspicio a chi unquemai la Sicilia reggesse? E se tremassero Giacomo e Federigo e tutti i reali d’Aragona, chiamerebbero i Siciliani un altro Federigo, rampollo della casa di Svevia; troverebbero i più disperati partiti, pria che abbassar le aquile dianzi agli abborriti gigli105: e se Iddio non benedicesse le armi loro, affranti alfine e debellati, vibrerebbero gli ultimi colpi ne’ petti de’ propri figliuoli e delle donne; sè stessi con quelle care vittime scaglierebbero nelle fiamme delle città. Ma Giacomo non se ne mosse. Lodò i legati di zelo; lodò i suoi propri maggiori di fede ai popoli: ei, nato di quel sangue, non che non abbandonar la Sicilia, combatterebbe per lei finchè gli restasse spirito di vita106. Con questo focoso parlare accomiatolli: e non andò guari che di novembre, abboccatosi tra Junquera e Paniças con re Carlo, fermò i patti, a sè più avvantaggiosi, verso la Sicilia più rei, che que’ d’Alfonso, maladetti da lui medesimo, tre anni prima. Tennersi in segreto grandissimo; aspettando a ultimarli in buona forma, che fosse rifatto il papa, e raggirato, col popol di Sicilia, anco l’infante Federigo107, cresciuto di potenza, perchè come i nostri videro più da presso la minaccia del giogo angioino, la perfida morbidezza di Giacomo, prendendone sempre in maggiore abborrimento la dominazione straniera, che sotto Carlo li avea calpestato sì orrendamente, sotto il re d’Aragona macchinava tal tradigione, vennerne al fermo proposito di rifarsi indipendenti; e più s’accostaron gli animi a Federigo.




