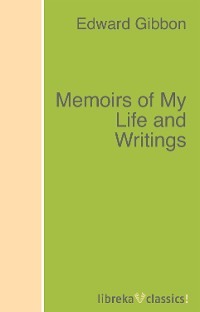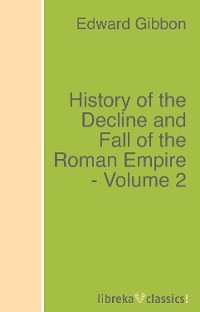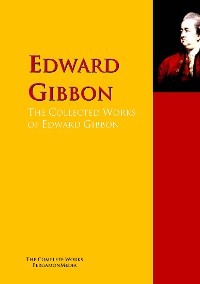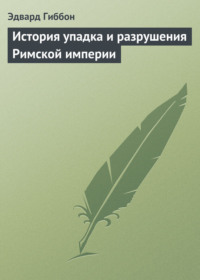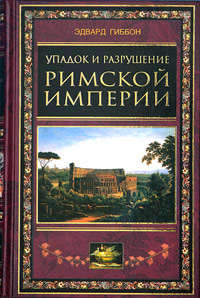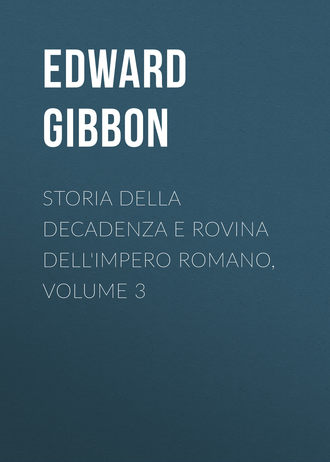
Полная версия
Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 3
50
Euseb. III. 20. La storia o presa da Egesippo.
51
Vedasi la morte, ed il carattere di Sabino appresso Tacito (Hist. III. 74-75). Sabino era il fratel maggiore di Vespasiano, e fino all'avvenimento al trono di lui, si era considerato come il principal sostegno della famiglia Flavia.
52
Flavium Clementem patruelem suum contemtissimae inertiae… ex tenuissima suspicione interemit. Sueton. in Domit. c. 15.
53
L'Isola Pandataria secondo Dione. Bruzio Presente (ap. Eusebio III 18) la bandisce in quella di Ponzia, che non era molto distante dalla prima. Tal differenza, ed un errore o d'Eusebio, o de' suoi copisti han data occasione di supporre due Domitille, una moglie, e l'altra nipote di Clemente. Vedi Tillemont, Mem. Eccles. (Tom. II. p. 224.)
54
Dione l. LXVII. p. 1112. Se Bruzio Presente, dal quale probabilmente prese questo racconto, era il corrispondente di Plinio (Epist. VII. 3) possiam risguardarlo come uno scrittore contemporaneo.
55
Sueton. in Domit. c. 17. Filostr. in vit. Apollon. l. VII.
56
Dion. l. LXVIII. p. 1118. Plin. Epist. IV. 22.
57
Plin. Epist. X. 97. L'erudito Mosemio si esprime con le più alte lodi intorno al moderato ed ingenuo carattere di Plinio. A malgrado di tutti i sospetti del Dottore Lardner (Vedi le testimonianze Giudaiche e Pagane Vol. II. p. 46), io non posso ravvisare alcuna ipocrisia nel suo linguaggio o nella sua maniera di procedere.
58
Plin. Epist. V. 8. Egli difese la sua prima causa nell'anno 81, cioè un anno dopo la famosa eruzione del Vesuvio, nella quale il suo zio perdè la vita.
59
Plin. Epist. X. 98. Tertulliano (Apolog. c. 5) risguarda questo Rescritto, come un rilassamento delle antiche leggi penali quas Traianus ex parte frustratus est. Eppure Tertulliano in un altro luogo delle sue Apologie nota l'incoerenza di proibire le inquisizioni, e di ordinare i gastighi.
60
Eusebio (Hist. Eccles. l. IV. c. 9) ci ha conservato l'editto di Adriano. Egli ce ne dà parimente uno (c. 13) ancora più favorevole sotto nome di Antonino, del quale però non s'ammette così universalmente l'autenticità. La seconda Apologia di Giustino contiene alcune curiose circostanze relative alle accuse de' Cristiani.
61
Vedi Tertulliano (Apolog. c. 40). Gli atti del martirio di Policarpo somministrano una viva pittura di tali tumulti, che per ordinario si fomentavano dalla malizia dei Giudei.
62
Questi regolamenti sono inseriti ne' soprammentovati Editti di Adriano e di Pio. Vedi l'Apologia di Melitone (ap. Euseb. l. IV. c. 26).
63
Vedasi il rescritto di Traiano, e la condotta di Plinio. Gli atti più autentici de' Martiri abbondano di simili esortazioni.
64
In specie vedasi Tertulliano (Apolog. c. 2) e Lattanzio (Instit. Divin. V. 9.) I raziocinj loro son quasi gl'istessi; ma si ravvisa bene, che il primo di questi Apologisti era stato un legale, ed il secondo un rettorico.
65
Vedansi due esempi di questa specie di tortura negli Atti Sinceri de' Martiri pubblicati dal Ruinart (p. 160-399.). Girolamo, nella sua Leggenda di Paolo Eremita, riporta una strana istoria d'un giovane, che fu legato nudo in un letto di fiori ed assalito da una bella e lasciva meretrice. Egli represse la tentazione lacerandosi co' denti la lingua.
66
La conversione della propria moglie provocò Claudio Erminiano, Governatore della Cappadocia, a trattare i Cristiani con straordinario rigore. Tertulliano ad Scapulam cap. 3.
67
Tertulliano, nella sua lettera al Governatore dell'Affrica, fa menzione di molti notabili esempi di lenità e di tolleranza, de' quali esso ebbe notizia.
68
Neque enim in universum aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui potest; espressione di Traiano che diede un largo campo alle operazioni de' Governatori delle Province.
69
In metalla damnamur, in insulas relegamur. Tertullian. Apolog. c. 12. Le miniere della Numidia contenevano nove Vescovi, con un numero de' loro Cherici e Popolo a proporzione, ai quali Cipriano mandò una pietosa lettera di consolazione o di lodi. Vedi Cipriano (Epist. 76, 77.)
70
Quantunque non possiam prestare intera fede all'epistole, o agli atti d'Ignazio, che si trovano nel II tomo dei Padri Apostolici; pure possiam citare quel Vescovo d'Antiochia come uno di questi martiri condannati per esempio degli altri. Fu egli mandato in catene a Roma come ad un pubblico spettacolo; e quando arrivò a Troade, ricevè la piacevol notizia, che la persecuzione d'Antiochia era già terminata.
71
Fra' Martiri di Lione (Euseb. l. V. c. 1) la schiava Blandina fu distinta co' più squisiti tormenti. De' cinque Martiri, sì celebri negli Atti di Felicita e Perpetua, due erano servi, e due altri di molto vil condizione.
72
Origen. adv. Celsum. (l. III. p. 116.). Le sue parole meritano d'essere trascritte. Ολιγοι κατα καιρους, καὶ σφοδρα ευαριθμητοι περι τῶν Χρισιανῶν θεοσεβειας τεθνηκασι.
73
Se noi riflettiamo, che tutti i plebei di Roma non eran Cristiani, e che tutti i Cristiani non eran santi nè martiri, possiam giudicare, con quanta certezza possano attribuirsi gli onori sacri a quelle ossa ed urne, che si prendono senza distinzione alcuna da' pubblici cimiteri. Dopo un libero ed aperto commercio, che se n'è fatto per dieci secoli, si è risvegliato qualche sospetto fra' più eruditi Cattolici. Al presente si richiedono, come una prova di santità e di martirio le Lettere R. M., una caraffa piena di liquor rosso, che si crede sangue o la figura di una palma. I due primi segni però son di piccolo peso, e quanto all'ultimo si osserva da' Critici 1. che quella che si dice figura d'una palma, è forse un cipresso o anche puramente un punto, o un intrecciamento di punteggiatura usato nelle iscrizioni sepolcrali; 2. che la palma era il simbolo della vittoria fra' Pagani; 3. che fra' Cristiani serviva come d'emblema non solo del martirio, ma anche di una gloriosa risurrezione in genere. Vedi la lettera del P. Mabillon sul culto de' Santi ignoti, ed il Muratori sopra le Antichità Italiane (Dissert. LVIII.).
74
Per dare un saggio di queste leggende, ci contenteremo de' diecimila soldati Cristiani fatti crocifiggere in un giorno da Traiano o da Adriano sul monte Ararat. Vedi Baronio ad Martyrol. Rom. Tillemont (Mem. Eccles. Tom. II. P. II. p. 438.) e le Miscellanee di Geddes vol. II. p. 203. L'abbreviatura MIL., che può significare tanto soldati che migliaia, dicesi, che abbia prodotto vari sbagli straordinari.
75
Vedi Dionisio ap. Euseb. l. VI. c. 41. Uno de' diciassette fu accusato ancora di furto.
76
Le lettere di Cipriano somministrano una molto curiosa ed original pittura sì di esso che de' suoi tempi. Vedansi parimente le due vite di Cipriano, scritte con ugual esattezza quantunque con mire assai differenti, l'una da Le Clerc (Biblioth. univers. Tom. XII. p. 208-378.) l'altra dal Tillemont (Memoir. Eccles. Tom, IV. part. I. p. 76-459).
77
Vedasi la civile ma severa lettera del Clero di Roma al Vescovo di Cartagine (Cyprian. Epist. 8, 9.) Ponzio pone la massima cura e diligenza in giustificare il suo maestro contro la general censura, che se gli faceva.
78
Specialmente quello di Dionisio di Alessandria, e di Gregorio Taumaturgo di Neocesarea. Vedi Euseb. (H. E. lib. VI. c. 40) e le Memorie di Tillemont (Tom. IV. Part. II. p. 685.).
79
Vedi Cipriano, Epist. 16, e la vita che ne fece Ponzio.
80
Abbiamo una vita originale di Cipriano fatta dal Diacono Ponzio, compagno del suo esilio e spettatore della sua morte; e possediamo ancora gli antichi Atti Proconsolari del suo martirio. Questi due documenti son coerenti fra loro e probabili; e quel ch'è più osservabile, sono spogliati di qualunque circostanza maravigliosa.
81
Potrebbe parere, che questi fosser ordini circolari mandati a tutti i Governatori nel medesimo tempo. Dionisio (ap. Euseb. l. VII. c. 11.) racconta l'Istoria del proprio esilio da Alessandria, quasi nell'istessa maniera. Ma siccome egli evitò la morte, o sopravvisse alla persecuzione, si dee reputare o più o men fortunato di Cipriano.
82
Vedi Plinio, Hist. Nat. V. 3. Cellario Geogr. ant. (Part. III. p. 96.) i Viaggi di Shaw p. 90, e per l'adiacente paese (ch'è terminato dal Capo Bona, o dal promontorio di Mercurio) l'Affrica di Marmol (Tom. II. p. 474.). Si trovano ivi i residui di una acquedotto vicino a Curubis, o Curbis presentemente mutato in Gurbes; ed il D. Shaw lesse un'iscrizione, che chiama quella città Colonia Fulvia. Il Diacono Ponzio (in vit. Cypriani c. 12) l'appella apricum et competentem locum, hospitium pro voluntate secretum, et quidquid apponi eis ante promissum est, qui regnum et justitiam Dei quaerunt.
83
Vedi Cipriano (Epist. 77. Edit. Fell.)
84
Nell'atto della sua conversione aveva egli venduto quei giardini per benefizio de' poveri. La bontà di Dio (probabilissimamente la liberalità di alcuni amici Cristiani) li restituì a Cipriano. Vedi Ponzio c. 15.
85
Quando Cipriano un anno avanti era stato mandato in esilio, sognò che sarebbe stato posto a morte nel seguente giorno. L'evento fece spiegare quella parola come indicante un anno. Vedi Ponzio. c. 12.
86
Ponzio (c. 15) confessa che Cipriano, col quale cenò egli stesso, passò la notte custodia delicata. Il Vescovo esercitò l'ultimo atto di giurisdizione molto a proposito, disponendo, che le giovani donne, che vegliavano nella strada, fossero allontanate dal pericolo, e dalle tentazioni di una folla notturna. Act. Proconsolar. c. 2.
87
Vedasi negli Atti c. 4, ed appresso Ponzio c. 17, la sentenza originale. Quest'ultimo l'esprima in un modo oratorio.
88
Vedi Ponzio c. 19. Al Tillemont (Memoir. Tom. IV. Part. I p. 450 nat. 50) non piace una così positiva esclusione di ogni Martire di grado Episcopale più antico.
89
Qualunque sia l'opinione che possiamo avere del carattere o de' principj di Tommaso Becket, bisogna confessare ch'egli soffrì la morte con una costanza non indegna de' primitivi Martiri. Vedi Lord Lyttelton Istor. di Enrico II. (Tom. II. p. 592 ec.).
90
Vedasi particolarmente il trattato di Cipriano de Lapsis p. 87-98. Ediz. Fell. L'erudizione di Dodwell (Dissert. Cyprian. XII. XIII.) e l'ingenuità di Middleton (Ricerca libera p. 162 ec.) non hanno lasciato cosa da aggiungere intorno al merito, agli onori, ed ai motivi de' Martiri.
91
Vedi Cipriano Epist. 5, 6, 7, 22, 24 e de unit. Eccles. Il numero de' pretesi Martiri si è moltiplicato assaissimo per l'uso, che fu introdotto, di dare quest'onorevole nome a' Confessori.
92
Certatim gloriosa in certamina ruebatur; multoque avidius tum martiria gloriosis motibus quaerebantur, quam nunc Episcopatus pravis ambitionibus appetuntur. Sulpic. Sever. l. II. Egli poteva omettere la parola nunc.
93
Vedi Epist. ad Rom. c. 4, 5 ap. Patres Apostol. (Tom. II. p. 27.). Era confacente al proposito del Vescovo Pearson (Vindic. Ignatian. part. II. c. 9) di giustificare con profusione di esempi e di autorità i sentimenti d'Ignazio.
94
L'Istoria di Polieuto, sulla quale Cornelio ha formato una bellissima tragedia, è uno de' più celebri, quantunque non de' più autentici esempi di questo eccessivo zelo. Noi dobbiam osservare, che il canone 60 del Concilio d'Elvira nega il titolo di martiri a quelli che si esponevano alla morte col pubblicamente distruggere gl'Idoli.
95
Vedi Epitteto l. IV. c. 7, e (sebbene vi sia qualche dubbio, s'egli alluda a' Cristiani) Marco Antonino de rebus suis (l. XI. c. 3.) Lucian. in Peregrin.
96
Tertullian. ad Scapul, c. 5. Gli eruditi son divisi fra tre dell'istesso nome, che furon Proconsoli d'Asia. Io sono inclinato ad attribuire questo fatto ad Antonino Pio, che poi fu Imperatore, e che può aver governato l'Asia sotto Traiano.
97
Mosem. de rebus Christ. ante Constant. p. 235.
98
Vedi l'epistola della Chiesa di Smirne ap. Euseb. Hist. Eccl. (l. IV. c. 15).
99
Nella seconda Apologia di Giustino si trova un esempio speciale e molto curioso di questa legal dilazione. Il medesimo fu concesso a' Cristiani accusati nella persecuzione di Decio; e Cipriano (de Lapsis) fa espressa menzione del dies negantibus praestitutus.
100
Tertulliano risguarda la fuga dalla persecuzione come un'imperfetta, sebbene assai colpevole, apostasia, come un empio tentativo di eludere la volontà di Dio ec. Egli ha scritto un trattato su tal proposito (Vedi p. 536-544. Edit. Rigalt.). che è pieno del più fiero fanatismo e della più incoerente declamazione. Merita però qualche attenzione il vedere che Tertulliano medesimo non sofferse il martirio.
101
I Libellatici, che sono specialmente noti per le opere di Cipriano, vengono descritti con la massima precisione nel copioso commentario di Mosemio p. 48, 489.
102
Vedi Plinio (Epist. X. 97.) Dionisio Alessandrino. ap. Euseb.(l. VI. c. 41.) Ad prima statim verba minantis inimici maximus fratrum numerus fidem suam prodidit: nec prostratus est persecutionis impetu, sed voluntario lapsu seipsum prostravit. Cyprian. oper. p. 89. Fra questi disertori trovaronsi molti Preti ed anche Vescovi.
103
Fu in quest'occasione, che Cipriano scrisse il suo trattato de Lapsis, e molt'epistole. Fra' Cristiani del secolo antecedente non si trova la controversia intorno al trattamento degli apostati penitenti. Dobbiamo noi attribuirlo alla superiorità della fede e coraggio di essi, od alla più scarsa cognizione, che abbiamo della loro Istoria?
104
Vedi Mosemio p. 97. Sulpicio Severo fu il primo autore di questo computo, quantunque sembri, che desideri di riservar la decima e maggiore persecuzione per la venuta dell'Anticristo.
105
Della testimonianza, che fece Ponzio Pilato si fa menzione per la prima volta da Giustino. I successivi accrescimenti fatti a quell'Istoria (nel passare ch'ella fece per le mani di Tertulliano, di Eusebio, di Epifanio, di Grisostomo, di Orosio, di Gregorio Turonense, e degli autori di molte edizioni degli Atti di Pilato) sono esattamente fissati dal Calmet; Dissertazioni sulla Scrittura (Tom. III. p. 651. ec.).
106
Rispetto a questo miracolo, come si dice comunemente della Legione fulminea, vedasi l'ammirabil critica di Moyle Vol. II. p. 81-390 delle sue opere.
107
Dione Cassio, o piuttosto l'abbreviatore di lui Sifilino, l. LXXII. p. 1206. Moyle ha esposto lo stato della Chiesa nel Regno di Commodo.
108
Si confronti la vita di Caracalla nell'Istoria Augusta con la lettera di Tertulliano a Scapula. Il Dottore Jortin (Osservaz. sull'Istor. Ecclas. Vol. II. p. 5.) risguarda la cura di Severo per mezzo dell'olio santo con gran desiderio di convertirla in un miracolo.
109
Tertulliano De Fuga, c. 13. Il dono si faceva in occasione delle feste de' Saturnali; ed è un soggetto di grand'importanza per Tertulliano, che il Fedele dovesse restar confuso con quelli, ch'esercitando le professioni più infami, accattavano la connivenza del Governo.
110
Euseb. l. V. c. 23. 24. Mosem. p. 435, 447.
111
Judaeos fieri sub gravi poena vetuit. Idem etiam de Christianis sanxit. Hist. Aug. p. 70.
112
Sulpic. Sever. l. II. p. 384. Questo computo (fattavi una sola eccezione) vien confermato dall'istoria d'Eusebio e dalle opere di Cipriano.
113
Si discute l'antichità delle Chiese Cristiane dal Tillemont (Memoir. Eccles. Tom. III. part. II. p. 68-72) e dal Moyle (Vol. I. p. 378-398). Quegli riferisce la prima costruzione di esse alla pace di Alessandro Severo; questi alla pace di Gallieno.
114
Vedi l'Istoria Augusta p. 130. L'Imperator Alessandro adottò il loro metodo di proporre pubblicamente i nomi di quelle persone, che dovevan promuoversi agli Ordini. È vero però che l'onore di tal costume si attribuisce ancora agli Ebrei.
115
Vedi Eusebio Hist. Eccl. l. VI. c. 21 e Girolamo de script. Eccl. c. 54. Mammea fu chiamata una santa e pia donna sì da' Cristiani che da' Pagani. Da' primi però era impossibile, che essa potesse meritar quell'onorevol epiteto.
116
Vedi L'Istoria Augusta p. 123. Sembra, che Mosemio (p. 465) troppo nobiliti la domestica religione d'Alessandro. Il suo disegno di fabbricare un pubblico tempio a Cristo (Hist. Aug. p. 129) e le obbiezioni, che furon suggerite o ad esso, o in simili circostanze ad Adriano, par che non abbiano avuto altro fondamento, che un improbabil racconto inventato da' Cristiani, ed adottato con troppa credulità da un Istorico del tempo di Costantino.
117
Euseb. l. VI. c. 28. Si può presumere che i buoni successi de' Cristiani avessero commosso ad ira l'ipocrita devozione de' Pagani che sempre andava crescendo. Dione Cassio, il quale compose la sua Storia sotto il regno anteriore, destinava molto probabilmente ad uso del suo Sovrano que' consigli ch'egli attribuiva ad una migliore età ed al favorito di Augusto. Intorno a quest'orazione di Mecenate, o per dir meglio, di Dione, posso riferire il lettore all'imparziale opinione che ne ho portato io medesimo (Vol. I N. 25), ed all'abbate De la Bleterie (Mem. de l'Acad. t. XXIX. p. 303. t. XXV. p. 432).
118
Orosio (l. 7. c. 19) rappresenta Origene come l'oggetto dell'odio di Massimino; e Firmiliano, Vescovo di Cappadocia in quel tempo, dà una giusta e ristretta idea di questa persecuzione. Vedi Cipriano (Epist. 75.).
119
La menzione che si fa di que' Principi, che pubblicamente si supponevan Cristiani, quale si trova in una lettera di Dionisio Alessandrino (ap. Euseb. l. VII. c. 10) evidentemente allude a Filippo ed alla sua famiglia, ed è una testimonianza contemporanea, che tal opinione aveva preso vigore; ma il Vescovo Egiziano, che viveva in una umile distanza dalla corte di Roma, si esprime con una giusta diffidenza rispetto alla verità del fatto. Le lettere d'Origene che sussistevano al tempo d'Eusebio (Vedi l. VI. c. 36) probabilmente deciderebbero questa più curiosa che importante questione.
120
Euseb. l. VI. c. 34. L'istoria è stata abbellita, secondo il solito, da' successivi scrittori, ed è confutata con sovrabbondante erudizione da Federigo Spanemio (Oper. var. Tom. II. p. 440 ec.).
121
Lactant. de Mortib. Persec. c. 3, 4. Dopo aver celebrato la felicità e l'avanzamento della Chiesa, durante una lunga successione di buoni Principi, soggiunge: Extitit post annos plurimos execrabile animal, Decius, qui vexaret Ecclesiam.
122
Euseb. l. VI. c. 39. Cyprian. Epist. 55. Rimase vacante la Sede Romana dal martirio di Fabiano, che seguì nei 20 di Gennaio dell'anno 250, fino all'elezion di Cornelio fatta ne' 4 Giugno del 251. Decio era probabilmente partito da Roma, giacchè fu ucciso avanti la metà di quell'anno.
123
Vedi Eusebio l. VII. c. 10. Mosemio (p. 548) ha dimostrato molto chiaramente, che il Prefetto Macriano ed il Mago Egizio sono un'istessa persona.
124
Eusebio (l. VII. c. 13) ci dà una versione Greca di quest'editto Latino, che sembra essere stato molto conciso. Per mezzo di un altro Editto Gallieno comandò, che si restituissero a' Cristiani i Cimiteri.
125
Vedi Eusebio l. VII. c. 30. Lattanzio de Mort. Persecut. c. 6. S. Girolamo in Chron. p. 177. Oros. l. VII. c. 23. Il lor linguaggio è generalmente sì ambiguo e scorretto, che non sappiamo determinare fino a qual segno Aureliano estendesse le sue intenzioni avanti che fosse assassinato. Moltissimi fra i moderni eccettuato Dodwell (Dissert. Cyprian. XI. 64.) hanno preso di qui l'occasione di guadagnare alcuni pochi Martiri straordinari.
126
Paolo si compiaceva più del titolo di Ducenario che di quello di Vescovo. Il Ducenario era un procuratore Imperiale, così chiamato dal suo salario di dugento sesterzi, o di tremila dugento zecchini l'anno. (Vedi Salmasio ad Hist. Aug. p. 124) Alcuni Critici suppongono, che il Vescovo d'Antiochia realmente avesse ottenuto quell'uffizio da Zenobia, mentre altri non lo considerano che come un'espressione figurata del suo fasto ed insolenza.
127
La simonia non era incognita in que' tempi ed il Clero alle volte comprava quel che avea intenzione di vendere. Ciò si chiarisce dal Vescovato di Cartagine, che fu comprato da una ricca Matrona chiamata Lucilla, per il suo servo Maiorino. Il prezzo, fu di 400 Folli (Monum. antiq. ad calcem Optati p. 263.) Ogni Folle conteneva 125 monete d'argento, e può valutarsi tutta la somma circa 4800 zecchini.
128
Se volessimo diminuire i vizi di Paolo, saremmo costretti a sospettare, che i Vescovi dell'Oriente, adunati insieme, avessero pubblicato le più maliziose calunnie in una lettera circolare mandata a tutte le Chiese dell'Impero (ap. Euseb. l. VII. c. 30).
129
La sua eresia (come quelle di Noeto e di Sabellio, che insorsero nel medesimo secolo) tendeva a confondere la misteriosa distinzione delle persone Divine. Vedi Mosemio p. 720. ec.
130
Vedi Eusebio (Hist. Eccl. l. VII. c. 30). Ad esso è interamente dovuta la curiosa istoria di Paolo Samosateno.
131
L'Era de' Martiri, ch'è sempre in uso fra' Copti e gli Abissinj, dee computarsi dal 29 Agosto dell'anno 284, perchè il principio dell'anno Egiziano cadeva diciannove giorni prima del reale avvenimento al trono di Diocleziano. Vedasi la Dissertazione preliminare all'Arte di verificar le date.