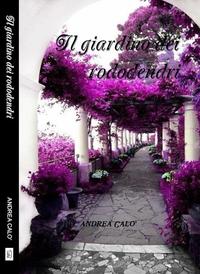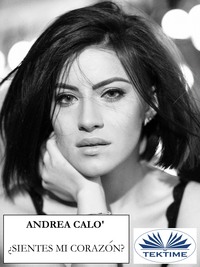Полная версия
Lo Senti Il Mio Cuore?
Questa volta era andata lei a segno, aveva assestato un colpo che mi aveva fatto maledettamente male. La guardai, sconfitta e senza alcuna voglia di ribattere. Forse la mia fuga non sarebbe servita a nulla, capii che anche scappando a gambe levate dal mio passato sarei ricaduta in un presente ed un futuro fatti a sua immagine e somiglianza. Abbassai gli occhi e giunsi le mani posandole sulle mie gambe, aggiungendo un tono di rassegnazione alla mia sconfitta e rimanendo in attesa che il mio avversario mi infliggesse il colpo di grazia, per finirmi come avrebbe fatto un gladiatore nell’arena dopo aver ottenuto il permesso di uccidere da parte del suo imperatore, per placare la sua sete di sangue. Ma questa volta l’imperatore mi graziò, il pollice era rimasto rivolto verso l’alto, la folla non gridava perché non aveva visto il sangue uscire dalle mie membra lacerate dal ferro freddo della spada, per fermarmi il cuore e cancellarmi definitivamente dal mondo dei viventi. Il gladiatore, il mio avversario, mi aveva allungato invece la sua mano per aiutarmi a rialzarmi. Ed io, fortunata vittima di un crudo spettacolo per adulti, l’afferrai e mi lasciai sollevare da lei, respirando e ammirando nuovamente quanto fosse bella la luce del sole che risplende in un cielo azzurro e sgombero dalle nuvole. Non ci sarebbe stata pioggia quel giorno, meglio così.
«Io mi chiamo Cindy».
«Melanie».
«Melanie, è un bel nome. Posso chiamarti Mel?».
«Può. Mi chiami pure come meglio crede».
«Sei sicura che non ti dia fastidio?».
«No, non mi da fastidio, altrimenti glie lo direi».
«Io ho venticinque anni Mel!».
Non risposi. Non volevo ricordare quanti anni avessi in quel momento.
«Lo sai che cosa significa questo?».
«Non ne ho idea. Forse significa che lei è nata venticinque anni fa?».
«Acuta osservazione Mel! Ma quella è solo aritmetica, non ha nulla a che vedere con ciò che intendevo dire. Intendevo dire che sono giovane».
«Sono felice per lei Cindy, io invece sono più vecchia, ho trentacinque anni». Sobbalzai quando realizzai che inavvertitamente avevo esternato un particolare della mia vita che non avrei avuto alcuna intenzione di condividere con altri. Le avevo detto la mia età, consegnando nelle sue mani la scatola che conteneva la mia esistenza, anche la parte che avevo con tanta fatica cercato di dimenticare.
«Bene, siamo quasi coetanee allora».
«Beh, non direi. Abbiamo ben dieci anni di differenza».
«E che sarà mai! Facciamo parte della stessa generazione. Quella dei Beatles, Elvis, Jeans e camicette sbottonate, brillantina nei capelli e Cadillac! Hai sentito “A hard day’s night”, la nuova canzone dei Beatles?».
«Si, certo che l’ho sentita! Adoro i Beatles», confidai nuovamente sorpresa.
«Anche io li adoro! E poi loro sono ragazzi troppo belli. Mio Dio come me li farei!», affermò prima di mettersi a canticchiare il motivo con una buona intonazione.
«Mel, dammi del tu dai! Non ti mangio, stai tranquilla».
Rimasi ferma a pensare per troppo tempo, come se la scelta sul da farsi, se accettare o meno la sua proposta, fosse una questione di vita o di morte. Eppure sarebbe stata una cosa banale per una persona “normale”, una scelta da farsi d’istinto. L’istinto che guida gli animali e che io non avevo mai coltivato. Cindy mi guardò, in attesa di una mia risposta. Il mio silenzio e la mia reticenza l’avevano un po’ spiazzata.
«Va bene». Le sorrisi, quasi a volerla premiare per la sua attesa, in risposta alle mille domande che potevano averle affollato la mente in quegli istanti. Forse aspettavo proprio che mi chiedesse lei di farlo, scardinando la cassaforte nella quale mi ero rinchiusa da sola, ridonandomi l’ossigeno e, forse, qualche residuo sussulto di vita. Forse Cindy mi considerava al pari di una pazza, una persona con urgente bisogno di aiuto. E avrebbe avuto ragione.
«Dove vai?».
Domanda inopportuna e dalla difficile risposta per me. Tuttavia ormai ero già compromessa. Una confessione in più da parte mia non avrebbe di certo distorto la mia immagine più di quanto non lo fosse già. Non avrebbe di certo modificato il percorso del mio destino. Tuttavia mantenni un certo riserbo mentre le rispondevo.
«Vado a Cleveland».
«A Cleveland! Ma è fichissimo! Io sono di Cleveland, sto tornando a casa mia!».
Mi sentii come investita da uno schiacciasassi, da una di quelle macchine infernali usate per pressare l’asfalto sulle strade e che rendono il catrame liscio e sottile come una lastra di vetro. Ma questa volta il catrame nero sparso a terra e poi compresso ero io.
«Ah!». Fu l’unico suono che riuscii a produrre con le mie corde vocali impietrite.
«E dove alloggerai?».
Ecco, un nuovo squarcio si apriva nella voragine già sanguinante. Che cosa le avrei risposto? Che non avevo una meta precisa? Che in realtà non avevo una casa in cui stare ma me ne sarei andata a spasso per le strade come una barbona alla ricerca di un posto a basso costo per dormire? Ecco l’idea! Avrei potuto dirle che sarei rimasta a Cleveland solo per un breve periodo, che ero solo di passaggio! Così avrei avuto anche la scusa per cavarmi d’impiccio e scappar via da lei in qualunque momento, per riguadagnare la mia vita! La mia vita! Si, ma quale vita? Ne avevo davvero una?
«Starò in un hotel. Sono solo di passaggio, ci starò solo per qualche giorno», risposi, fiera di aver imboccato per la prima volta la strada giusta, di aver deciso da sola sul da farsi. Era una sensazione nuova per me, dannatamente potente, prodigiosa, una valanga di energia.
«Oh, capisco. Per pochi giorni. Bene, allora puoi venire a stare da me, a casa mia!».
«No, ci mancherebbe altro! Non voglio essere d’impiccio per nessuno io. Ringrazio per l’offerta ma mi dispiace, davvero non la posso accettare».
«Ma quale impiccio, Mel! Noi dell’Ohio siamo fatti così! Guai a rifiutare la nostra ospitalità».
«Noi del West Virginia invece siamo un po’ diversi».
«Dal West Virginia! Vieni da lì? Da quale città?».
La mia vita ormai era diventata di dominio pubblico. Persino l’anziano uomo aveva abbassato il suo giornale per vedere la faccia di quella fuggiasca che stava riempiendo l’aria di quello spazio angusto con le sue parole. Senza difese vomitai anche quello.
«Fico!».
«Ma cosa significa “fico”?».
«Significa “bello”, “forte”! Ma dove vivi scusa? Non hai mai sentito questa parola?».
Le mentii dicendole che l’avevo sentita ma che non l’avevo mai fatta rientrare nel mio dizionario, quindi mi ero disinteressata del suo vero significato. In realtà conoscevo benissimo il significato di quella parola usata per lo più dagli adolescenti, ciò che non capivo era che cosa ci trovasse lei di così “fico” nelle cose che le dicevo. Perché quella ragazza riusciva a trovare del bene o del bello in cose, paesi o situazioni che io avevo odiato da sempre? Cominciai a pensare che forse restare un po’ di tempo con lei mi avrebbe fatto bene. Forse avrei potuto imparare a vivere un po’, rubando lezioni di vita gratuite da una ragazza più giovane di me, come una parassita sociale. Forse lei davvero sapeva come si dovesse vivere nel mondo, in questo mondo del quale facevamo entrambe parte con le nostre innumerevoli diversità.
«E tu dove vivi?», le chiesi.
«Sulle sponde del lago Erie. E’ un posto molto bello, soprattutto la sera quando i rumori della città si attenuano e senti solo quelli provenienti dal lago. La mia casa guarda proprio sul lago e dal giardino si può godere di splendidi e coloratissimi tramonti. Ti piacerà, vedrai. E poi io vivo da sola, non ci sarà nessuno a disturbarci!», concluse con un sorriso malizioso che avevo visto fare a qualche quindicenne vittima dei suoi primi sussulti ormonali.
Le sorrisi e in quel modo le confermai che accettavo il suo invito. Mi sarei sdebitata in qualche modo, avrei diviso con lei le spese per il vitto e per l’alloggio, avrei lavorato e così via. In quel momento pensai che si sarebbe trattato solo di una breve permanenza presso di lei, nel frattempo avrei cercato un alloggio tutto mio e all’occorrenza avrei potuto incontrare la mia amica ogni volta che fosse stato necessario. La mia amica! Sembrava una cosa tanto strana da dire e quasi surreale da sentire. Ma mi sbagliavo, visto che in quella casa sul lago Erie ci passai buona parte della mia intera vita. In un solo giorno ero entrata in possesso di due cose tutte mie, un’amica e una vita. E tutto questo per merito o per colpa di Cindy, di quella sua sfacciata presenza che era riuscita ad abbattere tutte le mie barriere, ogni mio minimo residuo desiderio d’isolamento. Di una presenza ingombrante che ora mi dava sicurezza, come l’amore di una madre o l’abbraccio di una sorella che non avevo mai avuto. Del suo modo violento di entrare nella mia esistenza con le sue parole, con il suo sguardo, con tutta la sua energia e con la sua gomma da masticare. Le chiesi se aveva una gomma anche per me, lei me la offrì. Fu la prima volta che masticai una gomma nella mia vita, era al gusto di fragola.
4
Quando lasciai il mio lavoro di infermiera dopo otto anni di attività, i miei colleghi mi organizzarono una festa a sorpresa. Parteciparono anche i medici, a turno per non lasciare scoperto il servizio di assistenza ai malati ricoverati in ospedale. Durò all’incirca un’ora, sessanta minuti di frastuono e allegria che altri vivevano al posto mio. Mi avevano risvegliata da un letargo, mettendomi per la prima volta al centro di un cerchio, rendendo ancora più complicata la mia partenza. Negli anni avevo capito che quando gli altri ti organizzano una festa è perché tutto sommato provano un certo affetto per te. Loro la chiamano amicizia. Avevo quindi capito che l’amicizia è quel sentimento primitivo che si prova verso un’altra persona con la quale si condivide qualche cosa, una sorta di rapporto umano. Quindi forse avevo avuto qualche amicizia nella mia gioventù ma io ero troppo cruda per rendermene conto. O forse no, si trattava solo di un rapporto di convivenza, di reciproca accettazione e sopportazione che non andava oltre il semplice saluto o la condivisione di un’oretta di gioco. Se l’amico è colui che ti ascolta e che si prende cura di te, che condivide con te le gioie e le paure, allora questo mio amico era il mio pelouche, regalatomi dall’orco e che da quello stesso orco mi aveva difeso finché poté farlo. Mio padre, l’orco, mi aveva regalato la mia unica arma di difesa, perché io potessi difendermi da lui. Mi aveva donato un’amicizia fatta di stoffa e pelo sintetico, perché lui non sarebbe mai stato all’altezza di darmi qualcosa di più. E mio amico fu anche Ryan, il ragazzo dolce che era riuscito a farmi provare un brivido, anche se dal significato totalmente sconosciuto.
Tagliarono una torta decorata che riportava il mio nome e un augurio per il mio futuro scritto sopra con una filatura di cioccolato nero. Ma quale futuro? E soprattutto, il futuro di chi? Versarono bevande analcoliche in bicchieri di plastica, rumoreggiavano come pazzi ubriachi e scatenati alla sagra del pesce del paese. Per qualche istante la mia mente tornò alle notti del pianto, quando mio padre rientrava a casa e sfogava la sua ira sul corpo di mia madre, rassegnato e già pronto nel suo letto ad accettare ancora per una volta, non l’ultima, il suo destino. “Beato chi soffre, perché vedrà il regno dei cieli” sentiva dire nel sermone recitato in chiesa. E lei sorrideva nel sentire quelle parole, accettava la sua vita così come le era stata donata, rassicurata dal fatto che ogni pugno, schiaffo o calcio, ogni violenza ricevuta l’avrebbe avvicinata sempre di più alla porta di quel paradiso tanto bello descritto dagli uomini per loro stessi. In quel paradiso gli orchi non sarebbero mai entrati. Qualcuno si accorse di me, in quel frastuono notarono una lacrima furtiva scivolare via dalle mie palpebre incontinenti per scendere seguendo il profilo del mio volto. Mi dissero “E’ bello vederti commossa per la festa, sei sempre stata così dolce, ci mancherai tanto lo sai?”. Ancora una volta non ero stata capita, non mi conoscevano affatto, non condividevamo nulla. Quindi non potevamo considerarci “amici”. Quel sentimento così importante non aveva per noi alcuna valenza. L’ospedale era stato trasformato in un bordello, schiamazzi e grida mi fecero pensare che forse quella gente fosse piuttosto contenta per la mia partenza, della mia scelta di togliermi dai piedi di mia spontanea volontà. Ero un essere scomodo per tutti loro, troppo diverso e quindi anormale. C’era gente che formava il trenino intonando motivi per me privi di senso e di musicalità, ognuno con le braccia tese e le mani posate sulle spalle dell’altro che lo precedeva, il “capotreno” con un cono capovolto piazzato sopra la testa. Sembrava un gelato caduto a terra. Sorrisi senza un apparente motivo. Sul cono una mano sapiente aveva scritto in bella calligrafia le parole “Non ti dimenticheremo mai Melanie!”, io per un attimo vi credetti. Alla fine della festa, quando i pazzi tornarono a rinchiudersi nelle loro celle per scontare la convalescenza delle loro malattie, notai quel cono di cartone accartocciato e gettato nel cesto dell’immondizia. Riuscii a vedere solo il mio nome tra le pieghe, imbrattato da una macchia lasciata dal burro di arachidi. Sorrisi, piansi, non ricordo bene. Vi gettai sopra gli altri scarti della festa fino a coprire completamente anche il mio nome, eliminandone ogni traccia. Ammirai l’opera, sospirai soddisfatta, accartocciai il foglio con i nomi e i numeri di telefono che alcuni mi avevano lasciato dicendomi “mi raccomando, restiamo in contatto!”. Nella mia testa tutto ciò risuonava più come una minaccia che come un amichevole invito dettato da un reale interesse nei miei confronti. Lo gettai insieme al resto della carta straccia perché quello era il suo posto, con quello si completava. Richiuso il cesto, cominciai a dimenticare. Dimenticare, come tutti loro avrebbero fatto con me di lì a qualche ora. Ci saremmo rincontrati in paradiso se fosse realmente esistito, ammesso che l’inferno non mi avesse risucchiato prima del tempo. Così, giusto per il gusto di divertirsi ancora un po’ con me. Non incontrai mai più nessuno di loro in tutta la mia vita, non seppi mai chi fosse sopravvissuto a quella giornata, a quella fugace ora di euforia da catalogo. A parte una persona, Melanie. Anche l’inferno mi aveva rifiutata, nemmeno il diavolo si divertiva più a prendersi gioco di me.
Tornai a casa stanca quella sera. Avrei voluto fare i bagagli e partire quella notte stessa per un posto nuovo, così senza decidere, senza una meta precisa. Lo facevano tanti giovani, ormai era una cosa alla moda, quasi un obbligo per chi era riuscito a mettere qualche soldo da parte. Quindi avrei potuto farlo anche io. Ma rimandai la preparazione dei bagagli, rimandai quella partenza a momenti migliori. Posai il regalo che gli altri mi avevano dato prima di salutarci e augurarci “buona fortuna per il futuro”, frase che sapeva un po’ di rassegnazione e portava nascosta in sé una nota amara che diceva “tu da oggi non sei più affare nostro”. Mi regalarono un orologio. Regalarono un orologio anche a quelli che erano andati via prima di me, a quelli che si erano sposati, a quelli che avevano avuto dei figli. Perché si regala sempre un orologio? E’ davvero così importante ricordare ad una persona che il suo tempo è destinato a passare e alla fine lei scadrà come un cartoccio di latte abbandonato da tutti sul fondo di uno scaffale in un piccolo supermercato di provincia? Solo ai funerali non si regala un orologio al defunto, forse perché per lui il tempo non esiste più. Il tempo non è nulla paragonato all’eternità stessa che lo contiene. Aprii il pacchetto, guardai l’orologio, segnava già l’ora giusta. Qualcuno si era preoccupato di sistemarla perché fosse già pronto all’uso e io non fossi costretta a perdere tempo, appunto. Perdere del tempo per sistemare il tempo, che curioso paradosso! Posai la scatola richiusa sulla mensola del camino, da dove lo avrei ripreso prima di partire. Forse.
5
Cleveland era ormai vicina. Cindy si era appisolata durante l’ultimo tratto del viaggio. Eravamo rimaste noi due sole nel vagone, la osservavo con attenzione perché lei non poteva vedermi. La invidiavo perché la vedevo felice, sicura di sé, della sua esistenza. Una ragazza più giovane di me che aveva vissuto più di quanto non avessi saputo fare io, che aveva fatto delle scelte conscia di avere la sua vita stretta in pugno. La “sua” vita. Mi chiedevo per quale ragione avessi parlato con lei, rispondendo alle sue domande e ponendomene a mia volta delle altre su di lei. Non trovavo una risposta a questa domanda. Non mi conoscevo abbastanza, evidentemente. Sudavo, nonostante i turbini di aria fresca che riempiva il nostro vagone e che penetrava fino in fondo alle ossa. Lei se ne stava lì tranquilla, beatamente cullata dai suoi sogni. Poi il treno cominciò a rallentare, accompagnato dallo stridio fastidioso prodotto dalle ruote e dai freni, quello che anticipa l’arrivo nella stazione. Cindy si svegliò e stirò le braccia come facevo anche io ogni mattino da bambina nei primi secondi che seguivano il risveglio, quando ancora le paure della notte non erano ricomparse nella mia testa per ricordarmi quale fosse la mia realtà. Mi sorrise.
«Sono crollata come una pera, scusami!».
Ricambiai il suo sorriso con il mio. Ero sincera e meravigliata di esserlo al tempo stesso.
«Ti sei riposata un po’», confermai. Lei annuì.
«Tu che cosa hai fatto?».
«Ho guardato fuori dal finestrino».
«Per tutto il tempo? Quanto ho dormito?».
Guardai l’orologio.
«Quasi due ore».
«Però! Niente male!».
Non capivo a cosa si riferisse. Cosa non era “male”? Il fatto di aver dormito per quasi due ore sopra un ammasso di ferraglia in movimento in mezzo alla campagna dell’Ohio? La guardai aggrottando la fronte.
«Il tuo orologio! Niente male!».
«Ah, grazie. E’ un regalo».
«Del tuo uomo?».
Abbassai lo sguardo. Quella ragazza stava lentamente dissotterrando tutti i cadaveri che io con pazienza e dedizione avevo a fatica ricoperto di terra e dimenticato. Risposi, a metà.
«Non ho un uomo, sono sola. E’ un regalo dei miei ex colleghi dell’ospedale, me lo hanno dato il giorno in cui ho lasciato il lavoro, durante la festa di addio».
Lei mi guardò, squadrandomi dalla testa ai piedi. Mi stava osservando, mi sentivo studiata nei dettagli, come una cavia da laboratorio alla quale fosse stato iniettato un virus letale e si fosse voluto misurare il tempo necessario per vederla morire. Improvvisamente mi parve disinteressata al mio orologio, ora era concentrata su di me, sul mio aspetto, sulla mia infelicità così come lei la percepiva in quel momento. Forse stava pensando di “sacrificarsi” per me, di prendere in mano le redini della mia vita per condurla da qualche parte. La “mia” vita, ancora una volta. Alzai le mie barriere o quel poco che ne restava, non volevo tornare a soffrire. Ero ormai esperta e riconoscevo i sintomi che anticipano l’arrivo della sofferenza con assoluta sicurezza. In quanto a sofferenza ero davvero infallibile, una sulla quale si poteva davvero contare. Decisi che il nostro sarebbe stato solo un incontro per un viaggio. Non sarei andata da lei, a casa sua. O forse anche si, per poche ore, pochi giorni, pochi anni o forse per sempre.
Il treno si fermò e una voce registrata diffusa nelle carrozze annunciò che eravamo arrivati. Cindy si alzò, si aggiustò per bene la camicia nei pantaloni. Era stranamente in ordine nonostante le tante ore che aveva passato seduta sulla sua poltrona. Sentii il suo profumo. Era fresco, come appena messo. In quel momento notai le due grandi valige che aveva portato con sé in quel viaggio, mi meravigliai di come avesse potuto trasportarle da sola, senza l’aiuto di nessuno. Mi alzai e sentii che il mio corpo rilasciava invece un cattivo odore di sudore. Mi vergognai al punto che decisi di sedermi nuovamente. Avrei aspettato che lei fosse uscita dal vagone per rialzarmi senza timore di battezzare l’aria con la mia fragranza di fogna. Ma lei non badò affatto a me. Forse aveva capito il mio problema, o forse no. Non lo seppi mai.
«Io vado avanti, ci vediamo qua fuori», mi disse con un sorriso.
«Va bene, prendo la mia valigia e ti raggiungo subito».
Lei mi guardò mentre allungavo le braccia verso lo scomparto posto in alto, sopra la mia testa. Non si mosse.
«Tutto qui? Questo è tutto il tuo bagaglio?».
«Si. Ho portato poche cose. Il resto l’ho lasciato a casa, non mi servirà molto qui». Lei mostrò il lato perplesso della sua espressione.
«Se lo dici tu Mel! Dai forza, andiamo prima che il cavallo decida di ripartire con gli asini sopra!».
«Scusa?».
«Nulla, è un modo di dire locale! Noi saremmo gli asini, tutto qui!».
Scoppiò a ridere, era evidentemente felice di essere ritornata a casa, la sua casa, per ricondurre la vita, la sua vita. E per trascinarsi dietro anche i resti sgualciti della mia esistenza. Camminava davanti a me e io la seguivo, come un cane legato ad un invisibile guinzaglio segue il suo padrone. Ammiravo quanto fosse bello il suo corpo di giovane venticinquenne, ne invidiavo il fisico che sembrava essere stato creato dalle mani sapienti di uno scultore. Il suo seno era generoso, il sedere sodo, le belle gambe lunghe e dritte accomodavano perfettamente i suoi jeans stretti. Toccai per un attimo i miei fianchi e la mia fantasia subito svanì. Rimase solo l’invidia a tenermi per mano, ancora una volta, e non l’ultima.
Durante gli anni trascorsi al college riuscii nonostante tutto a prendermi delle piccole soddisfazioni personali. Ero una studentessa modello, una di quelle ragazze sempre in ordine, con il colletto della divisa pulito e ben stirato, preparata, sempre al passo con le lezioni e i compiti ben fatti. Oltre a tutto ciò io non comunicavo. Per mia scelta, ma anche per necessità, non entrai mai a far parte di uno dei tanti branchi che popolavano il campus. E per questo motivo, credo, venni invidiata e additata come una ruffiana dalla maggior parte delle mie compagne, una di quelle che dietro una faccia d’angelo nasconde tanti interessi personali e secondi fine. Alcune di queste voci si fecero sempre più insistenti nel tempo e una di queste, forse la più infamante per una donna di quell’epoca, arrivò all’orecchio del rettore. Lui conosceva bene il mio percorso di studi, i miei successi scolastici e il mio comportamento, sia in istituto che fuori. Ma soprattutto conosceva bene mio padre e il suo carattere. Avevano combattuto insieme, anche lui ricordava la scena straziante di mio padre che teneva l’amico e compagno di battaglia morente tra le sue braccia, cercando di trattenere le lacrime, la disperazione e la paura. Ma quell’uomo una volta ritornato a casa dai suoi cari era riuscito a dimenticare tutto, aveva intrapreso una brillante carriera accademica per poi diventare il rettore di quello stesso istituto. Forse proprio per questo motivo si preoccupò di tenermi sotto la sua ala protettrice, difendendomi da tutto e da tutti. Ma per la carica che copriva nell’istituto non poteva darlo a vedere pubblicamente. Un giorno mi chiamò nel suo ufficio con la banale scusa di chiedermi quali intenzioni avessi per il mio futuro e per propormi un’attività di ricerca da svolgere in istituto al completamento dei miei studi. Mi parlò delle brutte voci che aveva sentito sul mio conto e che le erano state riferite da una inserviente, a detta sua.
«Melanie, girano strane voci qui dentro che tendono a metterti in cattiva luce. Volevo chiederti se ne sei al corrente e cosa ne pensi. Io ti conosco piuttosto bene e so chi sei e come ti comporti. Queste voci però devono essere messe a tacere e in fretta, prima che sia troppo tardi».
Ero perfettamente a conoscenza di quelle voci, una delle tante capobranco me le aveva praticamente sbattute in faccia una volta, dandomi della “puttana” in seguito ad un piccolo battibecco che avevamo avuto. Ma decisi di non ammettere nulla perché volevo rimanere al di fuori di tutto. Credevo di essere molto abile nel nascondere la verità, sicura del fatto che nessuno mai avrebbe scoperto le mie menzogne. O meglio, le mie “non verità”. Non avrei accettavo l’aiuto di nessuno, soprattutto se offertomi da un amico di mio padre o da chiunque altro avesse condiviso anche la minima cosa con lui. Scossi il capo ammettendo la mia ignoranza.
«Si dice in giro che sei stata vista mentre praticavi prestazioni poco convenienti per una ragazza nubile della tua età ad uno dei ragazzi del nostro servizio di sicurezza».
«Pura fantasia di qualche sgualdrina da quatto soldi».