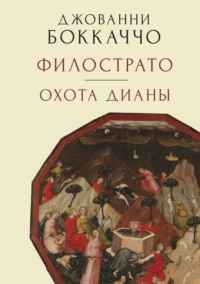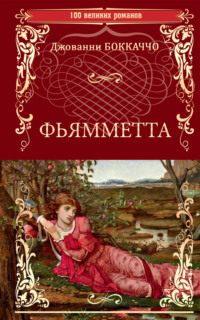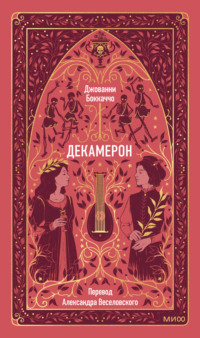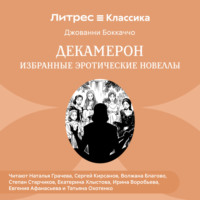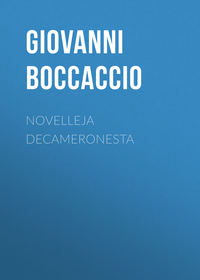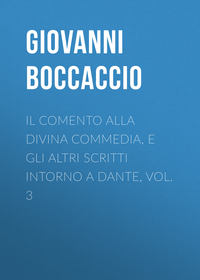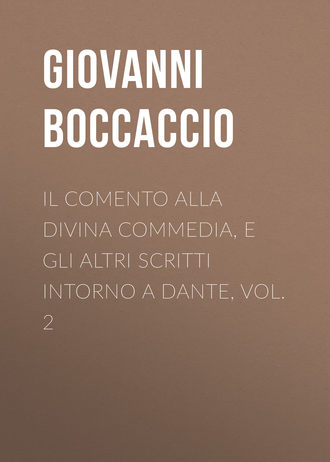
Полная версия
Il Comento alla Divina Commedia, e gli altri scritti intorno a Dante, vol. 2
«Dallʼaltra parte», forse a rincontro aʼ nominati, «vidi il re Latino». Latino fu re deʼ laurenti e figliuolo di Fauno re, deʼ discendenti di Saturno, e dʼuna ninfa laurente, chiamata Marica, sí come Virgilio nellʼEneida dice:
…Rex arva Latinus et urbesiam senior longa placidas in pace regebat.Hunc Fauno et nympha genitum laurente Maricaaccepimus.Ma Giustino non dice cosí, anzi dice che egli fu nepote di Fauno, cioè figliuolo della figliuola, in questa forma: che, tornando Ercule di Spagna, avendo vinto Gerione, e pervenendo nella contrada di Fauno, egli giacque con la figliuola, e di quello congiugnimento nacque Latino. E cosí non di Fauno, ma dʼErcule sarebbe Latino stato figliuolo. Ma Servio Sopra Virgilio dice che, secondo Esiodo, in quello libro il quale egli compose chiamato Aspidopia, che Latino fu figliuolo dʼUlisse e di Circe, la quale alcuni chiamaron Marica; e però dice il detto Servio, Virgilio aver detto di lui, cioè di Latino, «Solis avi specimen», percioché Circe fu figliuola del Sole. Ma dice il detto Servio (percioché la ragione deʼ tempi non procede, percioché Latino era giá vecchio, quando Ulisse ebbe la dimestichezza di Circe) essere da prendere quello che Iginio dice, cioè essere stati piú Latini. Oltre a questo, cosí come del padre di Latino sono opinioni varie, cosí similmente sono gli antichi scrittori discordanti della madre: percioché Servio dice Marica essere dea del lito deʼ minturnesi, allato al fiume chiamato Liri: laonde Orazio dice:
…et innantem Maricaelittoribus tenuisse Lirim;e però, se noi vorrem dire Marica essere stata moglie di Fauno, non procederá; percioché glʼiddii locali, secondo lʼerronea opinion degli antichi, non trapassano ad altre regioni. Alcuni dicono Marica esser Venere, percioché ella ebbe un tempio allato alla Marica, nel quale era scritto «Pontina Venere»; ma di costei anche si può dire quello che di sopra dicemmo di Latino, potere essere state piú Mariche. Ma di cui che egli si fosse figliuolo, egli fu re deʼ laurenti, neʼ tempi che Troia fu disfatta, ed ebbe per moglie Amata, sirocchia di Dauno, re dʼArdea e zia di Turno, sí come per Virgilio appare. Ma Varrone, in quel libro il quale egli scrive De origine linguae latinae, dice che Pallanzia, figliuola dʼEvandro re, fu sua moglie. Costui, secondo che vogliono alcuni, ricevette Enea fuggito da Troia, ed avendo avuto un responso da quegli loro iddii, che egli ad un forestiere, del quale dovea mirabile succession nascere, désse Lavina sua figliuola per moglie; avendola giá promessa a Turno, la diede ad Enea: di che gran guerra nacque, nella quale, secondo che dice Servio, questo Latino morí quasi nella prima battaglia.
«Che con Lavina, sua figlia, sedea». Lavina, come detto è, fu figliuola di Latino e dʼAmata e moglie dʼEnea, del quale ella rimase gravida; e temendo la superbia di Ascanio figliuolo di Enea, il quale era rimaso vincitore della guerra di Turno, si fuggí in una selva; e appo un pastore, secondo che dice Servio, chiamato Tiro, dimorò nascosamente: e partorí al tempo debito un figliuolo, il quale nominò Giulio Silvio Postumo, percioché nato era, dopo la morte del padre, nella selva. Ma poi fu costei da Ascanio rivocata nel suo regno, avendo egli giá fatta la cittá di Alba ed in quella andatosene. La quale non essendo dalle cose avverse rotta, tanto reale animo servò nel petto femminile, che senza alcuna diminuzione guardò il regno al figliuolo, tanto che egli fu in etá da sapere e da potere regnare. Ma Eusebio in libro Temporum dice che costei dopo la morte dʼEnea si rimaritò ad uno il quale ebbe nome Melampo, e di lui concepette un figliuolo, il quale fu chiamato Latino Silvio: né piú di lei mi ricorda aver trovato.
«Vidi quel Bruto, che cacciò Tarquino». Bruto fu per legnaggio nobile uomo di Roma, percioché egli fu dʼuna famiglia chiamata i Giuni, ed il suo nome fu Caio Giunio Bruto, e la madre di lui fu sorella di Tarquino Superbo, re deʼ romani. E percioché egli vedeva Tarquino incrudelire contro aʼ congiunti, temendo di sé, avendo sana mente, si mostrò pazzo: e cosí visse buona pezza, portando vilissimi vestimenti, e ingegnandosi di fare alcune cose piacevoli, come talvolta fanno i matti, accioché facesse ridere altrui, ed ancora per acquistare la benivolenza di chi il vedesse, e con questo fuggisse la crudeltá del zio. E percioché poco nettamente vivea, fu cognominato Bruto: il quale, per aver festa di lui, tenevano volentieri appresso di sé i figliuoli di Tarquino. Ora avvenne che, essendo Tarquino Superbo intorno ad Ardea ad assedio, e i figliuoli del re con altri lor compagni avendo cenato, entrarono in ragionamento delle lor mogli, e ciascuno, come far si suole, in virtú e in costumi preponeva la sua a tutte lʼaltre femmine; e, non finendosi la quistione per parole, presero per partito dʼandarne alle lor case con questi patti: che quale delle lor donne trovassero in piú laudevole esercizio, quella fosse meritamente da commendar piú che alcunʼaltra; e cosí, montati a cavallo, subitamente fecero. E pervenuti a Roma, trovarono le nuore del re ballare e far festa con le lor vicine, non ostante che i lor mariti fossero in fatti dʼarme e a campo; e di quindi nʼandarono a un castello chiamato Collazio, dove un giovane chiamato Collatino, loro zio, teneva la donna sua, chiamata Lucrezia, e trovarono costei in mezzo delle sue femmine vegghiare, e con loro insieme filare e far quello che a buona donna e valente sʼapparteneva di fare: per che fu reputato che costei fosse piú da lodare che alcuna dellʼaltre e che Collatino avesse miglior moglie che alcun degli altri. Era tra questi giovani Sesto Tarquino, giovane scellerato e lascivo, il quale, veduta Lucrezia e seco medesimo commendatala molto, entratagli nellʼanima la bellezza e lʼonestá di lei, seco medesimo dispuose di voler del tutto giacer con lei: e dopo alquanti dí, senza farne sentire alcuna cosa ad alcuno, preso tempo, solo ritornò a Collazio, dove da lei parentevolmente ricevuto ed onorato, considerato la condizione della casa, la notte, come silenzio sentí per tutto, estimando che tutti dormissero, levatosi, col coltello ignudo in mano, tacitamente nʼandò lá dove Lucrezia dormiva, e postale la mano in sul petto, disse: – Io sono Sesto, e tengo in mano il coltello ignudo; se tu farai motto alcuno, pensa chʼio tʼucciderò di presente. – Ma per questo non tacendo Lucrezia, la quale in guisa alcuna al suo desiderio acconsentir non voleva, le disse: – Se tu non farai il piacer mio, io tʼucciderò, e appresso di te ucciderò uno deʼ tuoi servi, e a tutti dirò che io tʼabbia uccisa, percioché col tuo servo in adulterio tʼabbia trovata. – Queste parole spaventarono la donna, seco pensando che, se in tal guisa uccisa fosse trovata, leggermente creduto sarebbe lei essere stata adultera, né sarebbe chi la sua innocenza difendesse: e però, quantunque malvolentieri si consentisse a Sesto, nondimeno, avendo pensato come cotal peccato purgherebbe, gli si consentí.
Sesto, quando tempo gli parve, se ne tornò ad Ardea; ed essa piena di dolore e dʼamaritudine, come il giorno apparí, si fece chiamare Lucrezio Tricipitino, suo padre, e Collatino, suo marito, e Bruto: li quali essendo venuti, e trovandola cosí dolorosa nellʼaspetto, la domandò Collatino: – Che è questo, Lucrezia? non sono assai salve le cose nostre? – A cui Lucrezia rispose: – Che salvezza può esser nella donna, la cui pudicizia è violata? nel tuo letto è orma dʼaltro uomo che di te. – E quinci aperse distesamente ciò che per Sesto Tarquino era stato la passata notte adoperato. Il che udendo Collatino e gli altri, quantunque dellʼaccidente forte turbati fossero, nondimeno la cominciarono a confortare, dicendo la pudicizia non potere esser contaminata, dove la mente a ciò non avesse consentito. Ma Lucrezia, ferma nel suo proposito, trattosi di sotto aʼ vestimenti un coltello, disse: – Questa colpa, in quanto a me appartiene, non trapasserá impunita; né alcuna mai sará, che per esempio di Lucrezia diventi impudica. – E detto questo, e posto il petto sopra la punta del coltello, su vi si lasciò cadere, e cosí senza poter essere atata, entratole il coltello nel petto, si morí. Tricipitino e Bruto e Collatino, vedendo questo, non potendo piú nascondere lʼindegnitá del fatto, ne portarono il corpo morto nella piazza, predicando lʼiniquitá di Sesto Tarquino, e di molte ingiurie accusando il re eʼ figliuoli. Il pianto fu grande, e il rammarichio per tutto: ma Bruto, estimando che tempo fosse a por giuso la simulata pazzia, tratto il coltello del petto alla morta Lucrezia, con una gran brigata deʼ collazi nʼandò a Roma, lasciando che lʼun deʼ due rimasi andassero nel campo a nunziare questa iniquitá: e in Roma pervenuto, per dovunque egli andava, piangendo e dolendosi, convocava la moltitudine a compassione dellʼinnocente donna e ad odio deʼ Tarquini. Per la qual cosa furono incontanente le porte di Roma serrate, e per tutto gridata la morte e il disfacimento del re e deʼ figliuoli: e il simile era avvenuto nel campo ad Ardea. E come fu sentita la scellerata operazione di Sesto Tarquino, e tutti, lasciato il re eʼ figliuoli, a Roma venutisene, e ricevuti dentro, in una medesima volontá con gli altri divenuti, al re Tarquino, che minacciando tornava da Ardea, del tutto negarono il ritornare in Roma: e subitamente in luogo del re fecero due consoli, appo i quali fosse la dignitá e la signoria del re, sí veramente che piú dʼuno anno durar non dovesse: e di questi due primi consoli fu lʼuno Bruto e lʼaltro Collatino. E, sentendo, in processo di tempo, Bruto due suoi figliuoli tenere alcun trattato di dovere rimettere il re eʼ figliuoli suoi a Roma, fattigli spogliare e legare ad un palo, prima agramente batter gli fece con verghe di ferro, e poi in sua presenza ferire con la scure e cosí morire. Cotanto adunque mostrò essergli cara la libertá racquistata. Ma poi, avendo Tarquino invano tentato di ritornare per trattato in Roma, ragunata da una parte e dʼaltra gente dʼarme, ad assediare Roma venne. Incontro al quale uscirono col popolo di Roma armati i consoli; ed essendosi traʼ due eserciti cominciata la battaglia, avvenne che Arruns, lʼuno deʼ figliuoli di Tarquino, combattendo, vide Bruto; per che, lasciata la battaglia degli altri, gridò: – Questi è colui che mʼha del regno cacciato; – e drizzato il cavallo e la lancia verso lui, e punto degli sproni il cavallo, quanto correr potea piú forte nʼandò verso lui. Il quale veggendo Bruto venire, e conosciutolo, non schifò punto il colpo, ma verso lui dirizzatosi con la lancia e col cavallo, avvenne che con tanto odio delle punte delle lance si ferirono, che amenduni morti caddero del cavallo. E poi, avendo i romani avuta vittoria deʼ nemici, con grandissimo pianto ne recarono in Roma il corpo di Bruto, lá dove egli da tutte le donne di Roma, sí come padre e ricuperatore della loro libertá e vendicatore e guidatore della loro pudicizia, fu amarissimamente pianto, e poi, secondo lʼuso di queʼ tempi, onorevolmente fu seppellito.
«Lucrezia». Di questa donna è narrata la storia.
«Marzia». Marzia non so di che famiglia romana si fosse, né alcune storie sono, le quali io abbia vedute, che guari menzione faccian di lei. Par nondimeno, per antica fama, tenersi lei essere stata onesta e venerabile donna; e per tutti si tiene, e Lucano ancora il testimonia, lei essere stata moglie, non una sola volta, ma due, di Catone uticense. Il quale avendola la prima volta menata a casa, generò in lei tre figliuoli; poi, dispostosi del tutto di volere nel futuro servar vita celibe e fuggire ogni congiugnimento di femmina, secondo che alcuni dicono, glielo disse; ed, oltre a ciò, immaginando non dovere per lʼetá essere a lei questa astinenza possibile, la licenziò di potersi maritare, se a grado le fosse, ad un altro uomo. Per la qual cosa essa si rimaritò ad Ortensio (a quale non so, percioché piú ne furono), e di lui concepette alcuni figliuoli. Poi, essendosi morto Ortensio, e sopravvenuto il tempo delle guerre cittadine tra Cesare e Pompeo, una mattina in su lʼaurora picchiò allʼuscio di Catone, e, entrata da lui, il pregò che gli piacesse di doverla ritôrre per moglie; che di questo matrimonio essa non intendeva di volerne altro che solamente il nome dʼesser moglie di Catone, e sotto lʼombra di questo titolo vivere, e, quando alla morte venisse, morire moglie di Catone. Alli cui prieghi Catone condiscese; e, con quella condizione ritoltala, senza alcuna altra solennitá osservare, e mentre visse servando il suo proponimento, per sua moglie la tenne, ed ella lui per suo marito.
«Giulia». Giulia fu figliuola di Giulio Cesare, acquistata in Cornelia figliuola di Cinna, giá quattro volte stato consolo; la quale, lasciata Consuzia che davanti sposata avea, prese per moglie. E fu costei moglie di Pompeo Magno, il quale ella amò mirabilmente, intanto che, essendo delle comizie edilizie riportati a casa i vestimenti di Pompeo, suo marito, rispersi di sangue (il che, secondo che alcuni scrivono, era avvenuto, che sacrificando egli, ed essendogli lʼanimale, che sacrificar dovea, giá ferito, delle mani scappato, e cosí del suo sangue macchiatolo); come prima Giulia gli vide, temendo non alcuna violenza fosse a Pompeo stata fatta, subitamente cadde, e da grave dolore fu costretta, essendo gravida, di gittar fuori il figliuolo che nel ventre avea, e quindi morirsi.
«E Corniglia». Il vero nome di costei fu Cornelia: ma, sforzato lʼautore dalla consonanza dei futuri versi, alcune lettere permutate, la nomina «Corniglia». Cornelia fu nobile donna di Roma della famiglia deʼ Corneli, del lato degli Scipioni: e fu figliuola di quello Scipione, il quale con Giuba, re deʼ numidi, seguendo le parti di Pompeo, fu da Cesare sconfitto in Numidia. E fu costei primieramente moglie di Lucio Crasso, il quale fu ucciso daʼ parti e a cui fu lʼoro fondato messo giú per la gola; e poi, come Lucio morí, divenne moglie di Pompeo magno: il quale ella, come valente donna dee fare, non solamente amò nella sua felicitá, ma, veggendo che la fortuna con le guerre cittadine forte il suo stato dicrollava, non dubitò di volere essergli, come nella grandezza sua era stata, neʼ pericoli e negli affanni delle guerre compagna: e ultimamente, secondo che Lucano manifesta, con lui dellʼisola di Lesbo partitasi, nʼandò in Egitto, dove miserabilmente agli assassini di Tolomeo, discendendo in terra, il vide uccidere. Quello che poi di lei si fosse, non so; ma dʼintera fede e di laudabile amore puote debitamente essere pregiata.
«E solo in parte vidi ʼl Saladino». Il Saladino fu soldano di Babillonia, uomo di nazione assai umile per quello mi paia avere piú addietro sentito, ma di grande e altissimo animo e ammaestratissimo in fatti di guerra, sí come in piú sue operazioni dimostrò. Fu vago di vedere e di cognoscere li gran principi del mondo e di sapere i lor costumi: né in ciò fu contento solamente alle relazioni degli uomini, ma credesi che, trasformatosi, gran parte del mondo personalmente cercasse, e massimamente intraʼ cristiani, li quali, per la Terra santa da lui occupata, gli erano capitali nemici. E fu per setta deʼ seguaci di Macometto, quantunque, per quello che alcuni voglion dire, poco le sue leggi e i suoi comandamenti prezzasse. Fu in donare magnifico, e delle sue magnificenze se ne raccontano assai. Fu pietoso signore e maravigliosamente amò e onorò i valenti uomini. E, percioché egli non fu gentile, come quegli li quali nominati sono e che appresso si nomineranno, estimo che «in parte» starsi «solo» il discriva lʼautore.
«Poi chʼio alzai un poco piú le ciglia», cioè gli occhi per vedere piú avanti, «Vidi il maestro», cioè Aristotile, «di color che sanno, Seder», cioè usare e stare, e quegli atti fare che a filosofo appartengono, ammaestrare, operare e disputare, «tra filosofica famiglia».
Aristotile fu di Macedonia, figliuolo di Nicomaco, medico dʼAminta, re di Macedonia, e poi di Filippo, suo figliuolo e padre dʼAlessandro; la madre del quale fu chiamata Efestide: li quali Nicomaco ed Efestide vogliono alcuni esser discesi di Macaone e dʼAsclepiade, discendenti dʼEsculapio, il quale gli antichi, percioché grandissimo medico fu, dicono essere stato figliuolo dʼApollo, iddio della medicina. E dicono alcuni lui essere stato dʼuna cittá chiamata Stagira, la quale, se io ho bene a memoria, ho giá letto o udito che è non in Macedonia, ma in Trazia: le quali due province è vero che insieme confinano, per che, essendo in su i confini la cittá, forse agevolmente sʼè potuto errare a dinominarla piú dellʼuna provincia che dellʼaltra. Fu costui primieramente, dopo lʼavere apprese le liberali arti, ammaestrato neʼ libri poetici. E credesi che il primo libro, che da lui fu composto, fosse uno scritto, ovvero comento, sopra li due maggior libri dʼOmero, e che, per questo, ancora giovanetto fosse dato da Filippo per maestro ad Alessandro. Poi vogliono lui essere andato ad Atene ad udire filosofia, dove udí tre anni sotto Socrate, in queʼ tempi famosissimo filosofo; e, lui morto, sʼaccostò a Platone, il quale le scuole di Socrate ritenne, e sotto lui udí nel torno di venti anni. Per che, sí per lʼeccellenza del dottore, e sí ancora per lo perseverato studio con vigilanza, divenne maraviglioso filosofo; intanto che, andando alcuna volta Platone alla sua casa e non trovando lui, con alta voce alcuna volta disse: – Lʼintelletto non cʼè, sordo è lʼauditorio. – Visse appresso la morte di Platone, suo maestro, anni ventitré, deʼ quali parte ammaestrò Alessandro, e parte con lui circuí Asia, e parte di quegli scrisse e compose molti libri. Egli la dialettica, ancora non conosciuta pienamente prima, in altissimo colmo recò, e ad istruzione di quella scrisse piú volumi. Scrisse similmente in rettorica, né meno in quella apparve facondo, che fosse alcun altro rettorico, quantunque famoso stato davanti a lui. Similmente intorno agli atti morali, ciò che veder se ne puote per uomo, scrisse in tre volumi: Etica, Politica ed Iconomica; né delle cose naturali alcuna ne lasciò indiscussa, sí come in molti suoi libri appare; ed, oltre a ciò, trapassò a quelle che sono sopra natura, con profondissimo intendimento, sí come nella sua Metafisica appare. E, brevemente, egli fu il principio e ʼl fondamento di quella setta di filosofi, i quali si chiamano peripatetici. E non è vero quello che alcuni si sforzano dʼapporgli, cioè che egli facesse ardere i libri di Platone: la qual cosa credo, volendo, non avrebbe potuta fare, in tanto pregio e grazia degli ateniesi fu Platone e la sua memoria e li suoi libri. Li quali non ha molto tempo che io vidi, o tutti o la maggior parte, o almeno i piú notabili, scritti in lettera e grammatica greca in un grandissimo volume, appresso il mio venerabile maestro messer Francesco Petrarca. È il vero che la scienza di questo famosissimo poeta filosofo lungo tempo sotto il velamento dʼuna nuvola dʼinvidia di fortuna stette nascosa, in maraviglioso prezzo continuandosi appo i valenti uomini la scienza di Platone; né è assai certo, se a venire ancora fosse Averrois, se ella sotto quella medesima si dimorasse. Costui adunque, se vero è quello che io ho talvolta udito, fu colui che prima, rotta la nuvola, fece apparir la sua luce e venirla in pregio; intanto che, oggi, quasi altra filosofia che la sua non è daglʼintendenti seguita. Ma ultimamente pervenuto questo singulare uomo allʼetá di sessantatré anni, finío la vita sua; e, secondo che alcuni dicono, per infermitá di stomaco. «Tutti lo miran», per singular maraviglia, quegli che in quel luogo erano; e similmente credo facciano tutti quegli che aʼ nostri dí in filosofia studiano: «tutti onor gli fanno», sí come a maestro e maggior di tutti.
«Quivi vidʼio», appresso dʼAristotile, «Socrate».
Socrate originalmente si crede fosse ateniese, ma di bassissima condizione di parenti disceso, percioché, sí come scrive Valerio Massimo nel terzo suo libro sotto la rubrica De patientia, il padre suo fu chiamato Sofronisco intagliator di marmi, e la sua madre ebbe nome Fenarete, il cui uficio era aiutare le donne neʼ parti loro, e quelle per prezzo servire; ed esso medesimo, secondo che dice Papia, alquanto tempo sʼesercitò nellʼarte del padre. Poi, lasciata lʼarte paterna, divenne discepolo dʼuna femmina chiamata Diutima, secondo che si legge nel libro De vitis philosophorum; ma santo Agostino, nel libro ottavo De civitate Dei, scrive che egli fu uditore dʼArchelao, il quale era stato auditore di Anassagora. E, poiché alquanto tempo ebbe udito sotto Archelao, per divenire pienamente esperto deglʼintrinseci effetti della natura, in piú parti del mondo gli ammaestramenti deʼ piú savi andò cercando, secondo che scrive Tullio nel libro secondo delle Quistioni tusculane: e in tanta sublimitá di scienza pervenne, che egli, secondo che scrive Valerio, fu reputato quasi un terrestre oracolo dellʼumana sapienza. E secondo che mostra di tenere Apulegio, e similmente Calcidio Sopra il primo libro del Timeo di Platone, e come Agostino nel libro ottavo della Cittá di Dio, egli ebbe seco infino dalla sua puerizia un dimonio, il quale Apulegio predetto chiama «iddio di Socrate» in un libro che di ciò compose: il quale molte cose glʼinsegnò e in ciò che egli aveva a fare lʼammaestrò. Ma chi che di ciò gli fosse il dimostratore, egli fu non solamente dagli uomini, ma eziandio da Apolline, il quale gli antichi neʼ loro errori credettero essere iddio della sapienza, giudicato sapientissimo. Della qual cosa non è molto da maravigliarsi, conciosiacosaché egli fosse nelli studi della filosofia assiduo; e tanto nelle meditazioni perseverante, che Aulo Gellio scrive, nel libro secondo Noctium Atticarum, lui essere usato di stare dal cominciamento dʼun dí infino al principio del seguente, in piede, senza mutarsi poco o molto col corpo, e senza volgere gli occhi o ʼl viso dal luogo al quale nel principio della meditazione gli poneva.
Fu costui di maravigliosa e laudevole umiltá, percioché, quantunque in iscienza continuamente divenisse maggiore, tanto minore nel suo parlare si faceva; e da lui, secondo che Girolamo scrive nella sua trentacinquesima pistola, e, oltre a ciò, nel proemio della Bibbia, nacque quel proverbio, il quale poi per molti sʼè detto, cioè «hoc scio, quod nescio». E, oltre a questo, essendo tanto e sí venerabile filosofo, non solamente in parole, ma in opera la sua umiltá dimostrò. Esso, tra lʼaltre volte, secondo che negli studi è usanza, facendo la colletta dagli uditori suoi, ed essi tutti dandogli volentieri non solamente il debito, secondo lʼuso, ma ancora piú; Eschilo, poverissimo giovane ma dʼalto ingegno, lasciò andar ognʼuomo a pagar questo debito, e non andandone piú alcuno, esso, levatosi, andò alla cattedra di Socrate e disse: – Maestro, io non ho al mondo cosa alcuna che ti dare per questo debito, se non me medesimo, e io me ti do; e ricordoti che io ti do piú che dato non tʼha alcun altro che qui sia; percioché non ce nʼè alcuno che tanto donato tʼabbia, che alcuna cosa rimasa non gli sia, ma a me, che me tʼho dato, cosa alcuna non è rimasa. – Al quale Socrate umilmente rispose: – Eschilo, il tuo dono mʼè molto piú caro che alcuno altro che da costoro mi sia stato dato, e la ragione è questa: io non ho alcuna cosa la quale io possa assai degna donare a costoro che a me hanno donato, ma io ho da potere rendere a te guiderdone del dono che fatto mʼhai, e quello sono io medesimo; e cosí io me ti do; e perciò quanto tu vuogli che io abbia te per mio, tanto faʼ che tu abbi me per tuo. – Fu di sua natura pazientissimo, e con egual animo portò le cose liete e le avverse, intanto che molti voglion dire non essergli stato mai veduto piú che un viso. Il che maravigliosamente mostrò vivendo, e sostenendo i fieri costumi dellʼuna delle due mogli che avea, chiamata Santippe: la quale, senza interporre, il dí e la notte egualmente, con perturbazioni e con romori era da lei stimolato; la qual tanto piú nella sua ira sʼaccendeva, quanto lui piú paziente vedeva. Ed essendo alcuna volta stato addomandato da Alcibiade, nobilissimo giovane dʼAtene, secondo che scrive Aula Gellio in libro undecimo Noctium Atticarum, perché egli non la mandava via, conciofossecosaché per la legge lecito gli fosse, rispose che per la continuazione dellʼingiurie dimestiche fattegli da Santippe egli aveva apparato a sofferire con non turbato animo le disoneste cose, le quali egli vedeva e udiva di fuori. Oltre a questo, tenendosi Santippe ingiuriata da lui, un dí, preso luogo e tempo, dalla finestra della casa gli versò sopra la testa un vaso dʼacqua putrida e brutta; il quale sapendo donde venuto era, rasciuttasi la testa, nullʼaltra cosa disse: – Io sapeva bene che dopo tanti tuoni doveva piovere. —
Furono le sue risposte di mirabile sentimento. Era in Atene un giovane uomo dipintore, assai conosciuto, il quale subitamente divenne medico; il che detto a Socrate, disse: – Questi può esser savio uomo dʼaver lasciata lʼarte, i difetti della quale sempre stanno dinanzi agli occhi degli uomini, e presa quella li cui errori la terra ricuopre. – Era, oltre a ciò, usato di prender piacere di vedere le due sue mogli per lui talvolta non solamente gridare, ma azzuffarsi insieme, e massimamente sé considerando, il quale era del corpo piccolo, e avea il naso camuso, le spalle pelose e le gambe storte, e appresso la viltá dellʼanimo loro; e il farle venire a zuffa insieme era qualora egli volea, sol che un poco dʼamore piú allʼuna che allʼaltra mostrasse; di che esse una volta accortesi, e rivoltesi sopra lui, fieramente il batterono, e lui fuggente seguirono, tanto che la loro indegnazione sfogarono. Fu in costumi sopra ogni altro venerabile uomo, in tanto che solamente nel riguardarlo prendevano maraviglioso frutto gli uditori suoi, sí come Seneca nella sesta pistola a Lucillo, dicendo: «Platone e Aristotile, e lʼaltra turba tutta deʼ savi uomini, piú daʼ costumi di Socrate trassero di sapienza che dalle sue parole». Fu nel cibo e nel bere temperatissimo, intanto che di lui si legge che, essendo una mortale e universale pestilenza in Atene, né mai si partí, né mai infermò, né parte dʼalcuna infermitá sentí. Sostenne con grandissimo animo la povertá, intanto che, non che egli mai alcun richiedesse per bisogno il quale avesse, ma ancora i doni daʼ grandi uomini offertigli ricusò. Ed essendo giá vecchio, volle apprendere a sonare gli stromenti musici di corda: di che alcuno maravigliandosi gli disse: – Maestro, che è questo? aver veduti gli alti effetti della natura, e ora discendere alle menome cose musicali? – Al quale egli dimostrò sé estimare esser meglio dʼavere tardi apparata quella arte che morire senza averla saputa. Né in alcuna etá poté sofferire dʼessere ozioso; percioché, secondo scrive Tullio nel libro De senectute, egli era giá dʼetá di novantaquattro anni, quando egli scrisse il libro, il quale egli appellò Panaletico.