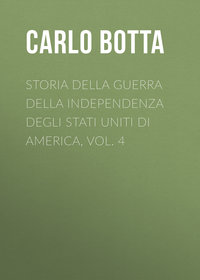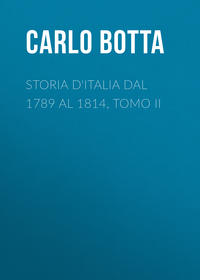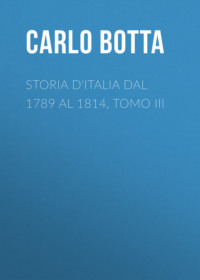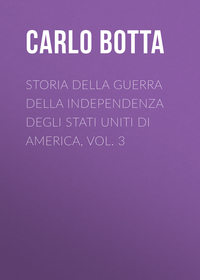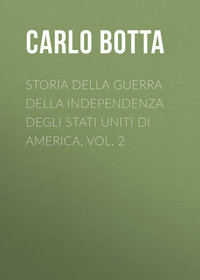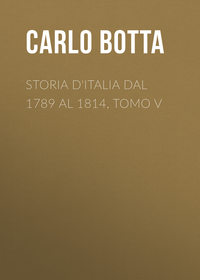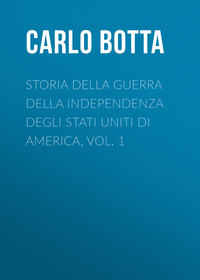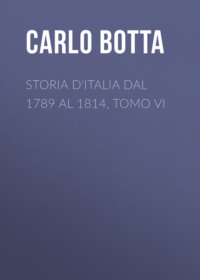Storia d'Italia dal 1789 al 1814, tomo IV
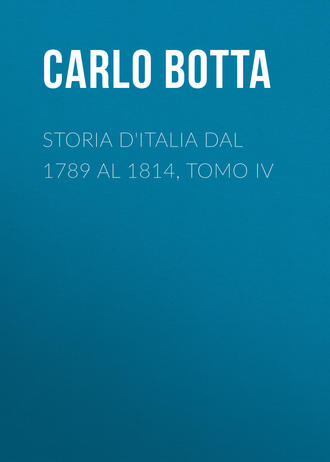
Полная версия
Storia d'Italia dal 1789 al 1814, tomo IV
Язык: Итальянский
Год издания: 2017
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу