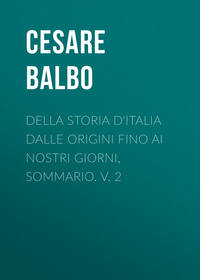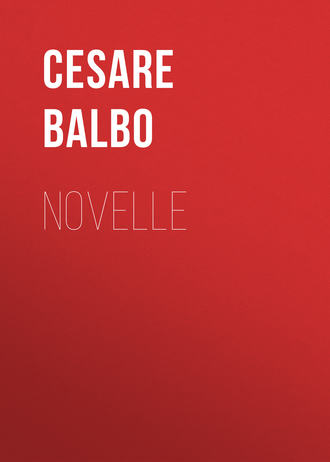
Полная версия
Novelle
E quella poi fu la sola volta che io vedessi, anche così per poco, intenerirsi o l'uno o l'altro di que' due infelici. Perchè infelici egli erano certamente. Ma ambidue lo portavano con un cuore da farne vergogna a tanti filosofi che scrivono libri sulla pazienza; ed anche poi a tutti quelli, perdonatemi, o signori, che della loro qualità ed educazione si servono a scusare quella che dicono sensibilità, ed è arrendevolezza al dolore, non, come dovrebbero, a sostenerlo tanto più fortemente. Ei dicono grossi ed insensibili questa povera gente, che non sente meno, ma sopporta più. E il vero è che nati e cresciuti tutti più o meno tra qualche stenti, ed avvezzi a veder felicità cui non possono arrivare, i poveri contadini tutti naturalmente e di buona fede s'imbevono di quel principio, che s'è quaggiù per patire e lavorare; mentre voi altri l'udite dire dai preti, e lo leggete talora da voi; ma veramente persuasi non ne siete; e certo vivete, scusatemi di nuovo, ed operate, e v'affaticate, e vi disperate, che si vede vi credete destinati a godere, e se vi son tolti i godimenti, la credete ingiustizia, e peggio se avete a patire. E quest'è che fa poi portar così malamente le disgrazie, succombendovi disperati alcuni, o facendo altri viltà per fuggirne. Ma forse io mal conosco i signori; e volevo solamente farvi intendere che se quei due poveri contadini non fecero scene nè disperazioni, ei non erano meno infelici per ciò. Di Maria v'ho detto che cosa avesse fatto per quel pensiero del dovere, ch'io pur troppo avea contribuito a metterle innanzi. Giudicate ora, che il dovere era tanto più stretto, come il seguisse. E non dico del dovere grosso della fedeltà di corpo o di cuore o di ogni minimo pensiero; ma il dovere stesso di star allegra e far felice lo sposo; anzi, per così dire, e quanto era possibile, d'esser felice ella stessa, e non pensar ad altro. Questo seguiva. E quanto a Toniotto, io il conobbi sempre ottimo anche da fanciullo. Pure nel primo fuoco di gioventù, vedeste come ei si fosse lasciato andare a quella tentazione, per fuggire un mal necessario e che non dipendea da lui, di far egli un mal volontario e scellerato mettendosi co' banditi di Majino. Ma ora la lunga vita da soldato l'avea sì avezzo a rispettare il dovere, e la guerra gli aveva sì insegnato ad indurirsi contro la disgrazia, che io ci metterei quanto ho al mondo, che suo cuore non fu macchiato mai nè d'un pensiero. Ed io l'ho creduto sempre che quest'educazione della guerra sia pure la più bella e buona educazione che possa avere un uomo; nè honne veduto tornar nessuno se non migliore. Ma ciò non importa; e so che molti tengono anzi il contrario, e guardano quei vecchi guerrieri come scomunicati. Sono opinioni; e confesso che la mia mi è principalmente venuta dal veder quel così schietto e così forte e così buono dolore del povero Toniotto. Non una parola mai d'ira, d'invidia o di disprezzo, nè una celia pure contro il buon Francesco. E se niuni anzi di questi che avean veduto paese e guerre si volean burlar di lui o far con esso i bravacci, egli era il primo senza affettazione a prender sue parti. Se erano amici prima, ora parean fratelli; e Francesco era sempre il primo a cercar Toniotto in piazza, e voler andar insieme all'osteria, e sarebbe stato in questo se avesse voluto essergli tutto il giorno in casa anche solo. Ma Toniotto non vi andava mai se non la sera talvolta con Francesco; e vi stava poco, e il più del tempo teneva i putti fra le braccia; ed egli e Maria si parlavano con tanta naturalezza e semplicità, che tutti credettero, e Francesco più di niuno, che nè l'un nè l'altra non vi pensassero più. E quasi quasi vi credevo pur io.
Un giorno tuttavia, che erravo su per quelle vette, e salendo su per un castagneto, entravo di quello in una vigna del padre di Toniotto, ei mi venne veduto egli che credendosi solo in quel luogo discosto, era seduto colla marra tra le gambe, e le mani appoggiate sopra, e il volto sopra esse; ed io stetti alcun tempo a mirarlo. E perchè al solito si vedeva lavorare che pareva allegramente, mi vergognai come se gli avessi sovrappreso e involato il suo segreto; e me ne sentii stretto il cuore, e mi rivolsi per di nuovo imboscarmi. Ma facendolo in fretta mossi alcune frasche, e il romore lo riscosse, e il fè rivolgere e alzarsi e chiamarmi, onde che io pur mi rivolsi: «E siete stanco» dissi, «mio caro Toniotto.» «Sì stanco appunto. Perchè, vedete voi, avevo alquanto disimparato il mestiero di zappare; facendo quell'altro. Ma a poco a poco di nuovo s'imparerà.» Io fui contentissimo, e credo anch'egli, di poterci mettere in questa conversazione; nè v'ha cosa che faccia parolai sopra un soggetto, come il non volersi mettere in un altro: «Ma» dissi, «l'avevate già di nuovo imparato là in Siberia con quel vostro signore; che, Dio gliel perdoni, era pure un tiranno di voler regolar vostro carteggio.» E m'accôrsi che m'ero involontariamente accostato troppo a ciò che si voleva fuggir da tutti e due; nè egli rispose. «E non ci sono vigne là, dite un poco?» «No» disse Toniotto, e lasciò cascar il discorso; ed io m'accôrsi d'essermi discostato troppo. «Povero Toniotto,» dissi, «voi siete sempre buono in ogni fortuna; e come siete stato buon figliuolo e buon soldato, ora siete buon contadino di nuovo e buon figliuolo.» Allora io aveva côlto nel segno; e Toniotto mi rispose com'altre volte già: «Quest'è, maestro mio, quest'è. Bisogna fare quel che Dio ci mette a fare, e prender quello che ci manda, ora una buona giornata, ora una cattiva; ora una vittoria, ora una sconfitta, ora un avanzamento o una croce alla parata, ora una palla alla battaglia; e qui pure, ora un buon anno, ora un cattivo; ora un buon raccolto o una bella vendemmia, ora una grandine. E così è che ogni giorno pur ci trovo somiglianza tra questi due mestieri.» «Dite bene, questa somiglianza io pur la trovo: epperciò forse ho sempre udito dire che i buoni contadini fanno i migliori soldati. Ma voi non eravate più soldato; e vi mancava pur poco a diventar ufficiale. Dite un po', se non era della palla, lo sareste stato certamente tornando.» «O se non era della palla…» diss'egli, e si fermò, ed io m'accôrsi d'aver di nuovo malaccortamente inciampato; pure volendomi valer dell'occasione per effettuare un mio disegno. «E non v'incresce» gli aggiunsi, «di quel mestiero? Così avanti già quando il lasciaste? forse il potreste riprendere con vantaggio.» Allora sì davvero ci trovammo su terreno franco, ed egli mi rispose che ci avea pensato, ed avea prese informazioni nel paese; ma tutti gli avean detto che era troppo difficile, e non gli riuscirebbe entrar altrimenti che come soldato: che invero gli faceano sperare diventerebbe presto sotto ufficiale, e forse anco ufficiale; ma che a dire il vero non gli dava il cuore di ricominciar da capo così; e se fosse tempo di guerra, potrebbe sperar di riaver i gradi come gli avea avuti, e ad ogni modo avrebbe soddisfazione in combattere almeno una volta presso alla propria patria, e pel proprio principe; ma in tempo di pace il mestiero militare non gli era mai parato il medesimo, e il quartiere anche a Parigi, e l'esercizio anche della guardia imperiale, due seccature. Dolevagli una cosa, d'aver dovuto alla frontiera nasconder quelle due croci che gli erano state lasciate fin sulla camicia e sugli stracci quando era in Siberia; e perchè sapeva che glie le muterebbero in un'altra prendendo servizio, più volte per questa ragione avea ripensato entrarci. Ma non se ne sentiva il cuore, e poichè Iddio l'avea rimesso presso al suo padre, tant'era vivergli allato e servirgli finchè Dio volesse; benchè a suo padre non era necessario… e qui parve accasciarsi sotto il peso de' dolorosi pensieri, e finì con dire: «Dura cosa, o maestro, a trent'anni il veder sparire e come annientarsi per un uomo tutta la vita passata. A trent'anni non si ricomincia più.» Egli avea ragione, ed io non gli volevo nè consentire, nè contraddire, e m'avviavo a partire. Egli mi prese la mano, non so se per serrarmela o per trattenermi; e poi tolta la marra in ispalla venne accompagnandosi con me.
Da quel giorno ei mi ricercò molto più, e avendo trovato il tono giusto su cui andar insieme, ci misimo a parlare molto sovente; e benchè egli fosse rozzo e senza educazione di libri, non è a dire come l'educazione della sperienza e della vita attiva gli avessero conformato tal cuore e ingegno da svergognare i più colti uomini; nè io, benchè di vita e professione così diversa, ho trovata persona mai con cui mi confacessi tanto come con lui. Povero Toniotto! Mi rimanevano sempre fitti nell'animo que' due pensieri che avrei voluti tôrre dal suo; che era inutile a suo padre, e che a' trent'anni non si ricomincia. Ma questo principalmente mi parea tanto più vero che l'aveva veduto anche negli altri tornati; chè quelli che erano intorno a' venticinque anni si facevano facilmente come una vita nuova, e quasi non pensavano al passato; ma quelli che eran tornati co' trent'anni addosso, difficilmente si eran adattati a mutar vita; e chi non sapeva altro che appiccicarsi senza profitto al passato, e tentar di rifar la medesima vita, e scioccamente lamentarsi del presente; ed altri anche rimaner nell'impresa e morire, ch'eglino stessi non sapean forse di che, ed io ben credo che era di seccatura. A tutti questi io aveva sempre consigliato prender moglie, e mi era messo a far matrimonii, non badando alle celie di coloro che mi chiamavano il gran matrimoniero. Ed io lasciava dire, perchè questa credo che sia la sola maniera di rivivere diverso da quello che si è vivuto; e la moglie se s'incontra buona, e i figliuoli, che tutti son buoni, sono un balsamo e un rinnovellamento che farebbe rivivere i sepolti. Ma al povero Toniotto come si facea? Dico il vero, il pensiero me ne venne: ma non glie lo seppi mai dir chiaramente; e girandovi intorno due o tre volte, ei non l'intese; e un'ultima volta che l'intese, mi lasciò con un aspetto aspro e di mal umore, che non gli ho veduto mai; e stettimo quindici dì senza che il potessi raccapezzare a riparlare insieme. Io vedeva il povero uomo mutarsi di dì in dì, e indurirsi a un tempo ed accasciarsi sempre più; ben pensai che non potea durare. Fui, senza dirgliene nulla, in città, e per certe mie relazioni con un colonnello tentai avergli un posto di sotto uffiziale; e mi si fece sperare; e tornando gliene riparlai. Ma egli con un mestissimo sorriso mi ringraziò, ma non volle; e vidi che il corpo infiacchito gli diminuiva anche la risoluzione, e benchè ora sarrebbe stata buona e necessaria a prendersi quella di partire, non gli dava più il cuore seguirla. Del resto io solo credo, e forse forse Maria, ci accorgevamo di questo suo infiacchirsi ed ammalarsi. Non si lagnava mai, non lasciava nè scemava il lavoro, e questo anche contribuì a farlo peggiorare; mai non si riposava se non quando potea credersi solo, come io l'avea sorpreso quella prima volta, ed ora seguendolo lo sorpresi più altre. Sei mesi passarono; era diventato come uno scheletro; venne l'inverno; non voleva rimanere in istalla ozioso; da Maria andava più di rado che mai. Appena era qualche giorno scoperta di neve la terra, egli riprendeva la zappa, e andava a lavorar a un fossato di viti nel tufo, che era una fatica peggio che mai. Io vi feci capitare una volta come a caso il medico, che s'informò di sua salute, e gli disse di lasciar quella fatica, e si curasse. Ma egli rispose allora, e poi: «Quand'io mi metta a letto son morto.» E così fu; preso un raffreddoruccio o che so io, che il tenne in casa, gli venne una febbre violenta, e mandò chiamare a un tempo il medico e me che il confessassi, e io 'l confessai, benedetta anima; e poi mi chiese di veder Maria con Francesco. E dicendo io: «Povera donna? a che serve?» rispose: «Avete ragione, anzi fate che non venga; io sono pur un uomo senza forza; ma ora me ne vuol poca più.» Fu sagramentato, e al terzo giorno gli si dava l'estrema unzione; trovammogli appesa al collo una treccia de' capelli di Maria: «Levatela» disse, «forse ho fatto male di continuar a portarla dopo il mio ritorno qua; questa, e questo libro di preghiere cristiane datomi da voi già, mi hanno accompagnato sempre, e tenuto caldo il cuore in Russia; prendetelo voi con le croci.» E si tirò il libretto e le croci di sotto il capezzale; mezza ora dopo perdè cognizione; e un'altra ora, e poi morì. Quest'è che m'ha fatto lasciar quel paese; e fui poscia da cappellano in quel regimento dove io aveva voluto far entrare Toniotto. «E Maria?» dissero alcuni degli ascoltanti. «Maria visse tranquilla altri quattr'anni; e or sono sei mesi, assistita da me, che là fui chiamato, e tornai per ciò, è morta in pace.»
Detto questo, il maestro s'alzò e s'avviò al giardino! e gli uni dopo gli altri tutti gli uditori, che alcuni mi parvero commossi dalla storia; altri all'incontro dicevano che di queste cose, se ci si volesse badare, ne accadono tutti i dì, e questo non si chiamava nè storia nè novella. Ma il vero è che nessuno riprese la disputa di prima; nè era stato altro l'intento del buon maestro. Poco dopo, già non essendo più persona nel salotto, vi tornava egli, ed io l'udii che preludiava sul gravicembalo, e intuonava come una cantilena d'improvviso molto semplice, e poi incominciava a cantare a mezza voce, onde io m'accostai, e udii questa canzone:
Tratto alle pugne oltre all'ignota MoscovaDell'italo guerrier tai fur gli accenti,Mentre ei forbiva al sorger del sol nordicoL'armi lucenti.Nordico sol, fa, che da lungi splendanoL'italiche armi in mezzo all'armi franche;Del sangue ostil oggi fien prime a tingersi,L'ultime stanche.Nordico sol, oggi per te dimenticoIl chiaro italo sole e l'alma terra,Ove nodrito io fui, che parte Eridano,E l'Alpe serra.Ardito e lieto al giorno di battagliaMe veda il Franco, che pur me deride,Primo al giuoco, alla mensa, ai vani canticiQuando s'asside.Alle mense, alle danze il pregio tolgasiIl Franco pur: ma sull'arduo ridottoMe segua il Franco, quando il passo sgombrogliE l'oste ho rotto.Dimesso il capo, basso il crine ed umileSerba alla stalla l'Arabo destriero.Squilla la tromba? – Ei chiama co' suoi fremitiIl cavaliero.Quando scomposto stuolo indietro timidoFugge del soverchiante oste l'incontro;Ditelo, o duci, chi si ferma, e impavidoSi volge contro?Quando la schiera spalle a spalle accumulaIrta di ferro, ed i cavalli aspetta;Chi figge i piè, chi tiene il posto immobile,O l'arma stretta?Or ben, terso è l'acciar, la squadra s'ordina,Batte il tamburo, omai suona ogni tromba;Cresce il frastuono; odi, di guerra il fulmineDa lungi romba.Ve' come a passo egual marcia terribileSchiera cui duce guidar sembra morte.Ecco i verde-vestiti; or deh proteggaviL'itala sorte.Felici voi cui diede il ciel combattereItali tutti l'un a l'altro accanto:Felici almen, cui resta d'una patriaIl nome e il vanto.Col Franco, o col German misto, o col Belgico,Franco di nome io pur divido il letto.Ma invano, italo cuore invariabileMi balza in petto.«Giorno verrà, dall'Alpi all'Adriatico,Una favella unirà Italia, e un nome;»Tu 'l promettevi c'hai le man, tu Italo,Entro sue chiome.Folle chi in te sperò; te il cielo vindice…Me chiama il duce, ecco la pugna ferve.Si pugni e vinca, e serva il mondo al perfido,Se Italia il serve.Finita che fu, ricominciò il maestro ad arpeggiare in varii toni minori, finchè alzandomi ei si avvide di me, ed io che ei non mi voleva bene d'averlo a suo malgrado ascoltato. Domandaigli pure se la canzone era sua, o forse di qualche ufficiale tornato da Mosca, o forse di Toniotto. Ma egli non me ne volle dir altro; ond'io credo che sia di lui. Perchè in gioventù so che fu pastore d'una colonia arcadica, sonettista, e schiccherator di versi sciolti nelle raccolte. Ora, colpa o grazie all'età, ei se ne vergogna e non vuol che si dica.
LA BELLA ALDA
Al tempo d'una delle discese de' Francesi per la combadi Susa, che qual sia non lo potrai accertare, avvenne, che rimasta a guardare il passo importante delle Chiuse una schiera d'uomini d'arme, questi, secondo il consueto di tutti gli uomini d'arme, invasori antichi e nuovi, e più dei distaccati e lasciati indietro, incominciarono in varii modi a taglieggiare ed opprimere il paese all'intorno. Benchè, essendo alleati del Duca e provveduti da lui d'ogni bisogna; ed avendo ordine da' proprii capi di vivere co' terrazzani come amici; e solendo poi i Francesi, a differenza di altre genti, e ad eccezione di alcuni scellerati che si trovano in tutte, essere ladri solamente per necessità, o tutt'al più per a tempo, e quando, come dicono essi medesimi, l'occasione fa il ladrone; certo i ladronecci erano men frequenti che non sarebbesi temuto; e se n'erano fatti alcuni da qualche mal soldato, e dalla gentaglia dell'esercito, per lo più anche erano da' cavalieri e da' capitani severamente castigati; e la riparazione sborsata o da essi, o dai delinquenti, o tavolta dal Duca. Ma se per soldati erano radi i loro peccati contro il settimo e il decimo comandamento di non pigliare e non desiderar la roba d'altri; tanto più frequenti, forza è pur confessarlo, erano quelli fatti contro il sesto e il nono, di non usurpare e non desiderare la donna altrui. È vizio antico e noto de' Francesi. Noto il famoso macello de' Vespri Siciliani al tempo di Carlo d'Angiò. Carlo VIII ne perdè il regno. A' tempi nostri ne durano vive le memorie, che i posteri cercheranno nelle storie, e forse nell'opuscolo de' Romani in Grecia, nelle belle canzoni milanesi del Porta e del Grossi, e nelle piemontesi del Calvo, e mille altre canzoni, anche troppe; chè gl'Italiani così d'accordo in cantare, ben avrebbero dovuto esserlo più in resistere. Come poi in tutte queste invasioni, così in quella di cui è la nostra istoria, i Francesi, che qualunque sia il merito personale di ciascuno di essi, ognuno se lo porta come in mano, e subito lo fa vedere, e per così dire lo spende e scialacqua in moneta piccola, dovunque arrivassero incominciavano a farsi ben volere; nè eran dimorati due o tre dì in una terra o in una casa che non paressero esservi da gran tempo; ed entravano a parte de' negozi e de' divertimenti domestici, e si facevano come della famiglia; e se non era di quella loro eterna frase del chez nous, che monta a ciò, a casa nostra si fa così, e si fa meglio che da voi; quasi che ognuno di essi sarebbe paruto nato e cresciuto della famiglia e del paese dove era arrivato poc'anzi. Ma che valeva? Tutto ciò era perfidia, e mentre cotestoro parevano aiutare, adulare, compiacere al padrone di casa, non ad altro miravano che alla padrona o alla padroncina, di cui insidiavano la fede e l'amore. Gran vantaggio almeno hanno sopra questi Francesi, e gran preferenza meritano gli altri invasori. I quali mostrandosi subito schiettamente e generosamente quali sono, nè si fanno mai da maschi nè da femmine perfidamente amare, nè ingannano i popoli soggetti, e dal primo all'ultimo giorno con ammirabil costanza, non sono un'ora mai da sè stessi diversi.
I giovani francesi lasciati da' loro capitani a presidio delle Chiuse nelle terre di S. Ambrogio, S. Antonio, Avigliana, Giaveno, e l'altre all'intorno, solevano, grandemente lagnarsi della propria sorte; che mentre i compagni erano scesi a' ricchi piani, e ridenti colli, e alle popolose città dell'Italia (e l'Italia per quanto sia bella in realtà, è più ancora all'immaginazione di tutti i popoli settentrionali), lagnavansi, dico, i giovani francesi d'essere stati lasciati in mezzo a quelle rupi, e que' nudi sassi, e que' neri boschi, e que' poveri tugurii; «dove» aggiugnea taluno con un dispettoso sorriso «difficile sarebbe dire se più sia guardata la onestà di queste misere Alpigiane dalla loro bruttezza, o più la bruttezza dall'onestà.» E in ciò si vuol dire che que' Francesi fossero veri conoscitori, e ben s'apponessero. Perchè le Alpigiane sogliono essere sane e fresche sì, ma piccole, grosse e tarchiate; e qualunque ne sia la ragione, di rado è che ritraggano le nobili e regolari fattezze delle altre Italiane. Immaginate adunque che novità fosse a que' Francesi sfaccendati, e che stavano ogni giorno di mercato meno a vagheggiare che a maledir le donne e le fanciulle sulla piazza di S. Ambrogio, il vedervi un mattino comparir soletta una fanciulla d'intorno a' sedici anni, alta, svelta e ben formata della persona; con mani e piè, che ne avrebbero disgradata qualunque più gentile fra le damigelle della Reina di Francia; e un volto! un volto, che all'allegrezza degli occhi, alla leggiadria della bocca, al color cinerino de' capegli, e più di tutto alla vivezza d'ogni impressione ed alla grazia dell'acconciatura, avresti detto francese, se non che la regolarità del bel profilo dall'alta e piana fronte al rotondo mento la mostravano veramente italiana; e l'abito snello e corto poi, lo stretto busto di velluto nero, e il fazzoletto rosso e grossolano, che mal gli copriva, ma graziosamente le inquadrava per così dire il viso, la mostravano schietta Alpigiana. Fu un sussurrio, un accostarsi l'uno all'altro, un accennar di dita, un affollarsi a lei, un comprarle, in men d'un ave, latte, ova, e quanto avea nella sporta, e un vagheggiarla e farle cerchio attorno, e interrogarla, e volerla seco trarre, che non s'era mai più veduto, ed avrebbe bastato a confondere una delle suddette sperimentate donzelle della corte reale, non che una tenera e timida foresozza com'era questa. Ma ella, benchè alquanto arrossisse e chinasse gli occhi, e non dando retta, poche oneste parole rispondesse ad ognuno; non mostravasi tuttavia troppo confusa; e pareva quasi persona che là venendo, avesse aspettato tanto, e vi fosse venuta ben apparecchiata, e che all'incontro di quell'altre sue paesane difese da loro bruttezza, ella lo fosse da sua bellezza ed alterigia. In breve, avendo ella così prestamente finito di vendere quanto avea recato; senza fermarsi altrimenti, ma alzando il capo e mirando intorno in atto quasi maestoso, e messo lo sguardo su un giovane che era in un canto del mercato, e non avea mai levato gli occhi da lei; ella, aprendo la folla de' vagheggiatori, dritto a lui s'avviò, ed egli a lei; ed ambidue poi uscieno della piazza, e s'avviavano per lo sentiero alpestro che sale alla Sacra o Monistero di S. Michele. Nè è a dire come tutti la seguitassero con gli occhi, e alcuni pure co' passi. Ma perchè era il sentiere molto cospicuo, e l'ora non lontana dal meriggio, e il mercato grosso, e presenti i capi, niuno s'ardì farle oltraggio, o nemmeno troppo lungi seguirla. Ed ella a raddoppiati passi, leggeri e veloce salendo, ora scomparendo, ora ricomparendo per gli alpestri andirivieni, finalmente svanì del tutto agli occhi di quegli stessi, che erano rimasti più costanti a mirarla. I quali forse, per poco di poesia che avessero in capo, l'avrebbero comparata a qualche Angiolo di Paradiso risalente al cielo fra le nubi; se non che quel compagno che traeva seco, dovea guastar la comparazione, e tarpar l'ali a qualunque più poetica o più amorosa immaginazione.
Ora che che dicessero e pensassero costoro, i due giovani, perchè giovane era pure il compagno, dicevano in salendo molte cose distesamente riferite in certa cronaca da me veduta, ma che io sforzerommi ridurre in brevi parole. Diceva egli dopo un silenzio di forse un buon quarto d'ora: «Bel piacere veramente quella calca che ci ha affogati; e quel chiasso che ci ha assordati; e quei visacci stranieri impertinenti, che Dio perdoni al signore Duca d'essere alleato di tal gente sicuramente eretici o pagani od anche peggio. Avete voi veduto che al sonar di mezzo giorno nemmeno uno non s'è alzato, nè ha fatto il segno della croce? Maledetti!» «Non ci avea badato,» rispose Alda. «Ma tu hai ragione, Giacometto; questi sono visacci e figure come non se ne sono mai più veduti al mondo; e come forse non si vedranno mai più, subito che il signor Duca non ne abbia più bisogno; e li abbia mandati via. Epperciò appunto è, che io avea tanta voglia di vederli una volta. Senti, Giacometto; quando fossimo marito e moglie, e avessimo figliuoli, e figliuoli poi, udendo da tutti narrare di questi Francesi, ci domandassero: gli avete voi veduti? com'eran fatti questi Francesi? e noi non avessimo che rispondere?» «Pah!» riprese Giacometto allungando e rinforzando il suono, che ne fece rimbombar le rupi, e prendendo poi tanto più animo egli a sgridare che vedeva lei ridotta a scusarsi; «che previdenza lunga! che pensiero di buona mammina! prima del matrimonio pensare alle storie che s'avranno a contar a' figliuoli che hanno ancora da nascere e crescere… Ma ringraziate il cielo, Alda, di non aver bell'e ora qualche storia a narrare a spese vostre, di qualcheduno di questi demonii che vi saltasse addosso a portarvi via, come parevano tutti essere lì lì per fare. E sì che io li stava adocchiando; e con l'aiuto del nostro santo Arcangelo san Michele, un po' più che avessero accennato, soldati, o demonii, o Francesi che sieno, io ne facevo pentire almeno un paio alla prima con questo mio bastone, che mai più non mi possa servire contro orso nè lupo, se io, per San Michele Arcangelo…» «Giacometto, Giacometto» diceva Alda raddolcendo la voce, «per carità non giurare, e principalmente non pel nostro santo Arcangelo, che non si adiri contro voi e contro me, e ci voglia aiutare in ogni nostra bisogna. Ed io vi confesserò, se volete, che ancor io quando mi sono trovata là in mezzo a quella calca, ancor io me ne sono sbigottita; che non avrei voluto esservi venuta mai più. E, a dirvi il vero, anche prima nello scendere, appunto quando giungevamo qui presso, già me n'era ripentita. Ma voi con quel vostro eterno contraddire e lagnarvi, me n'avevate fatto prender l'impegno; che se non era… or bene, è finita, non se ne parli più.» «È finita? Non se ne parli più? No, che non è finita; e sì che ne voglio parlare; e che non mi piace quel fare le cose a modo suo, sempre voler girare il mondo, or qua or là, e poi dire, è finita, non se ne parli più.» «Girar il mondo? vi par egli, Giacometto? incominciate voi a dirmi ingiurie? Povera me! Meschina me! Girar il mondo, perchè una volta sono andata al mercato a Giaveno, ed una volta ad Avigliana, e sempre con voi, Giacometto; e voi mi dite che voglio girar il mondo, e mi trattate come una cattiva donna. Povera me! che sarà di me?» E qui la fanciulla si diede a piagnere e singhiozzare, e Giacometto a intenerirsi; ma non essendo tanto ben educato da domandarla con delicata tenerezza: «Alda, tu piangi!» le disse più alla grossa: «Alda, tu sai ch'io non voglio che tu pianga. A che serve? quello che è fatto è fatto; e poichè il cielo ce ne ha salvati, ringraziamolo pure, e pensiamo a non rimetterci a' medesimi pericoli. Vedi, Alda;» e in ciò le prese la mano, e finchè durò largo il sentiero, camminarono così lato a lato, e mano in mano. «Vedi, Alda; se io ti sgrido, e mi sdegno per questo tuo capriccio di girar il mondo; voglio dire d'andare così una volta a Giaveno, una volta ad Avigliana, ed ora a Sant'Ambrogio, gli è perchè penso anch'io all'avvenire; e se abbiamo veramente a sposarci a questa Pentecoste, ed io poi andar su a' pascoli alla montagna, e lasciarti sola a casa ogni anno tutta la state; vedi, Alda, che pena sarebbe pensare io solo di là su: chi sa s'ora Alda non è a casa, ma a girar il… voglio dire, chi sa a Giaveno, chi sa ad Avigliana, e chi sa in mezzo a que' maledetti Francesi con que' loro occhi spiritati! nè io allora sarò lì ad impedire ciò che potrebbe succedere, nè a saperlo nemmeno. O Alda, Alda, io vorrei che tu amassi il paese come lo amo io, che non vo mai volentieri più in là di cento braccia dal bel campanile del monistero, e della casa di tuo padre.» E qui dice la storia che anche a Giacometto scesero alcune più poche, ma più grosse lacrime sulle guance. Ma essendo questo non dubbio segno del loro vicinissimo rappacificarsi, noi non seguiremo più oltre la cronaca, nè essi: che insieme arrivarono, e poi si lasciarono alla casa de' genitori di Alda. I quali, servi o contadini che si dicano della badia, erano di quei pochissimi che abitavano lì vicino; non essendone mestieri più a coltivare quelle poche e povere terre alpestri là su; troppo diverse dalle molte e ricche, possedute da' monaci per munificenza de' principi, ne' piani di Piemonte e Lombardia. Là intorno poi quanto era di terre, case ed uomini, tutto era della badia; e così anche Giacometto, orfano e solo, adoprato nell'interno del monistero alla cura degli armenti. I quali riducendosi all'inverno nelle stalle, alla primavera pascevano i prati all'intorno; ed alla state eran poi condotti a quegli altissimi piani, o somme valli che si trovano in quasi tutte le alpi, ed Alpi sono dette per antonomasia da' paesani. Nè vi ha terra, casa od abitato colà; ma ad ogni pascolo una bassa capanniccia, che mentre l'armento consuma l'erbe, serve al pastore a raccoglier sè talvolta e il latte e il vasellame da fare il cacio. Nè, durante que' pochi mesi, finchè è finito il pascolo o la stagione, il solitario Alpigiano scende mai da quella sua terrazza, dov'è quasi un San Simone Stilita sospeso tra cielo e terra; nè vede viso d'uomo più di tre o quattro volte, che la donna o i parenti vengono a rinfrescar sue provvissioni, e riportar giù i caci fatti. All'autunno, prima delle prime nevi, ei s'affretta a discendere. Che se i ghiacci ingombrassero i passi già per sè pericolosi, e frequenti di rozze croci, segni di non radi accidenti succeduti nell'istessa state; vi avrebbero a perire inevitabilmente gli armenti, e mal potrebbe salvarsi, quantunque destro e di sicuro piede oltre ogni credere, l'istesso Alpigiano.