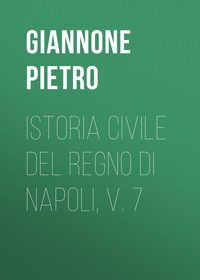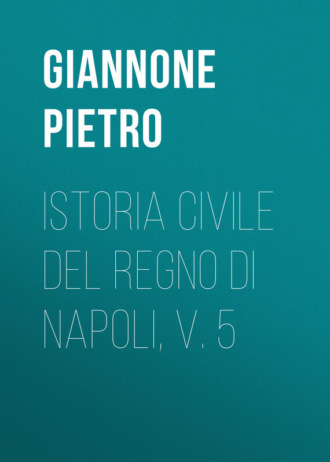
Полная версия
Istoria civile del Regno di Napoli, v. 5
Manfredi, ancorchè non personalmente citato, ma in quella maniera, per editto, udita la citazione, non volle mancare di mandar tosto suoi nunzj al Papa per difendersi di quanto se gl'imputava; ma ne furono tosto rimandati indietro senza conchiuder niente; ed approssimandosi il tempo prefisso alla citazione di dover comparire, tornò Manfredi a mandare altri suoi Messi; vi spedì il Giudice Attardo da Venosa, e Giovanni da Brindisi Notai suoi famigliari, i quali con premurose istanze dimandarono, ch'essendo stato Manfredi citato per cause ardue e gravi, non poteva commettere a niuno de' suoi Nunzj la sua difesa, ma che sarebbe egli personalmente venuto a presentarsi avanti il Papa ed il Collegio de' Cardinali, purchè però se gli spedissero dal Pontefice lettere di assicuramento, affinchè dovendo passare per luoghi della Chiesa non ricevesse molestia ed ostilità. Il Papa gli concedè sì bene licenza di poter venire, ma ristrinse il numero di coloro, che doveano per sua custodia accompagnarlo, e che entrasse senz'armata; onde Manfredi temendo di qualche insidia incamminossi alla volta del Pontefice, ma per sua sicurezza portò seco competente numero di soldati e molti Cavalieri per sua compagnia. Urbano ciò reputando una gran temerità di Manfredi, sordo ed implacabile a quel, che per sua discolpa allegavano i suoi Ambasciadori, rotto ogni indugio, rinovò le censure contro Manfredi, e con celebrità grande non altrimente di quel che fece il suo predecessore di nuovo lo scomunica, lo dichiara tiranno, eretico ed inimico della Chiesa[74].
Allora Manfredi toltasi ogni lusinga di poter entrare in grazia d'Urbano, vedendolo risoluto ai suoi danni, e che non vi era altro rimedio, che reprimere la sua alterigia colla forza, mandò subito ad assoldare nuove compagnie di Saraceni, spedendole a' confini del Regno, perchè infestassero lo Stato della Chiesa in Campagna di Roma; ed altre truppe mandò nella Marca d'Ancona, ritirandosi egli in Puglia a provvedere a' bisogni d'una buona guerra, che già prevedea doversi fare con Urbano.
Queste mosse accrebbero in guisa lo sdegno e l'ira nell'animo del Papa, che non contento d'aver umiliati i Svevi in Germania, cercò anche abbattergli in Italia; ed avendo scorto, che i ricorsi fatti da' suoi Predecessori in Inghilterra erano riusciti tutti vani, volle tentare se in Francia potessero avere miglior successo. Spedì pertanto ivi M. Alberto Notajo Appostolico, a trattare col Re Lodovico perchè accettasse l'investitura per alcuno de' tre minori suoi figliuoli, che erano Giovanni Conte di Nevers, Pietro Conte d'Alenzon, e Roberto Conte di Chiaramonte. Ma il Santo Re non accettò l'offerta, temendo (come rapporta Rainaldo[75] per una lettera di questo Pontefice scritta al soprannominato Alberto) di non scandalizzar il Mondo, assaltando un Regno, che a Corradino Svevo era dovuto per eredità, e ad Edmondo d'Inghilterra donato per investitura d'Alessandro IV.
Escluso per tanto Urbano dal Re Lodovico si rivolse a pubblicar la Crociata in Francia: laonde mandò ivi un Legato Appostolico ad assoldare buon numero di gente, ed a predicare l'indulgenza plenaria e remissione de' peccati a chi pigliava l'arme contra Manfredi, dichiarandolo per tiranno, eretico ed inimico della Chiesa.
Il Legato giunto in Francia pubblicò la Crociata, ed assoldò gran numero di soldati sotto Roberto Conte di Fiandra genero di Carlo Conte di Provenza e di Angiò, il quale venuto in Italia con buon numero di Cavalieri franzesi, in tal modo rilevò le cose de' Guelfi, e sbigottì i Ghibellini, che il Re Manfredi rivocò gran parte delle genti, che teneva sparse in Italia in favore de' Ghibellini; per la qual cosa i Guelfi di Toscana e di Romagna andarono ad incontrar Roberto, ed insieme con lui debellarono il Marchese Uberto Pallavicino. Il Re Manfredi per accorrere a' mali più gravi, si risolvè di passare egli in Campagna di Roma, e ponersi in luogo opportuno, ove potesse esser presto a vietare a' nemici l'entrata nel Regno, o venissero per la via d'Abruzzo, o di Terra di Lavoro; e subito andossene ad accampare con tutto l'esercito tra Frosinone ed Anagni[76].
Era allora il Papa in Viterbo, e volle che Roberto Conte di Fiandra con tutto l'esercito passasse di là, dove benignamente l'accolse, lodandolo ed accarezzando lui e gli altri Capi dell'esercito; e benedisse le bandiere e le genti, con esortarlo, che seguisse il viaggio felicemente, mandandolo carico di lodi e di promesse: delle quali gonfiato Roberto, si mosse con tanto impeto contra il Re Manfredi, che senza fermarsi in Roma un momento, andò ad accamparsi vicino a lui.
Ma il Re conoscendo, che non era per lui di fronteggiare nella campagna, ma più di munir le terre, e guardar i passi, per temporeggiare quella Nazione, che di natura è impaziente delle fatiche, quando vanno a lungo, si ritirò di quà dal Garigliano, da quella parte, che divide lo Stato della Chiesa dal Regno di Napoli; e già Roberto cercava di passar ancora quel fiume. Ma perchè la mano del Signore avea riserbato ad altri il ministerio della ruina di Manfredi, ecco che i Romani si ribellarono, e tolsero in tutto l'ubbidienza al Papa, e crearono un nuovo Magistrato detto de' Banderesi; per la qual cosa Urbano fu stretto a chiamare l'esercito franzese, per mantenere almeno con la persona sua il resto dello Stato ecclesiastico, che non seguisse l'esempio di Roma.
Non lasciò Manfredi di pigliare sì opportuna occasione, e di travagliarlo; poichè partito che fu dall'altra riva del fiume l'esercito nimico, passò solo coi Saraceni, ricusando i suoi Baroni regnicoli d'andare con lui ad offesa delle terre della Chiesa, col pretesto che l'obbligo loro era solo di militare per la difensione del Regno[77]; come se non fosse difender il Regno, con tal diversione abbattere le forze del nemico. Ma Manfredi cedendo al tempo, dissimulò l'abbandonamento, e con placidezza diede a tutti licenza, perchè partissero ed andassero quietamente alle lor case: gli richiese solamente a titolo d'imprestito, che lo sovvenissero di que' danari che aveano portato seco per le spese: ciò che fu trattato dal Conte di Caserta, e così fu fatto.
L'intrepido Re solamente co' suoi Saraceni andò verso Roma, e porgendo aiuto agli altri ribelli del Papa, perturbò tanto lo Stato ecclesiastico, che quelli Franzesi ch'erano venuti al soldo, non potendo aver le paghe, se ne ritornarono di là dall'Alpi, e gli altri che rimasero, appena bastarono a difenderlo.
§. I. Invito d'Urbano fatto a Carlo d'Angiò per la conquista del Regno
Questo accidente accaduto al Papa co' Romani, e 'l veder co' suoi ribelli unito Manfredi, accrebbe di tanto sdegno ed ira l'animo d'Urbano, che lo fece pensare a più potenti ed efficaci modi di ruinarlo; e perchè vedeva con isperienza, che le forze del Ponteficato non erano bastanti ad assoldare esercito tanto possente, che potesse condurre a fine sì grande impresa, chiamò il Collegio de' Cardinali[78], e con una gravissima ed accurata orazione commemorando le ingiurie e gl'incomodi, che per lo spazio di cinquanta anni la Chiesa romana avea ricevuti da Federico, da Corrado e da Manfredi senza niuno rispetto, nè di religione nè d'umanità, propose, ch'era molto necessario non solo alla reputazione della Sede Appostolica, ma ancora alla salute delle persone loro, di estirpare quella empia e nefanda progenie; e seguendo la sentenza della privazione di Federico data nel Concilio di Lione da Papa Innocenzio IV concedere l'uno e l'altro Regno, giustamente devoluto alla Chiesa, ad alcun Principe valoroso e potente, che a sue spese togliesse l'impresa di liberare non solo la Chiesa, ma tanti Popoli oppressi ed aggravati da quel perfido e crudel tiranno, dal quale parevagli ad ora ad ora di vedersi legare con tutto il sacro Collegio, e mandarsi a vogare i remi nelle galee. Queste e simili parole dette dal Papa con gran veemenza commossero l'animo di tutto il Collegio, e con gran plauso fu da tutti lodato il parer di Sua Santità, e la cura che mostrava avere della Sede Appostolica e della salute comune.
Si venne perciò alla discussione intorno all'elezione del Principe: e poichè dal Re Errico d'Inghilterra non era da sperarsi cos'alcuna per esser lontano, per essersi veduto fin ora inutilmente averlo aspettato tanto, bisognava metter l'occhio ad altro Principe. Dal Re di Francia esserne già stato escluso. Nè era da sperar soccorso da Alemagna, implicata allora tra fiere guerre per l'elezione di due Re de' Romani, cioè d'Alfonso X Re di Spagna e di Rainulfo fratello del Re d'Inghilterra. Gli altri Principi di Spagna, essere parte a Manfredi congiunti di sangue, e parte lontani ed impotenti; onde non restava, che dalla Francia, come non molto lontana e sempre propensa a soccorrere la Chiesa romana, di ricercar ajuto.
Era allora Carlo Conte di Provenza assai famoso in arte militare ed illustre per le gran cose fatte da lui contra gl'Infedeli in Asia sotto le bandiere di Re Luigi di Francia suo fratello[79], colui che per l'innocenza di sua vita adoriamo ora per Santo; e perchè era ancora ben ricco e possedeva per l'eredità della moglie tutta Provenza, Linguadoca e gran parte del Piemonte; parve al Papa ed a tutto il Collegio subito che fu nominato che fosse più di tutti gli altri attissimo a questa impresa; onde senz'altro indugio elessero Bartolommeo Pignatello già Arcivescovo d'Amalfi, ed ora di Cosenza e poi di Messina[80], per andare con titolo di Legato Appostolico a trovarlo in Provenza e riferirgli la buona volontà del Papa e del Collegio di farlo Re di due Regni, ed a trattare la venuta sua e sollecitarla quanto prima si potesse.
Fu anche in quest'anno 1263 da Urbano inviato in Inghilterra altro Legato al Re Errico e ad Edmondo suo figliuolo, affinchè non volendo accettar i patti contenuti nell'investitura concessa, nè essendo in istato di adempir le condizioni, colle quali era stato il Regno conceduto, rinunziassero in mano del detto Legato le ragioni che mai potessero avere in questi Reami per l'investitura fattagli da Papa Alessandro IV.
(Lunig[81] rapporta il breve d'Urbano IV drizzato in quest'anno 1263 al Re d'Inghilterra, riprendendolo della sua negligenza, e che perciò rinuncii all'investitura del Regno, minacciandolo di volerne investir altri. E ripigliando il trattato con Lodovico IX Re di Francia, offerendo l'investitura a Carlo suo fratello, gli scrisse per ciò due Brevi, che pur si leggono presso Lunig[82]).
E que' Principi prontamente, nauseati da tanti patti e condizioni dal Papa ricercate, rinunciarono l'investitura[83], nè vollero di ciò più sentir parola; ond'è che gl'Inglesi dicono che i Papi dopo aver tirate dall'Inghilterra grandissime somme di denaro per questo negozio, la fecero restar delusa d'ogni speranza, incolpando il Re Errico, il quale essi dicono, avrebbe dovuto alla prima rifiutar questa corona, o almeno rinunziarla tosto, da poi che vide le tante condizioni e difficoltà; e pensare che donare un Regno, sopra del quale non vi si abbia in sostanza alcun diritto, a condizione che s'abbia da andare a conquistare a proprie spese e rischio, è lo stesso, che fare un presente egualmente ingiusto e nocevole, e che fa tanto male a colui che l'accetta, quanto disonore a chi lo dona.
Intanto l'Arcivescovo di Cosenza giunto in Provenza, espose con molto vigore ed efficacia l'ambasciata; e come era uomo del Regno di Napoli e fiero inimico di Manfredi, cui avendo egli in tanti modi offeso, e dubitando non ne prendesse vendetta, premeva molto di ridurre ad effetto quest'impresa; esagerò a quel Principe con molto spirito e vivacità la bellezza e l'opulenza dell'uno e l'altro reame, e l'agevolezza d'acquistargli, per l'odio che portavano universalmente i popoli alla casa di Svevia.
Carlo, ancorchè Principe ambizioso, intesa l'ambasciata, restò alquanto sospeso, pensando all'arduità dell'impresa ed all'avversione, che v'ebbe sempre il Re Luigi suo fratello, onde fu per rifiutar l'offerta; nulladimanco stimolato da Beatrice sua moglie, la quale non poteva soffrire, che tre sue sorelle fossero l'una Regina di Francia, l'altra d'Inghilterra e l'altra di Germania, ed ella, che avea avuto maggior dote di ciascuna di loro, essendo rimasta erede di Provenza e di Linguadoca, non avesse altro titolo che di Contessa, vedendo suo marito così sospeso, gli offerse tutto il tesoro, tutte le cose sue preziose, fino a quelle, che servivano per lo culto della sua persona, purchè non lasciasse una impresa così onorata. Mosso adunque non meno dal desiderio di soddisfare alla moglie, che dalla cupidità sua di regnare, rispose all'Arcivescovo, ch'egli ringraziava il Papa di così amorevol offerta, e che accordate che si fossero le condizioni dell'investitura non sarebbe rimasto altro, che di parlarne al Re di Francia suo fratello, il quale sperava, che non solo gli avrebbe dato consiglio d'accettare l'impresa, ma favore ed ajuto di poter più presto e con più agevolezza condurla a fine.
Ed essendosi cominciato a trattar delle condizioni, che il Papa voleva imporre su i due reami di Sicilia e di Puglia, si vide, che Urbano voleva investirne Carlo, ma con quelle condizioni, colle quali erasi stabilita la pace tra Manfredi ed il Cardinal Ottaviano allora Legato Appostolico, cioè che Napoli, e tutta la provincia di Terra di Lavoro, colle sue città e terre e l'isole adjacenti, come Capri e Procida, Benevento col suo territorio e Val di Guado restassero alla Chiesa romana: e tutte l'altre province, coll'isola di Sicilia si sarebbero a lui per investitura concedute.
Mostrate al Conte queste condizioni, non volle in conto alcuno accettarle, e dal suo canto all'incontro si fecero alle medesime queste modificazioni: Ch'egli non avrebbe inclinato ad accettar l'impresa, se non se gli fosse conceduto interamente il Regno di Sicilia, con tutta la terra di quà dal Faro insino alli confini dello Stato della Chiesa; siccome lo possederono i Re normanni e svevi: di manierachè, eccettuatane la città di Benevento, con tutti i suoi distretti e pertinenze, niente dell'altre terre sarebbe rimasto alla Sede Appostolica se non il censo, ch'egli avrebbe pagato ogni anno di diecemila once d'oro[84].
E perchè premeva ad Urbano di non differir di vantaggio quest'affare; poichè in altra maniera non si sarebbe potuto scacciar Manfredi dal Regno; fu contento di moderare secondo il volere di Carlo le condizioni suddette; onde conchiuso il trattato in cotal modo, scrisse anche al Re Lodovico, che desse ajuto a Carlo suo fratello, significandogli per altra lettera, che i denari che fosse per somministrargli, si sarebbon presi per titolo di prestanza, con animo di restituirgli. Il Re Luigi non potè resistere a tanti impulsi, e di mala voglia fu alla perfine costretto a dar il consenso che suo fratello accettasse l'invito. Questa memoranda deliberazione, siccome fu cagione della fatal ruina della casa di Svevia, così ancora non può negarsi, ciò che da' savj politici fu ponderato, che portasse insieme la cagione non pur di tanti travagli e desolazioni della casa stessa d'Angiò, ma anche tante spese e tante inutili spedizioni alla Corona di Francia la quale per lo corso di più secoli si vide impegnata perciò a sostener molte dispendiose guerre, le quali riuscitele sempre con infelice successo, le han portato dispendii ed incomodi gravissimi; essendo cosa, e per gli antichi e nuovi esempi pur troppo nota, che cominciandosi da Gregorio M. tutti i Papi suoi successori, ancorchè invitassero molti Principi alla conquista, ebbero poi quegli stessi invitati per sospetti, quando gli vedevano prosperati, e a maggior fortuna arrivati; onde ne invitavano altri per discacciar i primi, per la qual cagione il nostro Reame fu miseramente afflitto, e reso teatro d'aspre e di crudeli guerre.
Ma mentre il Legato Appostolico era di ritorno in Italia, portando la novella della venuta di Carlo, ecco che Urbano dimorando in Perugia, se ne muore in quest'anno 1264 ciò che impedì per allora il passaggio di Carlo in Italia.
CAPITOLO II
Spedizione di Clemente IV e conquiste di Carlo d'Angiò, da lui investito del Regno di Puglia e di Sicilia
Re Manfredi intesa la morte di Papa Urbano ne prese grandissimo piacere, sperando esser in tutto fuor di pericolo, non meno per le discordie che a quei tempi soleano sorgere tra' Cardinali per l'elezione, onde nasceva lunga vacazione della Sede Appostolica, che per la speranza avea che fosse eletto alcun Italiano, il quale non avesse interesse co' Franzesi, e che avesse abborrimento d'introdur gente oltramontana in Italia; ma restò di gran lunga ingannato, perocchè i Cardinali, che si trovavano averlo offeso e dubitavano, che egli ne avesse presa vendetta, studiaronsi di creare un Papa d'animo e di valore simile al morto: e di comune consenso a febbrajo del nuovo anno 1265 crearono Papa il Cardinal di Narbona. Costui non solo era di nazione franzese, ma vassallo di Carlo[85]: ebbe già moglie e figliuoli; e fu uno de' primi Giureconsulti della Francia: fu poi, morta sua moglie, fatto Vescovo di Pois, indi di Narbona, ed appresso Cardinale, ed ora si trovava Legato in Inghilterra. Tosto che seppe l'elezione, partissi di Francia, ed in abito sconosciuto di mendicante, secondo il Platina, o di mercatante, come vuol Collenuccio, venne a Perugia, ove da' Cardinali con somma riverenza ricevuto, fu adorato Pontefice e chiamato Clemente IV; indi con molto onore a Viterbo 'l condussero.
La prima cosa, che e' trattò nel principio del suo Ponteficato, spinto da natural affezione che la Nazion franzese suol portare a' suoi Principi, fu la conclusione di seguitare quanto per Papa Urbano suo predecessore era stato cominciato a trattare con Carlo d'Angiò, per mezzo dell'Arcivescovo di Cosenza.
(Clemente IV successore d'Urbano, rivocò prima l'investitura data ad Edmondo; e la Bolla di questa rivocazione è rapportata da Lunig[86]; e da poi nell'istesso anno 1265 investì del Regno Carlo d'Angiò, e la Bolla di questa investitura con tutti i suoi patti e gravami, si legge pure presso Lunig[87], siccome anche il giuramento dato da Carlo nel 1266 a Viterbo, pag. 979).
E perchè trovò il Collegio tutto nel medesimo proposito, mandò subito con gran celerità l'Arcivescovo a sollecitare la venuta di Carlo. Confermò ancora il Cardinal Simone di S. Cecilia Legato in Francia, dal suo predecessore eletto; e gli scrisse che assolvesse tutti i Crocesignati Franzesi per Terra Santa, commutando loro il voto nella conquista di Sicilia, come si raccoglie da un'epistola di Clemente stesso riferita da Agostino Inveges[88]. Scrisse ancora al S. Re Lodovico, che desse aiuto a Carlo suo fratello; ed essendosi renduto certo, che così il Conte di Provenza, come il Re suo fratello erano disposti per l'impresa, commise al Cardinal di Tours, che accordasse i patti, co' quali egli voleva, che si fosse data l'investitura; ed ancorchè non potesse alterar niente di ciò ch'erasi convenuto con Urbano sopra le modificazioni già fatte, nulladimanco, ora che vide Carlo impegnato, volle di gravi e pesanti condizioni obbligarlo nell'istesso tempo che gli dava l'investitura.
Aveva Urbano, come si è detto, tentato in questa nuova investitura che s'offeriva al Conte di Provenza, ricavarne per la Sede Appostolica gran profitto, proccurando allora con ogni industria, che la provincia di Terra di Lavoro con Napoli e l'isole adiacenti, non altrimente che Benevento, fosse eccettuata e si aggiudicasse alla Chiesa; ma Carlo non volle sentir parola: poichè finalmente non se gli concedeva un Regno, la cui possessione fosse vacante, ma dovea egli colle sue forze discacciarne il possessore Manfredi, ed il Papa non vi metteva altro che benedizioni ed indulgenze ed un poco di carta per l'investitura; poichè le sue forze erano così deboli, che non poteva nemmeno mantenersi in Roma. Clemente per tanto, non potendo appropriar a se quella provincia, proccurò almeno gravare l'investitura di tanti patti e condizioni, che veramente rese il nuovo Re ligio, spogliandolo di molte prerogative, delle quali prima eran adorni i predecessori Re normanni e svevi.
I Capitoli stipolati e giurati da Carlo, nel modo che il Papa gli avea cercati, secondo che vengono rapportati dal Summonte, da Rainaldo[89] e da Inveges, sono i seguenti.
I. Fu da Clemente investito Carlo Conte di Provenza del Regno di Sicilia ultra e citra, cioè di quell'isola e di tutta la terra, ch'è di quà dal Faro insino a' confini dello Stato della romana Chiesa, eccetto la città di Benevento con tutto il suo territorio e pertinenze: e ne fu investito pro se, descendentibus masculis, et foeminis: sed masculis extantibus, foeminae non succedant; et inter masculos, primogenitus regnet. Quibus omnibus deficientibus, vel in aliquo contrafacientibus, Regnum ipsum revertatur ad Ecclesiam Romanam[90].
II. Che non possa in conto alcuno dividere il Regno.
III. Che debba prestar il giuramento di fedeltà e di ligio omaggio alla Chiesa romana.
IV. Atterriti i romani Pontefici di ciò che aveano passato co' Svevi, che furono insieme Imperadori e Re di Sicilia, in più capitoli volle convenir Clemente, che Carlo non aspirasse affatto, o proccurasse farsi eleggere o ungere in Re ed Imperador romano, ovvero Re de' Teutonici, o pure Signore di Lombardia, o di Toscana, o della maggior parte di quelle Province, e se vi fosse eletto, e fra quattro mesi non rinunziasse, s'intenda decaduto dal Regno.
V. Che non aspiri ad occupar l'Imperio romano, il Regno de' Teutonici, ovvero la Toscana e la Lombardia.
VI. Che se accaderà, stante le contese ch'allora ardevano per l'elezione dell'Imperadore d'Occidente, che fosse eletto Carlo, debba alle mani del romano Pontefice emancipar il suo figliuolo, che dovrebbe succedergli, ed al medesimo rinunciar il Regno, niente presso di se ritenendosene.
VII. Che il Re maggiore d'anni 18 possa per se amministrare il Regno, ma essendo minore di quest'età, non possa amministrarlo; ma debbasi porre sotto la custodia e Baliato della romana Chiesa, insino che il Re sarà fatto maggiore.
VIII. Che se accadesse una sua figliuola femmina casarsi coll'Imperadore, vivente il padre, e quegli defunto, rimanesse ella erede, non possa succedere al Regno; e se deferita a lei la successione del Regno, si casasse coll'Imperadore, cada dalle ragioni di succedere.
IX. Che il Regno di Sicilia non si possa mai unire all'Imperio.
X. Che sia tenuto pagare per lo censo ottomila once d'oro l'anno nella festa de' SS. Pietro e Paolo in tre termini, e mancando decada dal Regno; e di più un palafreno bianco, bello, e buono; e più, secondo un istromento che si legge nel regale Archivio[91], che fecero li Tesorieri del Re Carlo I nell'anno 1274 con alcuni Mercatanti di pagare alla Sede Appostolica ottomila once d'oro per questo censo, si vede, che seimila si pagavano per lo Regno di Puglia, e duemila per l'isola di Sicilia. Del che furono i Pontefici sì rigidi esattori, che nell'anno 1276 strinsero in maniera il Re Carlo, che trovandosi in Roma e senza danari, fu forzato scrivere in Napoli ai suoi Tesorieri, che impegnassero a' Mercatanti la sua Corona grande d'oro, e tante delle sue gioje ed oro, che abbiano in presto ottomila once d'oro, e che gliele mandino subito in Roma per doverle pagare alla Sede Appostolica per lo censo di quell'anno[92].
XI. Che debba pagare alla Chiesa romana 5000 marche sterline ogni sei mesi.
XII. Che in sussidio delle terre della Chiesa, a richiesta del Pontefice, sia tenuto mandare 30 °Cavalieri ben armati; in guisa che ciascuno abbia da mantenere a sue spese almeno tre cavalli per tre mesi in ciaschedun anno; ovvero si possano commutare in soccorso di Navi.
XIII. Che debba stare a quello diffinirà il Pontefice sopra la determinazione de' confini da farsi di Benevento.
XIV. Che dia sicurtà a' Beneventani per tutto il Regno; ed osservi i loro privilegi; e che permetta di poter disponere liberamente de' loro proprj beni.
XV. Che non possa nelle terre della Chiesa romana acquistar cos'alcuna per qualunque titolo, nè ottenere in quelle Rettorìa o altra Podestarìa.
XVI. Che s'abbiano a restituire alle Chiese del Regno tutti i beni, che alle medesime furono tolti.
XVII. Che tutte le Chiese e' loro Prelati e Rettori godano della libertà ecclesiastica, e particolarmente nelle elezioni, ristabilendo Clemente ciocchè Alessandro IV avea aggiunto nell'investitura data ad Edmondo figliuolo del Re d'Inghilterra; cioè che il Re e suoi successori non s'intromettano nelle elezioni, postulazioni e provisioni de' Prelati, in guisa che, nec ante electionem, sive in electione, vel post Regius assensus, vel consilium aliquatenus requiratur[93]; soggiungendosi però che ciò non abbia a pregiudicare al Re e suoi eredi, in quanto s'appartiene in jure patronatus, si quod Reges Siciliae, seu ejusdem Regni, et Terrae Domini, hactenus in aliqua, vel aliquibus Ecclesiarum ipsarum consueverunt habere: in tantum tamen, in quantum Ecclesiarum patronis canonica instituta concedunt; siccome perciò non furono esclusi i Re, sempre che la persona eletta fosse loro sospetta d'infedeltà, d'impedire il possesso e concedere il placito Regio alle Bolle di provisione, come altrove diremo.