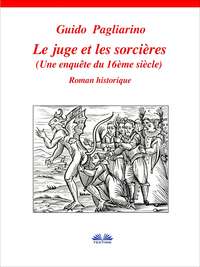Полная версия
Il Metro Dell'Amore Tossico – Romanzo
"Lo spero", avevo fatto eco meccanicamente, senz’accorgermi d'aver alimentato i suoi dubbi, sui quali si sarebbe arrovellato per anni. Me li avrebbe infine manifestati, in occasione d'un penoso avvenimento di cui dirò più avanti. Avevo soggiunto: "Certo, per voi cattolici è una vita piena di problemi, per me ce ne sono già così tanti altri nella vita che, almeno quelli religiosi, li ho sempre tralasciati."
"Non sei credente proprio per nulla?" m'aveva interrogato facendosi più serio.
"Mah, una volta ero del tutto ateo. Adesso… non lo so", avevo risposto esitante: "A volte... ma in definitiva, credo a ciò che vedo; e alla poesia."
"…e chi te la manda la poesia?" m'aveva incalzato, "la musa... già come si chiamava? Ah, sì, Calliope."
"No, Erato, dato che scrivo poesia lirica: Calliope era musa dell'epica."
"...e va bbuo', la musa in genere, non sottilizziamo, guaglio', No, era solo per dirti che la poesia è come l'amicizia; quella vera, dico: viene da Dio. Anzi, è uno dei segni dell'amicizia divina."
Non s'era più parlato per anni di quel rapporto Dio-poesia fino all'ultimo invito quando, a metà cena, Vittorio m’aveva detto: "Lo sai? Il premio letterario ti viene dal Cielo; come la tua poesia. Ricordi che ti dissi tanti anni fa? È Dio la vera e sola Musa."
"Anche per quelli come me?"
"Si capisce! Se son puri di cuore, però; e dimmi, tu lo sai perché i versi non dànno soldi?"
"So che ne direbbero i soldati di monsieur de La Palice5 : “Perché hanno pochi lettori”."
"Uh, e chista 'ccà ha da esse 'na risposta?! No, non li dànno perché son cosa dello Spirito Santo; e pure ti dico che la poesia bella viene ai poeti che hanno lo Spirito: tu sarai anche un repubblicano storico, un non credente, ma sei idealista."
Ebbene, ero rimasto per un momento interdetto: dalla vendita dei venti sonetti a quel potente sei mesi prima, infatti, non avevo scritto più nemmeno un verso.
...ma no, avevo concluso in me stesso quella volta, puro caso!
Capitolo V
Buon per me che, a differenza dell'amico, fossi rimasto magro e agile come un tempo e mi sentissi in corpo la stessa forza di quand'ero stato ragazzino, altrimenti quel pomeriggio non me la sarei cavata.
Mancavano solo più due giorni alla mia partenza per New York. Verso le 15 ero uscito per recarmi alla Gazzetta del Popolo per stendervi un articolo per la terza pagina. In quei tempi senza internet, mentre per le riviste si poteva usare la posta, per i quotidiani, causa i ben più rapidi tempi di pubblicazione, bisognava recarsi fisicamente in sede; solo i corrispondenti esteri avevano il privilegio di dettare l'articolo telefonicamente e, qualche volta, pure i cronisti se la notizia era urgente; io e gli altri pubblicisti dovevamo consegnare fisicamente il pezzo scritto a casa, oppure stenderlo direttamente in sede; abitualmente io scrivevo in redazione. Avevo precedentemente collaborato, sempre come esterno pagato a singolo pezzo, a uno dei più importanti fogli italiani, ligure ma con un'edizione torinese, di proprietà del finanziere Angelo Tartaglia Fioretti, capo d'un colossale gruppo economico; ma dopo che, contando sulla mia posizione d'indipendente pubblicista, senza avvisarne alcuno avevo preso a collaborare anche con l'altro giornale, quotidiano avversario delle concentrazioni economiche e favorevole a un’economia cristiano sociale, il foglio del Tartaglia Fioretti non aveva più stampato i miei scritti. Al mio perché mai? la risposta era stata esuberanza di costi. Non m'avevano neppur detto: Ti chiediamo di scegliere. M'avevano semplicemente respinto, come s'io fossi stato un loro cavallo improvvisamente bizzoso che, senza bisogno di scuse, non si monta più. Me n'ero indispettito, tanto più riflettendo ch'era stato proprio il Tartaglia Fioretti a comprarmi, un paio di mesi prima, quelle venti poesie da spacciar per sue con l'amante. Avevo finalmente capito che, anche in quell'occasione, ero stato trattato come una cosa che si può acquistare e buttare quando si vuole.
Il tragitto non era lungo da casa mia in via Giulio: un pezzetto della stessa, poi via della Consolata, via del Carmine e pochi metri di corso Valdocco, dove il giornale aveva sede; ma quel giorno, all’angolo tra lo stesso e via del Carmine, ormai vicinissimo alla mèta, mentre attraversavo sul verde, un furgone parcheggiato era partito all'improvviso puntando dritto su di me. Con un tuffo l’avevo evitato, proprio appena, limitando i danni alle mani spellate; e mentre il mezzo fuggiva, ero riuscito a prendergli la targa. Dopo aver scritto la mia nota al giornale, un poco sotto shock e pensando a chi potessi avere per nemico, m’ero precipitato alla vicina Questura da Vittorio. Come avevo pensato, il furgone era stato rubato. Nella mia denuncia l'amico aveva fatto annotare pure l'aggressione precedente, che ormai non si poteva più ritenere con sicurezza a scopo di rapina. Poteva esser stato il medesimo aggressore dell'altra volta a cercare d'uccidermi? Dopo essersi rimesso dai colpi potenti che gli avevo inferto? Purtroppo non avevo potuto vedere la figura alla guida.
"Non hai nessun sospetto? Che so, uno sgarbo?" m’aveva chiesto il D'Aiazzo.
"No, vado d'accordo con tutti."
"Già, già: potrebbe essere la vendetta di qualcuno che avevamo mandato dentro; ma di chi? Con tutte le indagini fatte assieme e tutta la gente che avevamo sbattuto in gattabuia... Mah! Comunque... forse sarà bene che mi guardi anch'io."
Da quel momento ero stato assai cauto e, fino al mio arrivo negli Stati Uniti, null'altro di male m’era successo.
Capitolo VI
Erano le 9 del mattino, ora di New York.
All'aeroporto s’era passato un controllo doganale così minuzioso che forse era secondo solo a certe ispezioni carcerarie. Avevano guardato persino nel tubetto del dentifricio e nel flacone del dopobarba, prendendo campioni che, pensai, avrebbero analizzato. Me l'ero aspettato, per la verità, un esame attento, anche se non talmente. Infatti, come pure i nostri mezzi d'informazione avevano riferito, due mesi prima in alcuni quartieri di New York l'acqua potabile era sgorgata dai rubinetti insieme a una strana sostanza inavvertibile al gusto, incolore e inodore, versata da ignoti in uno degli acquedotti in quantità proporzionalmente minuscole, ma talmente potente da indurre tutte le persone che l'avevano bevuta per almeno una decina di giorni alla condizione irreversibile di tossicodipendenti bramosi d'eroina. Nelle settimane successive era accaduta la stessa cosa a San Francisco e a Philadelphia. Contemporaneamente, i media avevano orecchiato e riferito che la Polizia Federale aveva saputo, da agenti della CIA, di un prodotto chimico che scienziati sovietici parevano avere sintetizzato. Qualcuno nell'FBI aveva avuto l'intuizione di far analizzare quelle acque e s’era scoperto il composto. Inutilmente però s’era cercato il laboratorio che lo produceva. S'era dunque sospettato che fosse stato importato segretamente. Intanto, i mezzi di comunicazione, preoccupando ancora di più i cittadini, s'erano chiesti: Si tratta di un'operazione di sabotaggio da parte dell’Unione Sovietica? O, col suo aiuto, dei nord vietnamiti? A nome del capo dell’URSS Leonid Il'ič Brežnev, l’ambasciatore sovietico aveva inoltrato una nota di ferma protesta alla Casa Bianca, accusando gli Stati Uniti di bieca calunnia.
Finalmente libero, m’ero avviato all’uscita per prendere un taxi che mi conducesse al Plaza Hotel, dove gli organizzatori m’avevano prenotato una camera. M’ero sentito però chiamare in italiano da una bella voce femminile. Era una signora attorno alla trentina, capelli corvini, molto graziosa, che, alla mia sinistra, stava agitando una breve sottile pertica con in cima un cartoncino bianco con il mio nome e cognome scritti in rosso.
"Il poeta Velli, vero?" m’aveva chiesto avvicinandosi e abbassando il cartello.
M’ero fermato: "In persona, signora..."
"Miniver: Norma Miniver. Sono inviata per lei dalla fondazione Valente." M’aveva porto la mano, dopo aver passato il cartello dalla destra alla sinistra. "L'ho riconosciuta non appena l'ho vista. Sa, la foto sui suoi libri."
Me n’ero compiaciuto. "Parla molto bene l'italiano", m’ero complimentato a mia volta mentre ci si avviava all'uscita.
"Sono italo americana."
"…ma il cognome..."
"È di mio marito. Quello della mia famiglia è Costante. Ho detto Miniver per abitudine. In verità", s’era confidata senza imbarazzo, " riprenderò il mio fra poco: abito già da sola e sto per ottenere il divorzio."
Al Plaza, dopo le formalità d'ingresso, Norma m’aveva preceduto col porteur fin dentro la stanza. Sulla soglia del bagno figurava un cartello in quattro lingue, ma non in italiano, che ammoniva in lettere maiuscole: NON BERE L'ACQUA DEGLI IMPIANTI IGIENICI. POTREBBE CONTENERE SOSTANZE NOCIVE.
"Sono a sua disposizione come hostess per tutto il tempo della sua permanenza", m’aveva assicurato; "ma ora, penso che lei desideri soltanto rinfrescarsi e riposarsi. Occupo la camera qui accanto a sinistra, per qualunque occorrenza."
M’ero chiesto se, tra le occorrenze, fossero comprese pure quelle che, inaspettate, mi stavano salendo dal basso ventre alla gola in quel momento.
Era stata lei a dare la mancia al ragazzo della valigia. Ospitalità completa, avevo pensato, e chi sa se è compreso anche il sostegno affettivo a quest'ospite solo e smarrito? Le avevo detto soltanto: "Avrò certo bisogno d'aiuto e... conforto."
Aveva sorriso brevemente, abbassando un momento gli occhi come confusa; poi s'era avviata, ma senza fretta, alla porta. "Il pranzo è alle ore 13", s’era congedata, "qui vicino, al Cooling's. Ne approfitterò per ragguagliarla su tutto il programma."
Il Cooling's offriva solo cibi freddi, insapori o peggio. Avevo preso una galantina di pollo gommosa con disgustoso riso, quasi gelato, al curry e una torta di mele legnosa. Avrei abbandonato entro i piatti gran parte del cibo. Norma s’era limitata a un frullato verdastro che avrebbe dovuto essere salutare, come aveva detto, di una tal consistenza spessa, fangosa che, forse, aveva il preciso scopo di far passare la fame allo stoico avventore a dieta.
"La cerimonia sarà a Brooklyn, immagino", le avevo chiesto nell’affrontare incoscientemente la pietanza e dopo che già lei, in pochi sorsi, aveva vuotato con coraggio il suo bicchierone.
"No. Non là!"
"Pensavo..."
"No, la premiazione sarà nel parco di villa Valente, fuori città. Le prime edizioni sì furono a Brooklyn, negli anni '40 e '50, quando c'erano ancora moltissimi italiani. Oggi il premio, di Brooklyn, ha soltanto più il nome."
Istintivamente avevo sfiorato col medio della sinistra l'unghia dell'indice dell'altra sua mano, che teneva posata da un buon tempo a mezza tavola, a fianco del mio bicchiere di minerale.
Non s’era ritratta.
A fine pranzo, m'aveva proposto di fare un giro per la città. Non avevamo impegni, infatti, fino alle 7 di sera. Il primo appuntamento del mio soggiorno prevedeva, per quell'ora, un aperitivo nell'appartamento niùiorchése di Mark Lines, il mio editore americano. Finalmente ci saremmo conosciuti. Aveva famiglia ma ci avrebbe ricevuti da solo: "Si tratta d'un piccolo attico che tiene di base in città, dove vive con un cameriere: moglie e figli abitano nel verde, a una quarantina di miglia da qui, e con loro si vede nei fine settimana", m’aveva spiegato Norma. Aveva soggiunto che sarebbero stati ospiti anche due dei Valente, fratello e sorella, e alcuni altri potenti della città: "Nonostante i milioni d'abitanti, le famiglie che contano davvero sono poche centinaia e si conoscono quasi tutte fra loro." Dopo l'aperitivo dal Lines, avrei cenato con lui e la mia interprete in un vicino ristorante di Manhattan; poi, libertà per me di fare ciò che preferivo. La mia assistente aveva due biglietti per un concerto, se volevo potevamo andarci o, se no, che proponessi io. La premiazione sarebbe stata il giorno dopo, alle 18. Cravatta nera ma, dato il gran caldo di quei giorni, diritto a indossare un camiciotto subito dopo. Di seguito, una festa in mio onore, nel parco della villa.
"La conduco io per la città, signor Velli, o ha qualche preferenza?" e aveva acceso il motore.
"Intanto, preferirei mi chiamasse Ranieri; anzi, Ran, ch’è più semplice. Posso chiamarla Norma?" Avevo avuto l'impulso di sfiorarle nuovamente la mano, che aveva posato sul cambio per la manovra, però m’ero trattenuto. Le avevo invece osservato a lungo il profilo.
Lei, senza guardarmi, aveva risposto: "Va bene, diamoci pure del tu."
"Mi piacerebbe vedere Brooklyn. Cosa ne pensi?"
"Okay, Ran."
Capitolo VII
Eravamo ormai sul ritorno, quasi al fondo della Brooklyn-Queens Expwy, lungo i moli e verso i ponti.
"…e adesso, dove vogliamo andare?" m’aveva chiesto Norma.
"A mangiare qualcosa di buono."
"A mangiare? T'è venuta fame?!"
"Non ho toccato quasi nulla." Avevo avuto un'ispirazione. Prendendola alla lontana, avevo azzardato: "Se tu sai di qualche cucina disponibile, potrei preparare io qualcosina d'accettabilmente gustabile."
"Sai cucinare? e ti piace?" La sua voce sapeva di sorpresa e divertimento: "Io lo odio."
"A me piace e, almeno, so quel che mangio; ma dove la troviamo una cucina?" Le avevo sfiorato il braccio in una brevissima carezza.
"Da me", aveva sorriso.
Era un piccolo alloggio nella Trentaquattresima, presso l'Herald Square, a Manhattan, al pianterreno d'una casa antica appena ridipinta. Non era distante dall’albergo. Un bell'appartamento. Dall'atrio-salotto, abbastanza ampio, con mobili in piuma di mogano stile inglese '800 e due brevi divani moderni contrapposti, poco più che poltrone, s'intravedeva a sinistra, per l'uscio lasciato aperto, il canterano della camera da letto, Luigi XV; l'ingresso s'apriva al fondo, per una porta ad arco, su di una bella cucina, tutta in legno di noce. Il bagno doveva essere attiguo alla camera da letto.
"Abito in affitto", aveva precisato Norma, "mobili compresi. Fino al mese scorso vivevo nell'attico di mio marito, qui vicino. Arnold vi ha pure l'atelier."
"L'atelier? Cos'è, un sarto?"
"Ma no", aveva riso, "è Arnold Miniver, il pittore."
Non l'avevo mai sentito nominare: "È famoso?"
"Famosissimo!" s’era stupita: "Ha venduto anche in Italia; ma non lo conoscevi?!"
"Francamente no." L'avevo fatta corta: "Posso andare in cucina?"
"Oh... certo, siamo qui apposta, no?" L'espressione indicava un ben diverso pensiero. Per la verità avevo pensato, a un certo punto, d'abbandonare l'idea del pranzo e volgermi subito al corteggiamento, ma la fame c'era e, dopotutto, quel rimandare poteva essere una buona tattica per aumentare il suo interesse per me; a patto ch'io le mostrassi subito il mio. Nel superarla, le avevo fatto scorrere una lievissima carezza sulla schiena.
In dispensa non aveva molto. Avevo improvvisato con quel poco, carne cruda affettata sottile, cetriolini sotto aceto, yogurt, prezzemolo surgelato, pomodori; e m’ero accinto a preparare quattro deliziose scaloppine. Avevo tritato finemente i cetriolini mescolandoli poi allo yogurt in un tazzone, con un poco di sale e un po' di prezzemolo che avevo prima scongelato con un momento di forno. Avevo lasciato riposare. Intanto avevo messo al fuoco una spessa padella antiaderente, su vivace fiamma, posandovi un pezzo di carta bianca da forno. Quand’era scurita nei punti a contatto col fondo, avevo levato la carta e disteso le carni nella padella. Sempre su fiamma altina, avevo cotto per un quattro minuti, due per ogni faccia delle bistecchine, finché s’era formata su entrambe una crosticina bruna. Avevo salato e servito in due piatti, coprendo la carne con la salsa fredda. Qualche pomodoro a fette per contorno e guarnizione. Una bontà velocissima! Norma, seppure a dieta, aveva mangiato intera la sua porzione, lietamente. Sì, penso che le donne possano conquistarsi anche così, prendendole per la gola.
Non sapevo che, forse proprio in quel momento, qualcun altro si stava preparando a prendere per la gola me, con una bevanda; e con ben diverso obiettivo.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.