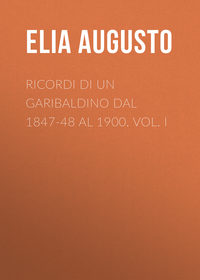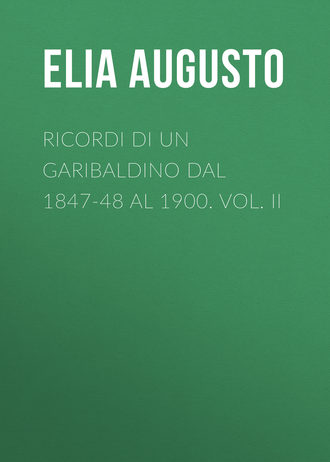
Полная версия
Ricordi di un garibaldino dal 1847-48 al 1900. vol. II
Nell'assalto della barricata Bixio, Dezza, Menotti, Bezzi, Canzio, Cucchi, Carbone, Damiani, Mosto, Venzo, Manci fecero prodigi di valore; Bixio sopra tutti; come una furia si precipitava dove era più forte la resistenza, tempestando di colpi i nemici, finchè cadde gravemente ferito.
Forzata l'entrata in città, i Carabinieri Genovesi ed il resto di Mille seguiti dai bravi picciotti, si lanciarono sui borbonici forzandoli a cedere ed a ritirarsi; nel combattimento dei Quattro Cantoni fino a Piazza del Duomo ed a Porta Maqueda Cucchi, Miceli, Venzo, Mosto, ed altri bravi caddero feriti; ma i nostri, non ostante le preziose perdite, procedevano dovunque vittoriosi. Turr, Sirtori benchè feriti insieme agli altri ufficiali di Stato Maggiore si moltiplicavano, ed erano all'attacco del Palazzo Reale, erano a quello di Porta Maqueda, tagliavano le comunicazioni tra il mare e il Castello, mentre Dezza e Missori con un pugno dei Mille battevano il nemico all'Albergaria.
La Loggia, e molti altri signori siciliani componenti il Comitato insurrezionale, con alcuni dei Mille fra i quali il Venzo, si cacciano fino alla Fiera-Vecchia, penetrano nelle Chiese, salgono sui campanili, ed il terribile tocco delle campane a stormo chiama in armi tutti i cittadini. La Città dei Vespri si ridesta, si erigono dovunque barricate, e i soldati napoletani, incalzati da ogni parte, sono costretti a ritirarsi nelle caserme e nel forte di Castellammare.
Garibaldi si spinge fino in piazza Bologna, insedia il suo quartier generale nel palazzo Municipale e di là emana il primo suo atto dittatoriale in nome di Vittorio Emanuele, col seguente proclama:
Siciliani!
"Il generale Garibaldi, dittatore in Sicilia a nome di S. M. Vittorio Emanuele Re d'Italia, essendo entrato in Palermo stamattina 27 maggio, ed avendo occupata tutta la Città, rimanendo le truppe Napoletane chiuse nelle caserme e nel forte di Castellammare, chiama alle armi tutti i Comuni dell'Isola, perchè corrano nella metropoli al compimento della vittoria.
Dato in Palermo, oggi 27 maggio 1860
G. Garibaldi.Il 28 fu giornata nella quale la città di Palermo sofferse orribilmente. La mitraglia fece vittime numerosissime, le bombe rovinavano, incendiavano, distruggevano tutto; ma mentre il bombardamento infieriva con tutti i suoi orrori, Garibaldi pensava anche all'organizzazione civile. Nominava Crispi segretario di Stato; il Duca della Verdura sindaco; istituiva un Comitato di difesa, presidente lo stesso della Verdura e componenti i signori Michele Mangiano, Tommaso Lo Cascio, barone Michele Capuzzo, barone di Paternò, Rubino Emanuele e Benedetto Scidita, Pietro Messineo, marchese Pilo, Patriola, Girolamo Mondino, ed altri patrioti, e segretario Vincenzo Scimecca.
La mattina del 29 maggio, i garibaldini ebbero un rinforzo di siciliani condotti da Fardella.
Per tutto quel giorno il combattimento continuò accanito, specialmente a Montalto ove il Laporta, il marchese Firmaturi, il Sant'Anna, sostenuti dai Carabinieri genovesi, fecero colle squadre dei Picciotti, con fermezza e valore, il loro dovere.
Il generale Lanza, che fin dal mattino aveva fatto inutili sforzi per riprendere le posizioni perdute, e vedeva falliti tutti i tentativi per aprirsi le comunicazioni con Castellammare, fece cessare il bombardamento, durato tre giorni e tre notti senza intervallo.
I Consoli esteri e l'Ammiraglio inglese, commossi per le tante rovine e gli eccidi che da tre giorni sterminavano la bella città, fecero dei passi presso il generale Lanza perchè si desse tregua con un armistizio a tanta effusione di sangue cittadino; il generale borbonico acconsentiva, e la mattina del 30 spediva al Dittatore Garibaldi la lettera seguente:
Generale!
"L'ammiraglio britannico mi fa conoscere che riceverebbe con piacere al suo bordo due miei generali, per aprire con lei una conferenza, nella quale egli servirà da intermediario.
"La prego farmi conoscere se acconsente, e nel caso affermativo, permettere che i due miei generali passino la sua linea, facendoli Ella accompagnare dal palazzo reale, ove potrebbe mandarli a prendere, fino alla Sanità per imbarcarsi.
"In attesa di una sua risposta, ho l'onore di essere
"29 maggio 1860.
"Lanza".Garibaldi acconsentì e ordinò la cessazione del fuoco, disponendo che l'intervista avesse luogo all'una pomeridiana. Il maggiore Cenni fu inviato alle undici e mezzo con due guide al palazzo Reale.
Erano scorsi pochi istanti dalla partenza del Cenni, quando veniva dato un allarme a Porta Termini; poco dopo incominciavano le fucilate: Erano Von-Mechel e Bosco, i quali ritornavano da Corleone, col dispetto di essere stati giuocati per la terza volta, e di avere inseguito non Garibaldi coi suoi volontari, ma un treno di cassoni e carriaggi inservibili.
I garibaldini non risposero al fuoco; Carini e Sirtori si presentarono per dare la notizia dell'armistizio nel momento in cui il fuoco dei napoletani era più vivo; Carini ne riportò grave ferita, Sirtori fu ferito leggermente. Turr, raccolti quanti uomini potè sul momento, corse in appoggio dei nostri a Porta Termini.
In quel momento il generale borbonico Letizia accompagnato dal Cenni traversava Toledo; saputo quanto accadeva, si offerse di recarsi egli stesso sul luogo del combattimento per portare ai suoi la notizia dell'armistizio, e per fare cessare il fuoco onde non si sospettasse un tradimento. Arrivato sul luogo, impose a Von-Mechel e a Bosco di cessare da ogni azione ostile, essendo che la tregua doveva essere rispettata da tutti. Garibaldi all'una si recò a bordo dell'"Annibal" nave da guerra Inglese, nella cui sala di consiglio ebbe luogo la conferenza e fu stipulata una tregua di 24 ore; ma, prima che questa venisse a scadenza, il generale borbonico richiese la sospensione delle ostilità per altri tre giorni, prodromo evidente della resa finale. E Garibaldi accondiscese ancora.
Infatti il 6 giugno, i negoziati furono ripresi e senza difficoltà condussero ad una convenzione, per la quale le truppe napolitane sgombravano Palermo e il forte di Castellammare per la via di mare.
Intanto tutte le principali città dell'Isola si erano affrancate a libertà, e di tutta la Sicilia, il 7 giugno, non restava in mano del Borbone che Messina, la cittadella di Milazzo, Augusta e Siracusa.
Garibaldi s'insediava, col suo quartier generale e col suo governo, al Palazzo Reale.
Dopo la presa di Palermo Garibaldi avuta notizia che Elia curato con cure fraterne dai bravi medici chirurgi, Ripari, Lampiasi, Cipolla, Maltese, era vivente a Vita, accolto amorevolmente in casa del patriota Salvatore Romano, mandò Menotti con incarico di portarlo possibilmente a Palermo, e ivi giunto il generale volle che fosse curato sotto ai suoi occhi e lo fece condurre al palazzo Reale.
Occorreva provvedere ora al necessario per non perdere il frutto delle riuscite imprese. Faceva mestieri organizzare i corpi militari in forza dell'entusiasmo dei cittadini per poter far fronte ai pericoli delle rappresaglie d'un governo che, prossimo a cadere, voleva segnalare i suoi ultimi giorni con atti disperati e col sovvertimento delle turbe e di ogni ordine civile.
Questi pensieri pesavano orribilmente sull'animo del dittatore, il quale trovava più difficile mettere riparo a queste difficoltà civili che il combattere formidabili eserciti borbonici. Per riparare a questi mali erano necessarie delle spedizioni nell'interno dell'Isola, affidate ai suoi fidi compagni; ma l'esecuzione di tale progetto gli riusciva nel momento assolutamente impossibile. Da Genova non arrivavano rinforzi. Anzi si avevano notizie che due navi cariche di volontari condotti dal maggiore Corte "L'Utile" e il "Charles Georgy" erano state catturate dalla crociera napoletana e condotte a Gaeta.
Era un vero disastro che impensieriva il Dittatore, tanto più che si sapeva che trovavasi in viaggio la forte spedizione Medici. Per fortuna questo esperto condottiero, che aveva ereditato da Garibaldi tutte le astuzie e tutte le audacie, seppe deludere la vigilanza della crociera napoletana, approdando inaspettato a Cagliari e di là, per rotta impensata dai nemici, arrivare alla desiderata destinazione.
Nella mattina del 19 giugno Medici sbarcava sulla vicina costa di Partinico con forte aiuto di uomini e di armi, e tutte le preoccupazioni del Dittatore erano dissipate – Medici aveva con sè il bravo colonnello Malenchini coi suoi toscani – e annunziava l'arrivo di Cosenz. L'arrivo di Medici pose Garibaldi in condizione di compiere i suoi piani riguardo alla Sicilia, quelli cioè di scacciare quanto rimaneva dell'esercito borbonico nella parte orientale dell'Isola.
Divise le forze in tre colonne: la prima formante la sinistra agli ordini di Medici doveva marciare per il litorale fino a Milazzo, ultimo obbiettivo Messina; la seconda, al centro, condotta dal Turr per Missilmeri, Villafrati, Alia, Caltanisetta, sopra Catania, scopo ultimo Messina; la terza, all'estrema destra, comandante Bixio, per Corleone, Girgenti, Catania scopo finale Messina; così che, tutte le forze non avevano che un solo obbiettivo la punta del Faro.
La marcia di queste brigate contribuì moltissimo a sistemare il nuovo ordine di cose, a sollevare l'elemento liberale e por freno agli insani tentativi di disordini.
Ma questo consolidamento incontrava ostacoli per il fatto che armi borboniche occupavano dei punti importanti dell'Isola e tenevano in soggezione tutta la regione orientale, appoggiandosi su Milazzo e alla cittadella di Messina.
Il Dittatore riserbava a Medici la parte splendida di liberare questa regione dalle truppe borboniche, e Medici, ricevuti gli ordini, a marcia forzata occupava Barcellona, quivi giunto, temendo che i regi fortificati in Milazzo tentassero un colpo per sloggiarlo, avvisava a tutti i mezzi per fortificarvisi; occupava l'interessante posizione del fiume Meri; muniva il ponte con due cannoni; distendeva le sue ali di difesa fino all'altura del villaggio Meri; e tutto preparava alla difesa della sua posizione per dare tempo all'arrivo di altri rinforzi.
Le truppe borboniche così composte: un corpo di 3500 uomini proveniente da Messina, altro di 1500 stanziato a Milazzo, altri 2500 che si aggiunsero provenienti da altre parti dell'isola, erano comandate dal colonnello Bosco, il quale si trovava in grado di dare aspra battaglia.
Il giorno 17 ebbe luogo un primo fatto d'armi, ostinato e sanguinoso.
Medici si era fortificato presso Carriola al fiume Nocito, ed aveva occupata la strada di Meri e Milazzo, erigendovi barricate. Bosco pensò di sloggiarlo, e con forze preponderanti pervenne a passare oltre Carriola il Nocito; ma ivi s'impegnò un vivissimo combattimento con la destra di Medici, gagliardemente tenuta dal reggimento Malenchini; tanta resistenza da questa parte poneva i regi in pericolo di essere tagliati fuori della loro linea, per cui Bosco spinse altri battaglioni verso le barricate; il combattimento fu accanito, ma Medici per venirne a capo, lanciava contro le truppe borboniche un battaglione della riserva e i nostri alla punta della baionetta ricacciavano i regi dentro Milazzo. Le truppe comandate dal Malenchini combatterono sotto gli occhi di Medici assai valorosamente.
Il generale Garibaldi avvisato a Palermo della resistenza che incontrava Medici s'imbarcava con un buon rinforzo. Sbarcato a Patti corse innanzi solo, al quartiere generale di Medici. Vi arrivò il 19 e vi trovò anche il Cosenz.
Calcolando il generale che i rinforzi sbarcati a Patti sarebbero arrivati il 20 sul luogo del combattimento, decise di dare battaglia e d'investire Milazzo.
La mattina del 20 alle 5 il generale Medici divideva le sue truppe in due colonne, ciascuna di quattro battaglioni, una sotto il comando di Simonetta, l'altra sotto quello di Malenchini.
Deciso il combattimento Garibaldi ordina che il Malenchini per la strada di Santa Marina si porti ad assalire senz'altro la sinistra del nemico; dà incarico al Medici di avanzare col reggimento Simonetta e il battaglione Gaeta per la strada di San Pietro spingendosi col centro e colla destra contro la città; affida a Nicola Fabrizi d'occupare con una legione di siciliani la strada di Spadafora per antivenire ogni sorpresa di un'eventuale sortita del presidio di Messina; delibera infine che la colonna Cosenz, già partita fin dall'alba da Patti e rinforzata dal battaglione Dunn e da quello del Guerzoni, lasciati a guardia di Meri, formino la riserva.
Alle 5 del mattino tutti erano in moto; il Malenchini alle 7 aveva già aperto il fuoco presso San Papino; anche il Medici attaccava il nemico al di là di San Pietro e il combattimento si accese, accanito su tutta la linea. I garibaldini si spingono verso Milazzo, ma la loro sinistra appoggiata al mare, trovò tale resistenza nei regi nella strada di San Pepino e tale fuoco d'artiglieria dal forte e dalla batteria portata dietro i canneti, che furono obbligati a ripiegare.
Ad accrescere lo scompiglio nelle giovani schiere dei volontari, concorse la cavalleria nemica che irruppe furiosamente sui nostri, sbaragliandoli. Comandava questa colonna il colonnello Malenchini che, potentemente coadiuvato dai suoi bravi ufficiali, faceva sforzi eroici per riordinare i suoi e ricondurli alla pugna; chi si distinse per ardire insuperabile fu il Tommasi, che venne promosso tenente sul campo di battaglia.
Mentre questo avveniva sull'ala sinistra, Medici spingeva tre dei suoi battaglioni ed uno di Carabinieri genovesi verso il fiume Nocito; investiva i molini dove i regi eransi fortificati e tentava d'impadronirsi della lingua di terra che congiunge Milazzo con l'interno, e così girare alle spalle del corpo napoletano e tagliar fuori di Milazzo il Bosco; ma anche questo tentativo incontrò un'energica resistenza, perchè il Bosco da quel lato aveva spinto il maggior nerbo delle sue forze; si combatteva uno contro tre, senza contare la mitraglia che, da dietro grandi siepi di fichi d'India, faceva strage dei nostri.
Medici riconosce la gravità della posizione e, da quell'eroe che era, decide d'avventarsi contro il cannone che faceva strage dei suoi e d'impossessarsene. "Meglio perire nell'arrischiata impresa, che vedere così sacrificati i miei soldati". Con questo pensiero raduna quanti più può dei suoi e si lancia in mezzo al fuoco nemico, ma nei primi passi gli cade morto il cavallo e al fianco suo è colpito da palla fredda il Cosenz, tanto da rimanerne tramortito; riavutosi tosto e circondato dai suoi valorosi compagni, riprende impavido il combattimento.
Garibaldi, accortosi del pericolo che correvano i suoi cari compagni, riunisce intorno a sè Missori, Statella e quanti trova sotto mano e si lancia al soccorso; il cavallo di Garibaldi è ferito e non sente più il freno; il tacco di un suo stivale è portato via da una scheggia; è obbligato a smontare dal cavallo; accanto a lui in quel momento cadeva mortalmente ferito il maggiore Breda; a Missori è pure ucciso il cavallo; anche Garibaldi vede che per spuntarla bisognava ad ogni costo impadronirsi del cannone che faceva strage, e dà gli ordini necessari; si lancia alla testa dei suoi e il cannone è preso e trascinato nelle proprie linee.
Allora la fanteria napolitana, che in quella giornata combattè valorosamente, apre i suoi ranghi e dà il passo ad una furiosa carica di cavalleria che s'avventa sui nostri come un turbine per riprendere il pezzo; le squadriglie siciliane giunte allora da Patti entrano in combattimento e con una formidabile scarica fermano l'impeto dei cavalieri; l'ufficiale che comandava la cavalleria è esso pure obbligato ad arrestarsi da Garibaldi che aveva preso la briglia del cavallo; l'ufficiale mena un fendente, ma Garibaldi para il colpo e con una pronta risposta gli taglia la gola; i napoletani assalgono Garibaldi; si combatte corpo a corpo; Missori scarica quanti colpi ha nel suo revolver ed uccide quanti tentano appressarsi al generale; Statella lo difende a colpi di sciabola, dando così tempo ai garibaldini di accorrere al soccorso.
Ma gli ostacoli sono insuperabili; gl'immensi canneti e le boscaglie di fichi d'India sparsi su quella riva impedivano ai garibaldini di far uso delle baionette, terribile arma loro prediletta, e favorivano i tiri dell'artiglieria borbonica. Per fortuna in quel momento apparve nella rada un vapore con bandiera italiana. Era la corvetta napoletana "La Veloce" che il comandante Anguissola, dando primo l'esempio della rivolta, aveva consegnata a Garibaldi, il quale la battezzava col nome di "Tuckery" in memoria del prode maggiore ungherese morto alla presa di Palermo. Il generale, senza perdita di tempo, si fa portare a bordo, e salito sulla coffa dell'albero di trinchetto domina tutto il teatro della battaglia; ordina al comandante d'accostarsi a tiro di mitraglia ed al momento opportuno fa fulminare di fianco le truppe borboniche, e ne fa strage tale che il nemico è sgominato in brev'ora.
Questo felice diversivo dà tempo al Medici ed al Cosenz di riordinare i loro battaglioni e prepararsi ad un decisivo assalto.
Garibaldi scende a terra dal Tukery con un manipolo di marinari armati, si mette alla testa dei suoi e si riprende l'assalto; tutte le riserve sono impegnate: il maggiore Guerzoni arriva esso pure coi suoi a passo di corsa; un'ultimo disperato assalto è ordinato, i canneti a sinistra, il ponte di Curiolo di fronte, le case di destra, terribili strette, sono tutte superate con indicibile valore; i cacciatori del Bosco rispondono con un fuoco infernale e recano ai nostri danni non lievi; il capitano Leardi, dopo aver veduto cadere attorno a sè non pochi dei suoi valorosi è ferito a morte; il Costa, lo Statella, il Martini, il Cosenz feriti; ma il nemico è in fuga e dopo del nemico i garibaldini entrano in Milazzo e i borbonici si rinchiudono nel forte.
La battaglia di Milazzo fu la più sanguinosa tra quelle combattute delle armi garibaldine nel 1860.
Su quattromila combattenti garibaldini, più di settecento restarono sul campo fra morti e feriti.
La giornata del 21 passò in entrambi i campi tranquilla, le nostre truppe riposarono, e quelle borboniche il 22 s'imbarcarono su tre navigli francesi per essere trasportate a Napoli.
Il 23 arrivavano nelle acque di Milazzo quattro navi da guerra napolitane; ma visto che i garibaldini erano padroni della piazza si limitarono ad imbarcare il presidio del Castello; sicchè il Castello, con cannoni, munizioni ed ogni attrezzo di guerra, rimaneva in potere di Garibaldi, che vi faceva inalberare la bandiera tricolore.
Dopo la presa di Milazzo anche le truppe che occupavano la cittadella di Messina si arresero. – Tutta la Sicilia era liberata!
Occorreva pensare al passaggio dello stretto ed alla continuazione della marcia gloriosa per le Calabrie alla capitale del Reame di Napoli, e primo pensiero del Duce fu quello di nominare comandante militare e civile di Messina l'illustre patriota Nicola Fabrizi, con suo Capo di Stato Maggiore il valoroso Abele Damiani.
Questo venerando patriota aveva organizzato a Malta un corpo d'italiani volontari del quale faceva parte il Pittaluga, che dopo lo scontro infelice di Grotte, sostenuto dal Zambianchi contro forze superiori papaline, aveva preso passaggio in un vapore delle Messaggeries per raggiungere Garibaldi in Sicilia; col Pittaluga erano il Civinini, il Pedani livornese, ed altri.
Sbarcato il Fabrizi in Sicilia ebbe ordine da Garibaldi di recarsi a Barcellona per organizzare e prendere il comando dei battaglioni dell'Etna composti di patriotti siciliani. Il governo civile e militare di Messina era quindi affidato a buone mani.
Il passaggio sul continente non era cosa delle più facili; bisognava vincere le difficoltà che venivano dal Ministero in seguito alle pressioni dell'imperatore dei francesi; bisognava inoltre deludere la vigilanza della flotta nemica che giorno e notte batteva il mare e sorvegliava lo stretto senza contare che il Borbone, nonostante le defezioni, poteva sempre mettere a fronte di Garibaldi un Esercito organizzato di 100 mila uomini. Era necessario quindi fare uso di quegli audaci colpi di mano, nei quali Garibaldi era maestro.
Infatti la sera dell'8 agosto egli ordinava al Mussolino, calabrese, di tentare con un limitato numero di volontari scelti fra i più audaci, come Missori, Alberto Mario, Vincenzo Cattabeni ed altri valorosi, la sorpresa del forte Cavallo e la insurrezione della Calabria. La sera dopo ordinava a Salvatore Castiglia di sbarcare nell'Alta Fiumana con arditi garibaldini.
Persuaso Garibaldi, dopo quindici giorni di vani tentativi, della difficoltà del passaggio dello stretto di Messina, causa l'esiguità delle sue forze, ed avute notizie dal Bertani che in Sardegna stavasi organizzando una legione di circa 8 mila bene armati sotto la direzione del colonnello Pianciani, col proposito d'invadere lo Stato Pontificio, convinto che su Roma si poteva marciare con più sicurezza per la via di Napoli, deliberava di portarsi egli stesso al Golfo degli Aranci per assicurarsi il concorso degli ottomila uomini coi quali avrebbe raddoppiato il numero delle sue forze. Non tardò a mettersi in viaggio ed appena arrivato si presentò d'improvviso a quella gioventù che anelava al combattimento; vinse col fascino delle sue parole gli scrupoli di qualcuno e, preso il comando di quelle truppe, se le trasse seco in Sicilia.
Date le disposizioni opportune per il governo dell'Isola – nominò Depretis Prodittatore e partì per Messina.
Prima di lasciare Palermo il Generale emanava l'ordine del giorno seguente:
Alle Squadre Cittadine!
"A Voi robusti e coraggiosi figli dei campi, io dico una parola di gratitudine in nome della patria italiana, a Voi che tanto contribuiste alla liberazione di questa terra, a Voi che conservaste il fuoco sacro della libertà sulle vette dei vostri monti, affrontando, in pochi e male armati, le numerose ed agguerrite falangi dei dominatori.
"Voi potete tornare oggi alle vostre capanne colla fronte alta, colla coscienza d'aver adempiuto ad opera grande! Come sarà affettuoso l'amplesso delle vostre donne inorgoglite di Voi, accogliendovi festose nei vostri focolari! e Voi racconterete superbi ai vostri figli i perigli trascorsi nelle battaglie per la santa causa dell'Italia.
I vostri campi, non più calpestati dal mercenario, vi sembreranno più belli, più ridenti. Io vi seguirò col cuore nel tripudio delle vostre messi, delle vostre vendemmie, e nel giorno in cui la fortuna mi porgerà l'occasione di stringere ancora le vostre destre incallite, sia per narrare delle nostre vittorie o per debellare nuovi nemici della patria, Voi avrete stretto la mano di un fratello.
Palermo, 3 giugno.
G. Garibaldi.Il generale Sirtori aveva già assicurati due vapori, il "Torino" ed il "Franklin", che faceva trovar pronti nel porto di Taormina. Senza perdita di tempo, appena arrivato a Messina, Garibaldi ordina a Bixio, che tanto aveva sospirato quel comando, di mandare tutta la sua gente a Taormina (circa 4000 uomini) e d'imbarcarla sui due piroscafi. Bixio, che tutto aveva approntato per il passaggio dello Stretto, imbarcate le sue truppe, monta sul "Torino"; Garibaldi, arrivato in carozza da Messina, sale sul "Franklin" e nella notte del 19 di agosto, levate le ancore partono per la Calabria, ed allo spuntar dell'alba del 20 i due vapori si accostano a Melito tra Capo dell'Armi e Spartivento. Disgraziatamente nel prendere terra il "Torino" rimaneva arenato, ma non per questo venne ritardato lo sbarco a terra delle truppe garibaldine che fu effettuato senza contrasto; solo più tardi le navi da guerra napolitane in crociera se ne accorsero e presero a bombardare il "Torino" vuoto.
Bisognava impadronirsi con un colpo di mano di Reggio; e senza esitare il generale Garibaldi ordina di muovere all'assalto, e la sera del 20 i garibaldini ripresero la marcia. Ad una certa distanza dalla città il Generale faceva obbliquare a destra e per sentieri remoti, evitando gli avamposti nemici appostati sullo stradale, e guidato dal colonnello Plutino si avvicinava alla piazza. Fatti riposare i volontari e disposto che la divisione Bixio dovesse assalire dalla parte di destra e quella di Eberhardt da sinistra, dopo forte resistenza i nostri s'impadroniscono della città ed obbligano i Regi a rinchiudersi nel Castello.
A Garibaldi importava d'impossessarsi del Castello, perchè aveva avuto notizia che una forte colonna nemica, comandata dal generale Briganti, marciava su Reggio. Fortunatamente la comparsa di Missori, coi suoi reduci dall'impresa del Forte Cavallo, fece credere ai Napoletani che erano rinchiusi, di essere accerchiati, per cui alle prime fucilate piovute dall'alto domandarono d'arrendersi.