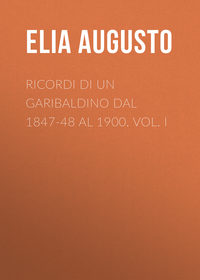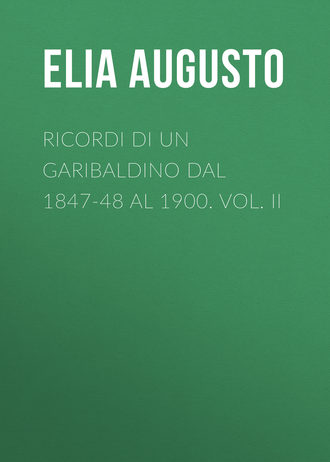
Полная версия
Ricordi di un garibaldino dal 1847-48 al 1900. vol. II
Ecco il proclama che il generale Garibaldi indirizzava al popolo Siciliano appena sbarcato a Marsala:
Siciliani,
"Io vi ho guidato una schiera di prodi, accorsi all'eroico grido della Sicilia. Resto delle battaglie lombarde, noi siamo con voi e non chiediamo altro che la liberazione della vostra terra. Tutti uniti, l'opera sarà facile e breve. All'armi dunque; chi non impugna un'arma è un codardo o un traditore della patria. Non vale il pretesto della mancanza delle armi. Noi avremo fucili, ma per ora un'arma qualunque ci basta, impugnata dalla destra di un valoroso.
"I Municipi provvederanno ai bimbi, alle donne ed ai vecchi derelitti. All'armi tutti! La Sicilia insegnerà ancora una volta, come si liberi un paese dagli oppressori, colla potente volontà di un popolo unito.
G. Garibaldi"Occorreva però non perdere tempo, e marciare avanti al più presto. Garibaldi comandò quindi che all'alba dell'indomani tutta la colonna fosse pronta alla partenza, ed infatti la mattina si metteva per la via di Salemi. A Rampagallo, feudo del Barone Mistretta, fu ordinato il grand'alto per pernottarvi. Fu in questa prima tappa, che si ebbero i primi segni dell'insurrezione siciliana, perchè vedemmo con gioia arrivare le bande comandate dai Baroni di S. Anna, e quelle del Barone Mocarta. Saranno stati un'ottantina, armati di schioppetti.
Intanto fu riordinata la Legione, già ripartita in otto compagnie; si formarono con esse due battaglioni ai comandi di Bixio e Carini, e si organizzò coi marinai del "Piemonte" e del "Lombardo" una compagnia di cannonieri.
Alla mattina seguente la colonna si rimetteva in via per Salemi, dove, dopo una marcia alquanto faticosa, arrivava accolta da grande festa di popolo, e al suono delle campane e di musica. Un vero delirio! A Salemi, il generale pubblicò il Decreto col quale per volontà dei liberi comuni di Sicilia, ed in nome di Vittorio Emanuele, Re d'Italia, assumeva la Dittatura.
Italia e Vittorio Emanuele.
"Giuseppe Garibaldi, comandante in capo l'armata nazionale in Sicilia, invitato dai principali cittadini e sulla deliberazione dei Comuni liberi dell'Isola, considerando che in tempo di guerra è necessario che i poteri civili e militari sieno concentrati nelle medesime mani, decreta di prendere la dittatura di Sicilia in nome di Vittorio Emanuele.
Salemi, 14 maggio.
G. GaribaldiAltre bande intanto arrivavano, comandate da Giuseppe Coppola e dal frate Pantaleo, che davano notizia che Rosolino Pilo e Corrao tenevano sempre la campagna e con una mano di prodi erano nelle alture di S. Martino, dominanti Monreale; si sapeva pure che verso Missilmeri mantenevansi, asserragliati sulla montagna, il La Porta, il Firmatari, il Piediscalzi, il Paternostro, e, cosa significantissima e per noi sorprendente, il clero faceva parte della rivoluzione e ne era il principale istigatore.
Ma il Borbone non stava inoperoso. Ordini erano stati dati al comando delle truppe di Sicilia, per arrestare la marcia dei garibaldini e distruggerli.
Infatti nella notte del 14 al 15 maggio Garibaldi aveva notizia che il generale Landi con un corpo di 3000 uomini ed artiglieria marciava su Calatafimi, e che a quella volta si era pure avviato il presidio di Trapani.
Le bande dei Picciotti non erano ancora giunte nel numero che il generale avrebbe desiderato. Era dunque da pensare bene se con lo scarso numero di volontari male armati, fosse prudente attaccare posizioni fortissime, coperte ai fianchi ed alle spalle e difese da truppe regolari armate da buone carabine e da artiglieria.
Non sarebbe forse stato più prudente consiglio trincerarsi in Salemi, occupare coi Picciotti le alture circostanti ed attendervi l'attacco?
Sì sarebbe potuto ricevere il nemico con una energica controffensiva e costringerlo alla ritirata; le bande avrebbero avuto tempo di formarsi numerose ed accorrere in aiuto, attaccando il nemico alle spalle.
Ma Garibaldi era impaziente di misurarsi col nemico; sentiva nell'animo che una vittoria gli era necessaria; senza di che tutto sarebbe stato compromesso e, forse, tutto perduto.
Non era dunque il caso di attendere il nemico a Salemi; bisognava andargli incontro audacemente, romperlo e sloggiarlo ad ogni costo da Calatafimi.
E così fu deciso.
La posizione nella quale eransi accampati i napolitani, chiamata fin dall'epoca romana "il Monte del Pianto" era forte per se stessa, perchè mentre impediva un rapido attacco, offriva validissimo riparo alla difesa.
Da Vita, villaggio che si erge su di un poggio a cinque chilometri circa da Salemi, Garibaldi dispose che le bande Siciliane che sopraggiungevano e si andavano raccogliendo, si distendessero il più diffusamente possibile sul dorso delle colline a destra e a sinistra della strada, mostrandosi sempre pronte alla pugna. Dopo questo spiegamento Garibaldi ordinava la marcia in avanti della colonna, con la sinistra in testa.
Precedeva Carini con l'ottava compagnia cui tenevano dietro la settima, la sesta e la quinta; al centro marciava l'artiglieria i cui avantreni consistevano in carri comuni a due ruote; poi alcuni volontari del genio, e i marinari del Piemonte e del Lombardo. Seguiva il battaglione Bixio con le altre quattro compagnie.
Durante la marcia Garibaldi si spingeva in avanti con alcune sue guide, avendo al fianco il capitano Menotti suo figlio, il capitano Schiaffino ed il maggiore Elia, i quali non avendo voluto accettare comandi, formavano la guardia del corpo del generale. Osservata la posizione del nemico, che, colla sua linea di cacciatori coronava l'altura del "Pianto", senza indugio inviava ai suoi l'ordine di schierarsi sulle pendici di Monte Pietralunga e sulla strada.
Egli aveva appena le forza di un battaglione sul piede di guerra, e dovette disporlo secondo esigeva il terreno, lo scarso numero dei suoi e la posizione formidabile del nemico.
Stabilì quindi un ordinamento profondo e rado in linee successive; i Carabinieri Genovesi in prima linea dietro ripari naturali; poi stese l'ottava e la settima compagnia in cacciatori colle squadriglie a brevi intervalli sul versante dell'avvallamento che separava la sua posizione da quella nemica e le teneva nascoste nel grano già alto; in seconda linea stavano le altre due compagnie 6a e 5a, pure in ordine rado, quasi sul ciglio; ed a rovescio del ciglio aspettava il battaglione di Bixio in riserva.
Questo schieramento si fece in ordine mirabile.
Da una parte e dall'altra delle alture apparivano secondo l'ordine di Garibaldi, sui verdi dossi gli insorti siciliani, che per entusiasmo sparavano i loro fucili e mandavano alte grida di guerra, che si ripercuotevano minacciose per le lontane campagne.
Questa apparizione, nel momento in cui si stava per venire alle mani, dovette certo, come aveva preveduto il generale, produrre sgomento e depressione nell'animo delle truppe napoletane, mal disponendole alla battaglia.
Verso il mezzogiorno parve che il nemico accennasse ad un serio attacco. I suoi sostegni si avvicinarono alla linea dei cacciatori, la quale cominciò a spiegarsi, scendendo per la costa del monte del Pianto. Per giungere fino a noi, doveva toccare il fondo del Monte, passare la convalle e rimontare la china verso l'altura di Pietralunga. Garibaldi avrebbe avuto grande vantaggio nell'attirare il nemico in basso, attendendolo a piè fermo nella posizione occupata dai suoi; egli veniva a paralizzare così la superiorità delle sue armi da fuoco e al momento opportuno, che egli avrebbe saputo ben cogliere, avrebbe potuto rovesciare addosso ai Napoletani le forze garibaldine coll'impeto irresistibile dell'attacco alla baionetta. A questo intento Garibaldi ordinò ai suoi di star tranquilli, distesi a terra e di non sparare alcun colpo.
Ma l'offensiva dei napoletani fu un lampo passeggiero e si arrestò poco dopo iniziata; invece di un attacco a fondo, essi si limitarono a mandare qualche colpo di fucile, le cui palle fischiarono alle orecchie dei garibaldini come un eccitamento del quale essi non avevano davvero bisogno. Ma non si doveva rispondere, bisognava mordere ancora il freno!
Intanto Bixio, di cui è da immaginarsi l'impazienza di venire alle mani, venne a spiegarsi a sinistra di Carini col suo battaglione su due linee, completando l'ordine di battaglia con dinanzi i Carabinieri Genovesi, all'ala destra, Bixio alla sinistra; Orsini sulla strada colla sua microscopica artiglieria. Garibaldi intanto con a fianco Turr suo aiutante di campo e Sirtori capo di Stato Maggiore, stava spiando il più fuggevole dei momenti tattici; quello che decide sempre della vittoria.
Vedendo che il nemico non si spingeva all'attacco desiderato, ma rimaneva immobile, egli ordinò si suonasse la sveglia, sperando che questo segnale servisse a scuoterlo. L'effetto prodotto da quel suono di tromba fu affatto contrario; quei napoletani che si erano spinti avanti in catena batterono tosto in ritirata; e fu quello il momento in cui Menotti Garibaldi, Schiaffino con la bandiera in pugno (una bandiera da lui improvvisata a bordo del Piemonte, e non già quella che la città di Montevideo donava alla Legione comandata dal generale Garibaldi) e l'Elia si lanciarono dietro ai fuggenti, seguiti dai Carabinieri Genovesi che formavano la prima linea. Fra i cacciatori del Landi fuggenti, i tre garibaldini erano con essi montati sulla banchina, fortissima posizione del nemico: Schiaffino colla bandiera, Menotti Garibaldi, Elia. Quello che accadde fu cosa di brevissimi istanti. L'eroico Schiaffino veniva crivellato di ferite; Menotti Garibaldi, che lo vide vacillare e sul punto di cadere, afferrava tosto la bandiera, ma veniva colpito alla mano; Elia che era già stato sfiorato al petto da una puntata di baionetta, con pensiero rapido e più rapidamente eseguito, afferrava il suo caro amico Menotti e la bandiera che egli teneva stretta nella mano sanguinante, e con lui abbracciato si lasciava cadere al di sotto della banchina; disgraziatamente l'asta impugnata da Menotti venne giù dalla banchina, ma il drappo della bandiera restava sul campo nemico.
A ridosso della banchina stavano i carabinieri genovesi che prendevano flato, per poi riprendere l'assalto.
Caduti dall'alto i due si trovarono vicini a Froscianti, il carissimo, fidato amico del generale Garibaldi, che appena veduto Elia, gli domandava cartucce avendo egli finito le sue. Nel voltarsi verso di lui, Elia vide il generale Garibaldi che col solito sangue freddo camminava verso la formidabile posizione nemica vomitante fuoco e dalla quale poteva essere distante non più di cinquanta metri. Il pericolo che il generale correva fece correre un brivido per le ossa ai presenti; ed Elia si slanciava rapidamente verso lui, gridandogli con disperazione "Generale, se una palla vi colga tutto è perduto e con Voi la unità della patria nostra;" ma egli, calmissimo, procedeva in avanti. Con la fronte rivolta al nemico. Elia, che gli camminava a fianco, stava in indicibile angoscia pronto ad ogni evento, quando infatti vide un cacciatore borbonico abbassare l'arma e puntarla alla direzione del generale. Elia non ebbe che il tempo di fare un passo avanti alla persona di Garibaldi; un terribile colpo alla bocca lo rovesciava ed egli cadde a terra supino; coll'aiuto del generale che si era chinato su lui per dirgli un'affettuosa parola "Coraggio, mio Elia di queste ferite non si muore" egli potè volgersi bocca a terra e scampare l'imminente pericolo di essere soffocato dal sangue.
Intanto i napoletani fulminavano i nostri; in quel momento arrivava Bixio a spron battuto; parlò a Garibaldi brevi parole: e fu inteso il generale rispondere "No, Nino, qui si vince o si muore" e puntata la sua spada alla direzione della sempre formidabile posizione nemica, con tonante parola gridò: "Avanti ancora questo assalto o figlioli e la vittoria è nostra" e ordinata la carica si slancia per primo sull'erta, seguito da tutti i compagni che non erano caduti; e quel pugno d'uomini, trafelati, pesti, insanguinati, sfiniti da tre ore di corsa e di lotta, con nuova lena riprende la sua ascesa micidiale rigando ancora ogni palmo dell'erta terribile di altro nobile sangue, risoluti all'estremo cimento.
Come l'eroe aveva preveduto, la vittoria fu nostra. Incalzati di fronte da quello stuolo di indemoniati che parevano uscissero dalla terra, sgomenti dall'improvviso rombo dei nostri cannoni che il bravo Orsini era riuscito a portare in linea, turbati dal clamore crescente delle squadre siciliane sui loro fianchi, disperando ormai di poter vincere, voltarono le spalle, abbandonando il monte tanto fieramente contrastato e non si arrestarono che dentro Calatafimi.
Il miracolo era compiuto – la giornata era vinta! – La vittoria di Calatafimi fu incontestabilmente decisiva per la campagna del 1860 e per l'unità della patria – decisiva sopratutto indiscutibilmente, nel senso morale – perchè dalla giornata di Calatafimi la superiorità della Camicia rossa sulle truppe borboniche fu immensamente stabilita. – "Aiuto e pronto aiuto" telegrafava a Palermo la stessa sera del 15 il generale Lanza: ma poi credette miglior partito una precipitosa ritirata anche da Calatafimi.
Ecco come un eroe dei mille Giuseppe Cesare Abba, descrive nel suo aureo libro "da Quarto al Volturno" la gloriosa giornata di Calatafimi:
"Già tutta l'erta era ingombra di caduti, ma non si udiva un lamento. Vicino a me il Missori, comandante delle guide, coll'occhio sinistro tutto pesto e insanguinato, pareva porgesse orecchio ai rumori che venivano dalla vetta, d'onde si udivano i battaglioni muoversi pesanti, e mille voci, come flotti di mare in tempesta, urlare a tratti: "Viva lo Re".
"Frattanto i nostri arrivavano a ingrossarsi, rinascevano le forze. I capitani si aggiravano fra noi confortandoci. Sirtori e Bixio erano venuti a cavallo fin lassù.
"Sirtori, impassibile, colla frusta in mano, pareva non si sentisse presente a quello sbaraglio; eppure sulla sua faccia pallida e smunta io lessi qualcosa, come la volontà di morire fra tutti noi.
"Bixio compariva da ogni parte, come si fosse fatto in cento; braccio di ferro del generale. Lassù, lo rividi vicino a lui un altro istante.
" – Riposate, figliuoli, riposate un poco, diceva il generale – ancora uno sforzo e sarà finita! E Bixio lo seguiva fra le file.
"In quello il sottotenente Bandi veniva a salutarlo lì, per cadere sfinito. Non ne poteva più. Aveva toccate parecchie ferite, ma un'ultima palla gli si era ficcata sopra la mammella sinistra, e il sangue gli colava giù a rivi. Prima che passi mezz'ora sarà morto, pensai; ma quando le compagnie si lanciarono all'ultimo assalto, contro quella siepe di baionette che abbagliavano, stridevano, sì che pareva di averle già tutte nel petto, tornai a vedere quell'ufficiale fra i primi. "Quante anime hai?" gli gridò uno che deve essergli amico.
"Egli sorrise beato.
"In quel momento i regi tiravano l'ultima cannonata, fracellando a bruciapelo un Sacchi pavese; e fu da quella parte un grido di gioia perchè il cannone era preso. Poi corre voce che il generale era morto, e Menotti, ferito nella destra, correva gridando e chiedendo di lui. Elia giaceva ferito a morte; Schiaffino, il Dante da Castiglione di questa guerra, era morto, e copriva colla sua grande persona la terra sanguinosa.
"Quando, i nemici cominciarono a ritirarsi, protetti dai loro cacciatori, rividi il generale che li guardava e gioiva.
"Gli inseguimmo un tratto; disparvero. Dal campo stemmo a vedere la lunga colonna salire a Calatafimi, grigia lassù a mezza costa del monte grigio, e perdersi nella città. Ci pareva miracolo aver vinto.
"O gran giorno, o immortali quelle tre ore del combattimento! Ma se fosse stato perduto? Si accapriccia il cuore, immaginando Garibaldi vinto, i suoi a squadre, a gruppi, rotti, messi in caccia, uccisi per tutta quella terra da Calatafimi a Salemi, lontano, lontano; gli ultimi ad uno ad uno, chi qua chi là, scannati come fiere, fin sulle rive del mare; e la testa del generale mandata a Napoli; che la potesse vedere e finire di tremare quel Re! Si raccapriccia. E forse l'Italia non si sarebbe fatta mai più.
"Felici allora, ben felici i morti combattendo, che almeno non avrebbero visto la grande tragedia.
"Ma per fortuna d'Italia la vittoria fu nostra".
Sgominato il nemico, conquistata Calatafimi, chiave della posizione, ormai si era padroni delle tre vie conducenti a Trapani, a Castellammare, a Palermo. Ulteriore resistenza non era pel momento da prevedersi, ed inutile era anche l'inseguimento da parte dei garibaldini, perchè ad infastidire i fuggiaschi vi avrebbero pensato i bravi insorti siciliani.
Garibaldi pensò di dare un po' di riposo ai suoi, e volle che si passasse la notte sul conquistato campo di battaglia.
Le perdite nostre furono gravi rispetto al numero esiguo che rendeva prezioso ogni individuo; bisognava quindi aver cura dei feriti.
Trentadue dei mille rimasero sul terreno, fra i quali Schiaffino, Montanari, Pedotti, Sartori, D'Amicis; centottantadue i feriti fra i quali, Menotti Garibaldi, Elia, Maiocchi, Sirtori, Manin, Nullo, Missori, Cariolato, Bandi, Martignoni, Perducca, Palizzolo, Sprovieri, Bedischini, Carbonari, Pasquinelli, Della Torre, Della Casa, molti dei quali gravemente.
La mattina del 16 i garibaldini entrarono a Calatafimi fra gli evviva e le acclamazioni del popolo.
Posto il quartier generale al palazzo del Comune, Garibaldi emanava il seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNODOPO LA BATTAGLIA DI CALATAFIMI:"Con compagni come voi io posso tentare ogni cosa, e ve l'ho provato ieri portandovi ad una impresa ben ardua, pel numero dei nemici e per le loro forti posizioni.
"Io contavo sulle fatali vostre baionette, e vedeste che non mi ero ingannato.
"Deplorando la dura necessità di dover combattere soldati italiani, noi dobbiamo confessare che trovammo una resistenza degna di uomini appartenenti ad una causa migliore, e ciò conferma quanto sarem capaci di fare nel giorno in cui l'italiana famiglia sarà serrata tutta intorno al vessillo di redenzione.
"Domani il continente italiano sarà parato a festa per la vittoria dei suoi liberi figli e dei nostri prodi siciliani; le vostre madri, le vostre amanti, superbe di voi, usciranno nelle vie colla fronte alta e ridente.
"Il combattimento ci costò la vita di cari fratelli morti nelle prime file; quei martiri della santa causa d'Italia saranno ricordati nei fasti della gloria italiana.
"Io segnalerò al nostro paese il nome de' prodi che sì valorosamente condussero alla pugna i più giovani ed inesperti militi, e che conduranno domani alla vittoria, nel campo maggiore di battaglia, i militi che devono rompere gli ultimi anelli delle catene, con cui fu avvinta la nostra Italia carissima.
Calatafimi, 16 maggio.
Scrisse poi a Bertani la seguente lettera:
Caro Bertani,
Ieri abbiamo combattuto e vinto. La pugna fu tra italiani. Solita sciagura – ma che mi provò quanto si possa fare con questa famiglia – nel giorno che la vedremo unita.
Il nemico cedette all'impeto delle baionette de' miei vecchi Cacciatori delle Alpi vestiti in borghese; ma combattè valorosamente – e non cedette le sue posizioni che dopo accanita mischia corpo a corpo.
I combattimenti da noi sostenuti in Lombardia furono certamente assai meno disputati che non fu il combattimento di ieri; i soldati napolitani, avendo esaurite le loro cartucce, vibravan sassi contro di noi, da disperati.
Domani seguiremo per Alcamo; lo spirito della popolazione si è fatto frenetico, ed io ne auguro molto bene per la causa del nostro paese.
Vi daremo presto altre notizie. Vostro:
Calatafimi, 16 maggio.
P.S. Questa serve per Medici pure.
Della battaglia di Calatafimi Garibaldi con parola commossa così ne parlava:
"Calatafimi! Io avanzo di tante pugne – se nell'ultimo mio respiro i miei, vedranmi sorridere, l'ultimo sorriso d'orgoglio – esso sarà ricordandoti!"
"Tu fosti il combattimento più glorioso di popolo! L'Italia non deve dimenticarlo".
Disfatte le truppe napolitane a Calatafimi, in quell'eroico combattimento nel quale si decise dell'unità della patria, Garibaldi comprese che bisognava battere il ferro finchè caldo, e marciare su Palermo. Era assai arduo affare, ma che cosa tratteneva più Garibaldi? Si trattava ne più ne meno di questo; mettere assieme strategia ed audacia per assalire con circa 4000 armati, tra i rimasti dei mille ed i picciotti, ed impadronirsi d'una città che conteneva trentamila difensori, appoggiati ad una fortezza e sorretti da una squadra regia. Garibaldi tentò il colpo.
Il 17 marciava su Alcamo, il 18 per Partinico; nel medesimo giorno ordinava una conversione e giungeva al passo di Reune; fiancheggiavano Garibaldi a ponente le bande di Rosolino Pilo, a levante quelle del La Masa, un quattromila picciotti, male armati ma arditi e ben condotti. Per sopperire alla tenuità delle forze Garibaldi giuocò di astuzia; ordì un tranello nel quale il nemico cadde.
Il giorno 20, comandò e diresse egli stesso, una ricognizione su Monreale per attirarvi il nemico, e manovrò in modo da far credere che quello era il suo obbiettivo. Impegnato un combattimento d'avamposti, ad un tratto faceva sospendere l'attacco e si ritraeva indietro.
Nella notte, imperversando una violenta tempesta, prendeva sentieri di montagna battuti solo da capre e volgeva a levante, lasciando Orsini con le salmerie ed i cannoni a farsi inseguire dalle truppe borboniche. Egli, di sorpresa, scendeva al Parco e batteva una colonna nemica che lo aveva assalito di fronte; colà il generale Orsini coll'artiglieria lo raggiungeva. Il 24 le truppe borboniche, fiancheggiate da forti colonne di cacciatori attaccavano i nostri. Garibaldi batteva in ritirata su Piana de Greci mentre era già sera. Nella notte ordinava ad Orsini di prendere la strada di Corleone per attrarre le forze nemiche; egli marciava silenzioso su Marineo, quindi lasciava Marineo per Missilmeri e, mentre le truppe napolitane inseguivano quelle che credevano le forze garibaldine condotte in ritirata dall'Orsini, Garibaldi, spalleggiato dalla parte di levante dai picciotti del La Masa, si preparava a dare l'assalto a Palermo.
La mattina del 26, alle 4, accompagnato da Turr, Bixio e Missori, andò a visitare il campo di Gibilrossa, occupato dalle squadre siciliane comandate da La Masa, Fuxa e fratelli Mastricchi, formanti un corpo di oltre 4000 uomini.
Garibaldi per avvicinarsi a Palermo aveva due grandi strade, ad una delle quali si poteva giungere per stretti sentieri e La Masa, pratico dei luoghi informò il Generale che da Gibilrossa poteva discendere benissimo calando per quei sentieri praticabili sino a Mezzagno, da dove con altro poco cammino faticoso si poteva trovar presto sulla strada di Porta Termini. Garibaldi, dopo brevi riflessioni, decideva di battere questa via e dava ordine a Turr di fissare la marcia per l'indomani di primo mattino e che veniva ordinata così:
1o l'Avanguardia comandata dal maggiore Tuköry, composta di guide e di 60 volontari dei Mille, scelti da ciascuna compagnia.
2o Il battaglione Bixio coi carabinieri genovesi.
3o Il battaglione Carini, cacciatori delle Alpi.
4o Il corpo delle squadre siciliane, comandate da La Masa.
Disposta in tal modo la colonna Garibaldi, fatti chiamare i suoi ufficiali superiori, i comandanti le compagnie, e i capi delle squadriglie parlò loro così: "Compagni! Due vie abbiamo avanti a noi: una è di ritirarci nell'interno dell'Isola facendo la piccola guerra per organizzarci; l'altra è di piombare su Palermo, entrarvi, accendervi la rivolta: sicuri che quest'ultima impresa darà per risultato la liberazione dell'intera Sicilia. "Decidete!" – A "Palermo", tutti gridarono. – "Ebbene, che ognuno faccia il suo dovere e domattina vi saremo!"
Alle 3 antimeridiane del 27 maggio – data memoranda – Garibaldi col resto dei suoi Mille comandati da Bixio, da Carini, da Cairoli, da Tuköry, da Menotti, da Mosto, da Nullo, da Canzio, da Dezza, da Cucchi sui quali sapeva di poter contare fino alla morte, spalleggiato fortemente dai Picciotti del La Masa e del Fuxa, come aveva predetto, si preparava ad assalire Porta Termini e da quella entrare in Palermo.
Era intendimento del generale di sorprendere la posizione del Ponte dell'Ammiraglio senza colpo ferire, ed in tal guisa piombare su Porta Termini, e di là spingersi al palazzo Reale dove trovavasi il Lanza, comandante in capo delle forze borboniche, col suo quartier generale. Tuköry colla sua avanguardia procedeva in silenzio per precipitarsi d'improvviso sul nemico, ma i Picciotti, tosto che videro le prime case del sobborgo, quasi avessero già in mano la città, non seppero frenarsi e presero a gridare Viva Garibaldi: Viva l'Italia; sparando delle schioppettate: così il piano di sorpresa andava fallito. I regi fortemente protetti da barricate, che difendevano e impedivano il passaggio del Ponte dell'Ammiraglio, spazzavano con un turbine di mitraglia e di moschetteria la via che vi conduceva e i campi d'intorno: – i Picciotti non ancora abituati al fuoco ed ai cimenti corpo a corpo, balenano per un momento, ma all'esempio dei mille che nulla paventano, serrati, concordi, disprezzanti della morte si slanciano, sperdono in men che si dica le truppe borboniche e, come un torrente impetuoso si avventano su Porta di Termini scacciandone i nemici, vincendone la resistenza: primi fra tutti Bixio, Carini, Sirtori, Turr, Fuxa, La Masa; già erano caduti fulminati, i prodi fra i prodi, Tuchöry, Rocco, La Russa, Pietro Inserillo e Giuseppe lo Squiglio assieme a tanti e tanti altri che ebbero la fortuna di fare la bella morte dei prodi; ebbero ferite più o meno gravi Turr, Benedetto Cairoli, Enrico Piccinini, Raffaello Di Benedetto, Leonardo Caccioppo; Bixio alla testa del suo bravo battaglione, coi carabinieri genovesi, con a fianco, Dezza, Menotti, Mosto, Missori, Canzio, Nullo, Carbone, Cucchi, Cavalli, Venzo ed altri bravi, a passo di corsa, con impeto furioso, attaccano ed espugnano la barricata di Porta Termini. Il Carbone, dei carabinieri genovesi, sale coraggiosamente per primo sulla barricata con la bandiera italiana in pugno e ne riporta ferita che non gli impedisce di continuare a combattere; per questo fatto il Carbone venne encomiato dal generale Garibaldi e promosso sottotenente.