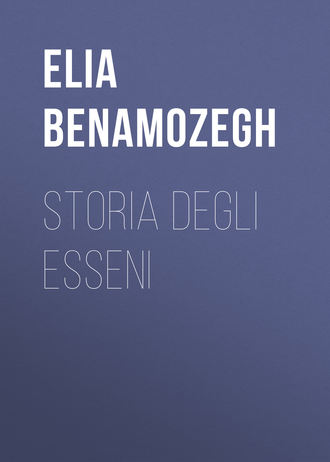
Полная версия
Storia degli Esseni
Io credo che non pochi insegnamenti abbiamo fin qui acquistato; abbiamo veduto tra gli antichi Nazirei e gli Esseni parecchi correre luminosissime attinenze, e tra ambedue altresì, e il sacerdozio costituito in Israele; abbiamo in tanta antichità rinvenuti parecchi degli elementi onde si formò di poi il nostro Essenato. Ma qui non finisce la vena feconda del Nazirato vetusto, qui non hanno fine i mirabili riscontri tra esso e’ moderni Nazirei che si chiamano Esseni. Solo che meglio vi piaccia la natura indagarne, solo che le frasi dei nostri Profeti, laddove dei Nazirei tolgono a ragionare, non vadano, come avviene, perdute nel torrente di una irreflessa e precipitosa lettura. Un passo principalmente vi ha di cui non si potrebbe ragionevolmente inforsare la importanza. Egli è il Profeta Amos quando rinfaccia ai coetanei suoi la ingratitudine onde ripagavano le insigni beneficenze di Dio, quando ricorda loro il portentoso riscatto, le spirituali divise con cui rivestilli, quando in ispecie ricorda i doni profetici, le fatidiche ispirazioni; quando esclama in nome d’Iddio, E pure io fui quello che i figli vostri costituiva profeti e i giovani vostri costitutiva Nazareni. Non è forse così, o Popolo d’Israel, dice il Signore? Ma voi che faceste? Voi propinaste ai Nazareni il vino conteso, ed ai profeti intimaste dicendo: Non profetate. O io m’inganno, o nuova sembianza è cotesta che assumono i Nazareni. Non solo gente sacra e quasi sacerdotale, siccome vedemmo, ma gente, si può dire arditamente altresì, gente profetica. Chi conosce il genio della lingua Ebraica, la replicazione del concetto, nelle due metà del versetto, le predilette sinonimie, il parallelismo frequentissimo, non porrà menomamente in dubbio che nella mente di Amos, Profeti e Nazireni, il vino dai Nazareni libato, e la esautorazione del Profetismo non si unificassero a dirittura in un solo concetto. Per chi è autonomo nei giudizi questo è d’avanzo. Per chi ama invece poggiare sulle autorità ne avremmo a citare di soverchio. Potremmo dire del Parafrasta Caldeo che con significantissima sostituzione pone invece della parola Nazireni il vocabolo Arameo Malfin che suona insegnatori; potremmo invocare il venerabile Rasci che tale ci offre definizione di cotesti del profeta, che più acconcia, più precisa, più completa non si potrebbe dare degli Esseni medesimi; quando dice cioè ch’erano i Nazirei separati dalle comuni costumanze, e tutti dediti alla legge di Dio. Potremmo dal labro pendere di Abenesra ove col consueto laconismo, ma altamente espressivo pel caso nostro, Nazirei dice che consacrai a riprendervi, a santificarvi. Potrei chiamare a testimonio l’Abrabanel che dice il Nazireato esser preparazione allo spirito santo, che aggiunge essergli stato il vino propinato onde lo spirito divino non scendesse sopra di essi, nè quindi potessero vaticinare.28 Or che cosa sarà s’io vi dicessi che gli Esseni andavano celebri per i loro vaticini e che non poche delle loro predizioni ci sono da Giuseppe riferite, siccome a suo luogo vedremo? Certo che vedreste allora nell’antico Nazirato, nelle doti profetiche di cui va insignito un elemento nuovo dell’Essenato moderno, una pietra nuova del grande edifizio, un preludio alle Esseniche predizioni: e che sarà poi se vi farò toccare con mano nuovi riscontri nelle circostanze più particolari della vita, nell’abito per esempio, nel regime tra l’Essenato e i Nazirei; il sacerdozio antico e il Profetismo? Certo non negherete che sarà un passo di più verso la mèta a cui aneliamo, il ritrovamento delle parti integrali, degli elementi del grande Istituto. Or bene, volete sapere degli Esseni l’abbigliamento? Mirate ai Profeti ed ai Nazirei; due luoghi vi sono aurei tutti e due, luminosi tutti e due per chi ha gli occhi per vedere, dove il costume esteriore ci vien dipinto, ma di volo con un sol tratto, di Profeti e di Nazirei. Costume uniforme dei Profeti, colà abbiamo, laddove predicando Amos il discredito in cui saria caduta l’ispirazione, tanto vil cosa aggiunge sarà reputata, che niuno vorrà simulare nemmeno il portamento esteriore di un Profeta, che niuno più addosserà un mantello peloso. – Chi ha orecchi ascolti: un mantello peloso, ecco dei Profeti la divisa, il destintivo. Che se non contenti di aver trovato, se così è lecito dire, dei Profeti il figurino, ne voleste uno proprio di carne e sangue in cotal foggia vestito, potrei io esitare un istante, potrei io non vedere sorgere immantinente ai miei sguardi il severo, l’ispido Elia, l’uomo come il descrive il sacro storico, l’uomo peloso, l’uomo dalla cintura pelosa, Elia il Jesbita; Elia il solo superstite tra i Profeti di Dio, Elia che al sol vederlo in questo arnese caratteristico esclamano tutti? Elia attisbi u?29 Ebbene mirate nell’autobiografia di Flavio Giuseppe ciò che del costume va esprimendo dei più rigidi tra gli Esseni, e mi saprete dire se troppo disforme da quello procedesse tra i profeti usitato. Ma i men rigidi, i più urbani tra gli Esseni come vestivano essi? Ah! egli è qui ove ritornano in campo non solo i sacerdoti come gli Esseni bianco vestiti, ma ciò ch’è più, ritornano in campo gli stessi Nazirei e un nuovo e parlante rapporto ci offrono colla società degli Esseni. È tal cosa la Scrittura, o miei giovani, che se uomo non tende l’orecchio del continuo a spiarne non ch’altro le più fuggevoli espressioni, gran parte sperpera, miseramente perduta, delle sue ricchezze. È un mondo che si rivela per cenni ed enigmi, è la figlia del Re, secondo la magnifica parabola Zoaristica, che solo rivela la faccia sua bellissima, dopo avere con ripetuti cenni ed ammicchi l’attenzione e l’ansia provocate del suo amadore.30 Testimone l’esempio che abbiam tralle mani. Chi avrebbe detto che la Bibbia contenesse perfino l’antico costume dei Nazirei? Eppure nulla di più esatto, la Bibbia lo contiene, in una locuzione, in una idea incidentale, ma pure lo contiene. Povero Geremia! Ei lamenta perdute tante cose e carissime! Ma non dimentica, credete per questo, cose di men rilievo, per esempio i bellissimi Nazireni e le loro vesti. Dove n’andaste, sclama nel dolor suo, Dove, o Nazareni dalle candidissime stole più della neve bianche, bianche meglio del latte? (Treni cap. IV, v. 7.) Perocchè glossa il venerando Rasci i Nazirei e i Farisei (notate questo contatto e ponetelo in serbo per altro tempo) i Nazirei e i Farisei mostravansi al di fuori tersi e puri colle bianchissime loro vesti, alla neve somiglianti, siccome alla neve si assimigliano le vesti dell’antico dei giorni, e siccome infine è costume dei Ilasidini; ed anche quest’ultima frase ponete in serbo, giovani miei. Ed ecco il costume degli Esseni, il costume dei più miti tra essi somministratoci dall’antico Nazirato, dal Nazirato consenziente anco in questo col sacerdozio ministrante nel tempio di Dio.31 Ma io dissi che negli antichi profeti un vestigio ritrovato avremmo della tavola degli Esseni, del regime degli Esseni. Dissi ben poco; doveva dire e la dietetica e la dimora e la scelta del luogo. Vi è un passo nel secondo dei Re ove la scuola dei profeti, i figli dei profeti come allor si dicevano, banchettando a cielo aperto ci permettono di osservare di che cosa si formassero le consuete imbandigioni. Io veggo primi rammentati i legumi; e legumi pure erano il cibo favorito nell’essenico refettorio, veggo radiche ed erbe qua e colà dai Profeti stessi raccolte su per i campi; ed erbe e radiche alternavansi talvolta negli essenici prandi. Che più? La scuola profetica abita non solo sotto il medesimo tetto, tralle stesse pareti, ma soggiorna eziandio lungi dall’abitato presso le rive del Giordano; e non sarebbe temerità s’io dicessi che non del tutto andò errato Gerolamo quando nelle frasi del testo intravide eziandio la costruzione di separate cellette.
Aveva io ragione di sperare larga suppellettile di elementi, di preludi, di presentimenti Essenici nella storia dei Nazireni, in quella del sacerdozio, in quella dei profeti che tanta parte offron pur essi della fisonomia dei Nazireni? Ma vi ha un’obbiezione che voi potreste fare e ch’io perciò appunto amo di prevenire. Potreste dire: il Nazirato era voto e vincolo; ma voto e vincolo a tempo, ch’è quanto dire era assai diverso dall’Essenato che una consacrazione importava la quale continuar doveva quanto la vita lontana. E benissimo vi apporreste se tra Nazirato ed Essenato non corresse a senso mio divario alcuno; se io dicessi le stesse forme, le stesse leggi essersi per tanto corso di secoli dall’uno all’altro tramandate senza alterazione alcuna. Ma ciò nè dissi nè poteva io dire in verità. Sebbene che dico? È egli poi vero che il voto dei Nazireni fosse sempre temporaneo come voi dite? Certo che così pensò e scrisse un uomo dottissimo il Munk nella Palestina. Ma con sua buona pace sia detto: il Munk s’ingannò a partito. Non solo la tradizione attesta il contrario, non solo esempi vi sono luminosissimi di Nazirato perpetuo, e basti citare i nomi famosi di Sansone, di Samuele, e nei tempi Rabbinici di Elena la pia Regina degli Adiabeni;32 ma sopratutto il testo stesso su cui pare il Munk affidarsi, se non dice aperto di un Nazirato a vita, non parla nemmeno di tempo, non prescrive termine, nè limitazione prefigge. Si dirà ancora che non vi fu Nazerato perpetuo? Io credo che la sua esistenza non possa revocarsi in dubbio, e quindi un nuovo elemento, un nuovo apparecchio emmi lecito intravedervi della grande e dotta congregazione degli Esseni.
Io non lascerò, o miei giovani, l’argomento dei Nazireni, anzi che non vi abbia fatto toccar con mano come oltre le regole, le leggi, le istituzioni, il nome stesso di Nazireno sinonimizzi mirabilmente con tutti quelli che in ogni tempo recarono gli Esseni, con tutta la ricca suppellettile di nomi con cui a senso mio furono contradistinti. Primo tra questi, e già in parte ve lo accennai altra volta, si è quello di Fariseo; nome che nella sua vastissima comprensione anco l’Istituto abbracciava degli Esseni siccome quello che dei Farisei era culmine ed apogeo. Or che vuol dire Fariseo? Vuol dire separato. E come direste separato nella lingua biblica, nella lingua della scrittura? Direste precisamente Nazir; col qual nome avrebbe qualificato Mosè i Farisei se al tempo suo fossero esistiti, in quella guisa che Farisei avrebbero potuto qualificare i dottori i Nazireni?33 Vi pare assai? Udite ancora. Io vi dissi altra volta e ve lo proverò in seguito, come speciale designazione degli Esseni fosse ai tempi Rabbinici il nome di Hasidim. Volete ora vedere i Hasidim trasformarsi in Nazireni? Certo che la metamorfosi vi parrà avventata. Pure nulla di più preciso se aprite il Talmud al primo di Nedarim. Dove leggerete questa confessione preziosissima; che i primitivi Hasidim solevano di frequente votarsi a Dio in Nazireni.34 Volete più? Certo che voi discretissimi non esigereste di più: ma pure proviamoci: proviamoci a recare il sinonimo di Nazir con Essena a quella evidenza che si può desiderare maggiore. Voi vedrete tra non molto come il Talmud, come i monumenti Rabbinici più antichi tracciano, siccome fu creduto finora sul conto degli Esseni, come questo silenzio formasse sempre argomento di legittima sorpresa per chiunque si facesse ad osservarlo, e come questo preteso silenzio, fosse creduto, fosse ammesso non solo dai dotti, dagli eruditi di ogni maniera, ma eziandio dai succedituri Rabbini, dai dottori che sursero e scrissero dopo il Talmud i quali quando ebbero contezza, strano a dirsi! per mezzo dei moderni scrittori della esistenza di un antica setta fra loro per nome Esseni, quando di essa ebbero come di peregrina e inaudita scuola a favellare, che nome credereste che gli apponessero? il nome di Nazireni! Tanto pareva loro confacersi agli Esseni l’antico nome di Nazireo, tanto al genio rispondere il genio, la vita, le leggi alle leggi e alla vita.
Un grande insegnamento emerge, se io non sbaglio, dalle cose dette sin quì, ed è questo: che senza ammettere una generazione diretta od omogenea, grande però, massima parte di tutti gli elementi che la vita composero e la esistenza dell’Essenato si trovano contenuti e come in germe rinchiusi in seno al Nazirato ed al Profetismo. Purità, sobrietà, dottrina, ispirazione, vita solitaria e cenobitica, costume, dietetica e persino il nome loro caratteristico. Si può dire per questo che tutte abbiamo le parti costitutive dell’Essenato? Io non oso dir tanto: vi ha un elemento nella organizzazione degli Esseni di cui traccia non solo nei Nazireni non si discopre, ma che pure ardua, se non impossibile impresa, sembra trovarne vestigia nella ebraica antichità; che dico? Che pare a dirittura contraddire alle leggi, ai costumi, allo spirito generale dell’Ebraismo. E questo è il Celibato. Il celibato fu egli dagli Esseni praticato? Ove sia stato praticato, ha egli radici, ha egli origine nel genio, nella storia, nel passato dell’Ebraismo? Io mi affretto a dirvi per ciò che concerne la prima dimanda, come il celibato fosse istituzione sì degli Esseni; non tale però che da tutti fosse egualmente praticata. Quando delle leggi loro favelleremo e del loro Istituto, vedremo come gravi restrizioni debbano accompagnare la divulgata sentenza che a tutti gli Esseni indistintamente attribuisce il celibato. Pure si praticò; e se non tutti come il più perfetto consideravanlo degli stati, certo che appo taluni era in grande onore. D’onde quest’onore? D’onde questa dissonanza dalla voce dei secoli che proclamava invece tra gl’Israeliti maledetto, infame il celibato? Ardisco dire che l’ebraica antichità non è sorda assolutamente al nostro dimando. Io vi so dire che certi fatti vi sono e certe frasi i quali attestano manifestissimo che se pel comune degli uomini, per le condizioni più comuni della vita sociale, lo stato coniugale è lo stato più onesto, più meritorio, più religioso, pure si dànno certi stati così sublimi, certi uomini così trascendenti, certi momenti così augusti, in cui la virtù della continenza, temporaria e passeggiera talvolta, si stende però altre fiate ad un epoca così vasta, e talvolta abbraccia così una vita intera, che male il nome si potrà contrastargli ed il carattere di Celibato. Quali sono questi fatti e questi precetti? Un occhio penetrante li scuopre a prima giunta nel gran campo delle scritture; una mente alquanto erudita li ritrova nel grande emporio delle Tradizioni. Ecco i Dottori cui amore stringe della vita speculativa, della vita ipermistica dispensati formalmente dal matrimonio: ma di questo non dirò di vantaggio, perciocchè non appartiene a rigore all’epoca delle origini. Ecco un colloquio interessantissimo tra il sacerdote di Nobbe e David che chiede cibo per sè e pei suoi. Ecco il sacerdote obbiettare come i sacri pani non potessersi offerire a coloro che da contatto donnesco non si fossero astenuti. Ecco David replicare essersi tutti da tre giorni serbati continentissimi. Ecco Giobbe che pria di bandire i Riti e il sacrifizio domestico, impone ai figli, apparecchiarvisi con rigorosa castità. Che più? Ecco il gran fatto, il fatto più culminante nella storia dell’Ebraismo, ecco la promulgazione della legge ed ecco ciò che impone Moisè? Egli comanda si separi ognuno dalla donna sua e tre giorni di severissima continenza li predispongano al condegno accoglimento della parola di Dio. Volete più? Vi ha una tradizione preziosissima certo non coniata in grazia dell’Essenato, ma che pure torna mirabilmente in acconcio pel caso nostro, e la tradizione riguarda Moisè. Si volle, si disse, che da quel punto in cui Dio fece suonare quelle parole sacramentali «Ed ora qui rimanti con me;» il gran profeta avesse letto nel volere divino l’obbligo di sequestrarsi da ogni carnalità e di vivere oggimai la vita dei Celesti, e le sole voluttà omai pregustare che il novello stato gli offriva nel consorzio di Dio.35 Che volete? Fosse consiglio della solitudine, fosse desio di scuotere a dirittura ogni polve terrena, fosse vaghezza di una perfezione superlativa, fosse persuasione di esquisita misticità, gli Esseni nostri, allo stato aspirarono eccezionale dei grandi uomini e dei grandi momenti nella vita dell’Ebraismo; aspirarono a fare una regola, una legge dell’anormale e dell’eccezione, agognarono ad ottenere del continuo quella istantanea elevazione in cui si tennero i santi antichissimi in breve ora del viver loro; e invece di libare un sorso della vita beata, vollero votare interamente la tazza. L’erezione dello stato eccezionale in regola inflessibile, del transitorio nell’immanente costituì tra gli Esseni il Celibato.36 Questi sono i germi, questa l’origine che ci offre la Bibbia. Quando parleremo della istituzione in se stessa, avremo un altro termine fecondissimo di raffronto, i Dottori e le Tradizioni; e il Celibato diverrà allora se occorre anco più comprensibile. Per ora noi abbiamo fornita parte non indifferente di nostra via, abbiamo notati, registrati nell’antichità Ebraica gli elementi dell’Essenato. Abbiamo descritta la embriogenia del grande Istituto. Otto giorni ancora e gli elementi disgregati, inorganici, impersonali diverranno un ente vivo, storico, parlante, organico, personale; in cui tutti o quasi tutti s’incarneranno i discorsi elementi. Noi possiamo dire oggi: questi sono gli elementi dell’Essenato. Noi potremo dire allora: questi sono degli Esseni i progenitori, gli antenati. Noi diciamo oggi, ecco le pietre, ecco i materiali: noi diremo allora, ecco la fabbrica, ecco il palagio, o almeno: ecco le fondamenta.
LEZIONE NONA
Se prepotente io non sentissi il bisogno di giungere più ratto che ci è dato a la mèta prefissa, la tela che noi andremo questa sera svolgendo troppo maggiore argomento ci offrirebbe che quello di una sola conferenza. Le cose che ho a dirvi sono molte, sono gravi, sono di grande momento, sono la ricostruzione storica dell’Essenato per tutti i tempi favolosi, incerti, storici della sua esistenza, sono la storia della sua incarnazione durante i lunghi secoli che precederono l’Essenato propriamente detto, egli è infine l’albero genealogico del grande istituto. Io stringerò il molto in brevissimi termini, io vincerò il desiderio che pur provo vivissimo di farvi assaporare di ogni parte il valore di farvi misurare sol collo sguardo gli amplissimi orizzonti che ad ogni tratto ci si schiuderanno dinanzi, nè a questo bisogno meglio che desiderio, verrei men di certo se io non contassi sulla vostra penetrazione, sul vostro acume. Supplite voi al manco del mio dire; intendete meglio che io non possa spiegami. Fecondate colla mente ingegnosa i dati che vi vado porgendo, indovinate quello che per brevità io taccio, andate più lungi colla mente di quel che a me sia conceduto lo andare colle parole; e sopratutto stringete tutte in un fascio le cose che sono per dirvi: sia la vostra mente un filo, anzi sia poderosissima catena che tutte unifichi le cose che sono per dire; alla seconda vi ricordate la prima, alla terza prima e seconda; nè giunga del mio dire la conclusione, senza che le precedenti cose vi stiano tutte dinanzi all’occhio della mente schierate, così io sarò breve senza pericolo, e voi istruiti sarete senza disagio.
Voi lo ricordate. Abbiamo trovato nelle passate conferenze gli elementi dell’Essenato, adesso ci è d’uopo trovare l’Essenato medesimo. Abbiamo veduto i suoi principii, adesso ci è mestieri vedere i suoi antenati; veduto abbiamo la storia delle sue idee, ci conviene adesso la storia studiare dei suoi precursori. Dove cercarla? Non vi dirò le laboriose investigazioni che emmi costata la costatazione di questa origine, la sua ordinazione, la sua confermazione. Voi stasera, o miei giovani, coglietene il frutto, ed il saperlo sarà il mio premio. Dove cercarla? Cercarla io dico colà ove l’origine si cerca di quanto vi ha di più nobile e venerando in Israele, dove si cerca l’origine della Reale Dinastia Davidica cioè nell’innesto di un ramo pagano sul ceppo ebraico,37 nella Moabita Rut che fu madre del Regno siccome leggiadramente chiamaronla i Dottori; dove si cerca l’origine di alcuno tra i Profeti stessi, siccome Obadia che di pagano che era si fece ebreo secondo i Dottori, dove si cerca l’origine dei più illustri tra i Dottori i quali pressochè tutti sortirono a confessione di loro stessi i natali da progenitori pagani: tra i quali si potrebbe citare per tutti il gran Proselita Onchelos, il più popolare tra tutti i Dottori. Cercarla infine tra i Pagani al Giudaismo conversi, cercarla nella nobil famiglia dei Proseliti. Perchè così abbia disposto il Signore, perchè non sia gentil pianta nell’ebraico giardino che un ramo non rechi innestato dell’agreste e selvatico Gentilesimo; troppo vorrebbesi lunga e protratta disamina perchè ci sia qui lecito il tentarla. Io domando solamente se l’Essenato deve al Proselitismo la sua origine, se in questo solo senso avvera l’opinione di coloro che gli Esseni dichiararon Pagani. Quale è tra i Proseliti che ricorda la Storia, il santo seme, onde poi allignò il rigogliosissimo albero? Io non so se ben m’apponga, ma io credo che il nome non vi riesca ignoto. Avete mai, o miei giovani, udito parlare di Jetro, di Jetrò il sacerdote di Madiani, il suocero di Mosè, il suo consigliere, lo approvato dal Signore, il primogenito tra i conversi, e secondo un antico Rabbino spagnuolo David di Leon, l’iniziatore di Mosè alla vita religiosa, alla propedeutica religiosa; tanto che se Mosè dir si può il padre di nostra fede, Jetrò se ne può dire l’avo? Io dissi primogenito tra i conversi e n’ho ben d’onde. Ho per me la tradizione che lo attesta, ho per me la formula quasi della sua abjura laddove all’udire il portentoso egresso di Egitto esclama ammirato: Ora sì riconosco che grande è l’Eterno al di sopra degli altri Dei. Ho per me l’atto istesso con cui al culto s’inizia nuovamente abbracciato, quando a Dio appropinqua olocausti ed ostie pacifiche, quando alla sacra mensa banchettan festanti assieme al Neofita, Mosè, Aronne e gli anziani tutti d’Israele; ho per me l’onore unico da nessun altro partecipato, tranne Jetro, di essere istitutore della Ebraica Magistratura, Dio consenziente non solo, ma encomiante; ho per me le parole mirabilissime di Mosè ove si confessa, quasi non dissi al grande suocero inferiore, quando cioè istantemente lo supplica di procedere seco lui per lo deserto, quando Jetro rifiuta dicendo: No, che solo al paese mio tornerommi e alla mia patria; quando senza lasciarsi ributtare al primo rifiuto torna Mosè e prega e scongiura, quando il titolo onorandissimo prodigagli il gran Profeta di suo duce, di suo conduttore e, secondo la forza dell’ebraico vocabolo, di occhio suo. Ho per me i dottori quando dicono che ridottosi al suo paese non quietò il gran Proselita sino a tanto che non ebbe il culto degli idoli estirpato dalla sua famiglia; e questo è Jetro, e questa è la sua conversione. Ma della sua famiglia altresì io parlai e della di lei conversione. Dove ne sono le prove? Parlai dei dottori e delle lor tradizioni, ma io doveva dire la scrittura, la Bibbia in quei fatti momentosissimi ove si fa parola della discendenza del gran Proselita, ove ti apparisce la sua figliolanza costituita veramente in società distinta, sì, ma pure dimorante in seno agli Ebrei, ove per gran fortuna possiamo passo a passo seguire le vicissitudini tutte dei Jetroiti, ove al tempo istesso che vi leggiamo la loro storia, una esatta dipintura ci si porge altresì della successiva, della lenta formazione di un dotto di un Religioso Istituto in quella famiglia. Io oso dire che non è senza una particolare provvidenza che la Bibbia ci ha serbato memoria di questo fatto, che di tratto in tratto ha deviato dal suo prescritto cammino per toccare delle fasi in vari tempi percorse dai discendenti di Jetro. Quali sono queste fasi? In qual guisa vi si può come in ispecchio mirare la secolare concezione dell’Essenico Istituto? Ecco il come ed ecco i fatti.
Ecco il libro dei Giudici che non appena pochi passi ha mutati nella sua narrazione, non appena alle conquiste ha esordito dopo Giosuè operate, esce fuora con queste parole: Ora i figli di Cheni suocero di Mosè trassero dalla città dei Palmizi coi figli di Giuda al deserto di Giuda che è posto a mezzodì di Arad, e andò e pose stanza appresso al popolo.– Che parole son queste e che significano? Se io non erro, non troppo vi saranno riuscite per ora accessibili. Però tranquillizzatevi; questa difficoltà non è in voi, è piuttosto nel testo istesso, è la mancanza di antecedenti che spianino la via alla sua intelligenza, è l’isolamento in cui il verso stesso si trova in seno al contesto, è quel piombare che ti fa subitaneo in sulla testa senza troppo sapere d’onde provenga, è quell’apparire istantaneo a guisa di lampo che pare scaturir di seno alle tenebre, per ricadere nelle tenebre, è quell’oscurità innanzi a cui resta perplesso, esitabondo ognuno comecchè erudito proceda nel sacro Idioma; nè se dovessi tutte le cause narrare di questa oscurità non saprei veramente venirne a capo. Però l’oscurità sentiamo, e la sentiamo gravissima; proviamo a diradarla. Si parla qui dei Cheniti, dei figli di Cheni. Chi sono i Cheniti? Sono certo Cheniti quei popoli di cui Dio accenna ad Abramo nella solenne promessa. Ma Cheniti sono, si chiamano pure i discendenti di Jetro, vuoi che Jetro appartenesse all’antico popolo dei Cheniti, siccome vuole il Munck, vuoi come meglio a parer mio opinarono il Gesenius, il Bohlen, il Tahu, come ad essi la tradizione consente, che Cheniti si dicessero da Jetro, appellato esso pure Cheni, vuoi finalmente che Cheni si dicessero da Chen nido, pel nido che facevano per campi e per selve siccome comprese il Zoar. Fatto è che i discendenti di Jetro si dicono Cheniti e che sotto il nome stesso ci si riveleranno in appresso i loro successori. Ma che cosa è la Città dei Palmizi? Città dei Palmizi è Gerico; Gerico chiamata negli ultimi versi del Pentateuco col nome istesso usato dai Giudici; Gerico situata poco lungi dalle sponde del lago Asfaltide. Ma in qual guisa li Jetroiti veggiamo stanziati in Gerico? Come dalla città lontanissima di Madian loro patria nell’Arabia Petrea, le orme seguirono di Israel sino nel cuore di Terra Santa? Nessuno lo spiega, e nessuno il narra, tranne la Tradizione. Ma quanto bene la Tradizione! Per la tradizione Jetro dopo i primi rifiuti, cesse finalmente alle istanze del divino Mosè. Jetro, i suoi figli, la sua famiglia ricovrarono all’ombra del popolo Ebreo, battagliarono nelle sue battaglie, trionfarono nei suoi trionfi e le piagge dilette vider pur essi della Cananea conquistata. Ma quale gli attendeva laggiù guiderdone? In qual guisa si sdebitarono gl’Israeliti della promessa Mosaica che Jetro voleva a compartecipe dei beni, delle terre acquisite? Coi suburbi, colle campagne di Gerico, dice la Tradizione; le quali terre dovuto avrebbero li Jetroiti serbare in custodia sino a tanto che fosse il Tempio edificato, e la metropoli destinata, la quale, proprietà nazionale dovendo essere meglio che tribunizia, mestieri pure era porgere alla Tribù spodestata una adeguata indennità, e questa doveva essere il territorio di Gerico, la stanza antica dei Jetroiti. Ma questi, voi lo vedeste, partiti da Gerico traggono altrove. Dove vanno? Vanno, dice il testo, nei deserti di Giuda che sono a mezzodì di Arad, e in mezzo al popolo fermano stanza. Che luoghi sono cotesti? Voi vedeste poc’anzi come Gerico fosse posta sulle rive o a quel presso, del lago Asfaltide. Or bene; il deserto di Giuda, Arad istesso, la nuova dimora dei Jetroiti, non piega sulla carta dalla linea contrassegnata, e l’epoca stessa gloriosissima di Debora troveralli abitare sui luoghi medesimi. Che monta ciò, potreste dire? Nol direste però se tutto aveste già ascoltato; nol direste se io vi mostrassi come gli Esseni di cui adesso cerchiamo l’origine, quegli stessi luoghi abitassero in tempi tanto più posteriori, che gli antichi Jetroiti occuparono in tempi così antichi; nol direste se vi ripetessi le parole di Plinio nel Cap. 17 del libro 5, laddove degli Esseni parlando, li qualifica Gens socia Palmarum, gente dei Dattolari amica, nè più celebre di Gerico e della riva del Giordano s’ebbe giammai in fatto a Palmizi; nol direste se vi mostrassi in Plinio stesso al luogo istesso, come la città ove ai suoi tempi abitavano gli Esseni fosse Engaddi, Engaddi posta essa pure sull’Asfaltide sulla linea stessa di Gerico e Arad, come vi mostra la carta, Engaddi famosa pur essa pei suoi Palmizj d’onde il nome derivolle più antico di Kazazon Tamar; nol direste finalmente se udiste Plinio istesso additarvi qual residenza altresì degli Esseni moderni Masada, città anch’essa meridionale di Palestina, anch’essa posta in riva all’Asfaltide, come di leggeri potete osservare nella Geografia del Dufour. Attalchè Gerico, Masada, Engaddi, Arad formano sulla carta una linea continuata che rasenta il Mar Morto, muove dall’ovest in direzione del Sud, e dove negli antichi e moderni tempi ebbero stanza gli Esseni ed i loro proavi Jetroiti. Ed a che fare traggono i Cheniti ad Arad? Ad abitare, dice il Testo, in mezzo agli Ebrei, a convertirsi, dice il Gersonide, definitivamente all’Ebraismo. E presso chi particolarmente riparano gli emigrati? presso Jahbez, dice la Tradizione, presso Jahbez, conferma la Bibbia nel 1º delle Cronache, come fra poco vedrete. Chi era Jahbez? Era Dottore, era Scriba, era Profeta, chè tutti e tre i caratteri solevano a quei tempi andare congiunti,38 ed alla Tribù dotta, massima, reina, apparteneva di Giuda; in cui doveva secondo l’antica benedizione perpetuarsi lo scettro, e l’oracolo promulgarsi della legge di Dio, a cui il titolo di maestra leggidatrice si concedeva nel libro dei Salmi; Jehuda mehokeki in cui rifulse mai sempre il primato sulle sorelle Tribù. Che se tale era pure l’origine, qual’è il Ritratto che di lui medesimo ci fa la Scrittura? Io oso dire che il libro delle cronache tali usa gravi, significantissime espressioni sul conto suo, che in tutto il corso dell’opera stessa, non se ne veggono per alcuno altro le simiglianti. E bene le avvertirono i nostri Dottori i quali osservarono e giustamente; come da Adamo da cui esordiscono le cronache sino a Jahbez, niuno si trovi che abbia fatto così nobilmente favellare di sè. E come favellano intorno a Jahbez i libri summentovati? Essi dicono E fu Jahbez sopra i suoi fratelli onorandissimo. Non basta. Il testo biblico reca manifeste le tracce di un gran voto da Jahbez pronunziato, voto che rimane per sventura incompreso poichè la promessa fatta al Signore restò implicita, restò sottintesa, ma che tutti i caratteri porge, come diceva, visibilissimi di un gran voto. Jahbez, dice il Testo, invocò il Dio d’Israel e così disse: Se tu mi benedirai, o Signore, se amplierai i miei confini, se la mano tua sarà in mio aiuto, se mi camperai dal male, onde non abbia a dolorare… Ebbene che cosa aggiunge, che cosa promette Jahbez ove Dio lo ascolti? Vano il cercarlo! Il Testo lo tace, gli Interpreti non sanno dirci se non che voto vi fu, ma rimane ignorato; e lo stesso Rasci non seppe dettare che le frasi seguenti ed egli votò quel che votò, ch’è quanto dire come più non c’è dato sapere. Sebbene questo sappiamo; che Dio ne adempì pienamente le voglie, e quindi se voto vi fu, siccome par dimostrato, se la preghiera fu accetta, il voto fu anch’esso adempiuto. Ma perchè traggono i Cheniti a fianco a Jahbez? I Giudici tacciono; ma la tradizione e le cronache lo dicono esplicito. Che dice la Tradizione? A imparare la legge, a fondare una scuola. Che aggiungono le cronache? Parole aggiungono che tutto il valore hanno di una grande conferma, di una grande rivelazione; un tratto di luce, vivo, acceso, che balena e sparisce; una stella che brilla un istante e quindi la ricuopre la nube, un suono che rompe per un istante la monotonia di un canto uniforme, parole ed idee che non siamo usati incontrare in mezzo le viete ed aride genealogie delle cronache e che rivelano la presenza dell’elemento scientifico intellettuale teologico, nell’epoche più remote della nostra esistenza. E quali parole poi perciò che riguarda i Cheneti e la origine degli Esseni!



