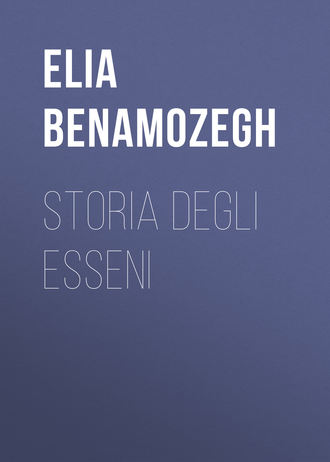
Полная версия
Storia degli Esseni
C’est du nord qu’aujourd’hui nous vient la lumière.
I progressi della scienza hanno ricollocato nell’oriente la sorgente della luce morale, siccome non cessò mai di essere il fonte della luce che ci rischiara; e basta aprire un lessico moderno per comprendere ad un solo sguardo qual parte segnalatissima sostenga l’idioma ebraico, e in generale sostengono le lingue semitiche, nella formazione delle lingue occidentali; comecchè si collochino nella famiglia delle indo-germaniche, e se ne cerchi la prima derivazione o almeno la forma loro più antica, nella lingua sanscrita.
10
Quanto volentieri rendiamo omaggio alla non infelice interpretazione del nome Esseni dal greco Isos amici, confidenti; altrettanto ci ripugna il credere, come vorrebbe persuadercene l’illustre Rabbino, che lo stesso vocabolo greco abbia derivazione ebraica, e tragga origine dall’incertissimo Hoze o Hazut d’Isaia, XXVIII, 15, 18, spiegato nel senso greco di Amicizia e Confidenza. Basti dire che l’esempio ebraico è unico in tutta la Bibbia in questo senso, mentre appena un uso frequente, quasi universale, basterebbe ad autorizzare il supposto di un passaggio dall’ebraico al greco; che questo senso stesso è almeno problematico, stando il Gesenius per altro, il quale non tollera questa assimilazione coll’Isos greco; e che infine meglio che la interpretazione dell’uno o dell’altro a noi arriderebbe l’ipotesi che qui non si tratta, nel Hoze o Hazut d’Isaia, che di un sinonimo assai più antico, più nobile e più puro del Galui di Geremia, Cap. XXXII, 11, che vale probabilmente quanto attestato, o almeno documento pubblico che accerti la esistenza di un contratto: e vale alla lettera, Scuoperto o Aperto, come Hoze o Hazut suona pure alla lettera, quello per cui si vede, o veduta. Ove non si voglia dire piuttosto che il patto per eccellenza, l’alleanza con Dio, essendo sancita per opera di una rivelazione, questa viene usata come sinonimo di patto nella parola Hoze o Hazut, per indicare l’alleanza col genio della Morte o dell’Inferno. Inoltre, parci l’illustre Rapoport caduto in una strana illusione quando trova affine al Hoze d’Isaia, l’arabo Haz, stringere patto, unirsi; mentre è evidente che questo verbo arabo non ha rapporto che coll’ahaz ebraico e coll’ahad arameo, stringere, unire.
11
Esodo, cap. XV, v. 26.
12
Proverbi, cap. III, v. 8.
13
Vi fu tra i Dottori chi intese in questo senso la signoria predetta dal Genesi all’uomo sopra le altre creature. Non si può negare che la frase nulla scapita, così intesa, della sua sublimità.
14
Salmo XXXXI, v. 5.
15
Isaia, VI, v. 10.
16
Isaia, LVII, v. 18.
17
Geremia, VIII, v. 22.
18
Opera infinita e certo non capace di stringersi in una nota noi faremmo, ove volessimo tutte riandare le analogie che la predicazione evangelica, il primitivo cristianesimo, ci offrono colla società degli Esseni. Forse ne sarà dato accennarne alcune, e solo di volo nel seguito di questa istoria. Ciò che possiamo sino da ora additare al lettore istruito, sono le numerose figure, imagini, locuzioni tratte dall’esercizio della medicina che ricorrono in bocca al Fondatore del Cristianesimo, le cure ch’egli prodiga agli infermi, la Salute onde s’intitola la nuova dottrina; indizj tra altri infiniti, che persuasero gravissimi autori antichi e moderni a vedere nell’Essenato la prima origine d’onde uscì il Cristianesimo evangelico. Nello scorso secolo, Bahrdtt e Venturini furono i più eminenti rappresentanti di questo sistema; e gli studj susseguenti nulla valsero a renderlo meno probabile.
19
Amici solo del vero, e rinunziando alla spuria gloria di aver ammaestrato Platone e Pitagora che alcuni Padri sognarono in favore dell’Ebraismo, ci acquistiamo il diritto di ripudiare egualmente una non meno falsa sentenza; cioè che l’Oriente semitico sia andato a scuola dei Greci, dei Romani, e anche degli Etruschi e antichi Italiani. Sistema dismesso dopo i tentativi invano assaggiati dal Biscioni, dal Mazzoldi, in favore delle origini italiche; ma che il sig. Gherardi tentò d’inverdire in un’opera recente, che ha, se non altro, il merito dell’eleganza e della erudizione. Ci duole aggiungere che non ne ha altri, e che vi manca quella nota impreteribile in ogni storica pertrattazione non solo, ma anche di un buon romanzo, la verosimiglianza. L’ebraismo ha una gloria più legittima e non men bella da vantare; quella di aver ammaestrato per mezzo della primitiva rivelazione i maestri stessi di Pitagora e di Platone, i legislatori, i Tesmofori e i poeti-teologi di Grecia e d’Italia: e questa e la Grecia a loro posta hanno titoli più legittimi che non il primato sull’oriente semitico; quello di avere sviluppato quei germi che l’Oriente vi dispose, in guisa che invano sariasi desiderato da popoli diversamente temprati, conciossiachè, nella guisa stessa che non ogni terreno è capace di fare allignare ogni sorta di pianta, così non ogni popolo è capace di fare fruttificare certi principj. I Dottori nostri, colla teoria loro dei Sarim o genj de’ popoli tutti necessarii e che nel loro insieme costituiscono la vera e completa Mercabà, cioè il carro che Dio stesso conduce e guida, gittarono le basi della più alta filosofia della storia che capir possa in mente mortale.
20
Il dotto signor Munk è sventuratamente afflitto da quasi completa cecità.
21
I fatti dall’illustre sig. Frank allegati, se provano improbabilissima un’influenza decisiva tra le due capitali e le due civiltà, non bastano però ad escludere ogni qualsiasi ascendente. Questo anzi è provato da quelle non scarse nozioni che di Alessandria e del suo ebraismo tralucono negli scritti dei dottori, e da quelle comunicazioni che la mercè dei viaggi intrapresi da varj cospicui dottori, non cessarono di rinnovarsi di tratto in tratto tra i due paesi. Il Talmud è ricco di notizie intorno all’organamento dell’ebraismo nella capitale dei Tolomei. Si rende ragione dei tribunali ebraici di Alessandria (Talmud Ketubot 25, 1), si magnifica la ricchezza delle sue Basiliche e delle Cattedre su cui siedevano pro-tribunali settanta dei più cospicui fra i cittadini; si descrive la magnificenza e le forme del culto, sino ai più minuti particolari della costruzione di quel tempio (Talmud Succa Babilonico e Gerosolomitano). Si mostra contezza delle loro arti (Moed Katan 26), degli abusi, delle prepotenze che si usavano sulle fidanzate altrui (Mezihà 104, 1), dei loro costumi dissoluti (Medras Ester in principio), della loro propensione alla magia (Ibidem e Kidduscin 49, 2). Ma ciò che più monta, sono i viaggi che si narrano dal Talmud colà intrapresi in varie epoche dai dottori Palestinesi. Non parleremo di Onia, che sugli esordj del secondo tempio, si recò dalla Palestina in Egitto, e vi fondò quel tempio che ne porta il nome. Si disputa nel Talmud se il tempio elevato da Onia in Egitto fu tempio dedicato al culto del vero Dio, o a un culto idolatrico. La prima opinione sembra prevalere. Ciò che importa non meno sapere, è una curiosa aggiunta che il Maimonide si permette fare nella storia del soggiorno di quest’Onia in Egitto, della quale, a quanto io mi sappia, non vi ha memoria negli antichi monumenti rabbinici. Il Maimonide, nel suo comento alla Miscnà (Trattato Menahot), ragionando di Onia, ne fa sapere che trovato avendo costui in Egitto una setta per nome Kabtazar, con essa si accontò o per dir meglio si fece suo capo. Kabtazar è invero il nome che si legge almeno nel comento stesso voltato dall’arabo all’ebraico. Però era naturale in me il dubbio che qualche altro nome ben altramente storico, sotto queste mentite sembianze si nascondesse. Infatti, la idea mi occorse che per questo nome guasto e corrotto di Kabtazar, si volesse significare per avventura i Copti; e per quanto la congettura mi sembrasse non infelice, pure non mi attentai a soscrivervi seriamente se prima non ebbi e l’attestato di antico documento e l’adesione di uomo competentissimo. Questo è l’illustre amico mio sig. Salomone Munk, socio dell’accademia delle Iscrizioni e belle lettere di Parigi, al quale m’indirizzai in cerca di notizie; e che con isquisita benevolenza risposemi nei termini seguenti: «Quant au mot Kabtazar, sur le quel vous me faites l’honneur de m’interroger, c’est tout simplement une faute d’impression, ou une faute de copiste dans la version hébraïque de commentaire de Maïmonide. La véritable leçon est Kobt Masr, et comme vous l’avez bien deviné dans un premier moment il s’agit ici des Coptes anciens ou des Egyptiens indigènes, par opposition aux Grecs qui depuis Alexandre s’étaient établis en grand nombre en Egypte. Maïmonide veut dire qu’Onia gagna un grand nombre d’Egyptiens indigènes, qu’il convertit au Judaisme. (È questo fatto principalmente che Maimonide introduce nella istoria, senza che si possa scuoprire d’onde derivato). Les mots Kobt Masr, sont généralement employés par les auteurs arabes pour désigner les anciens Egyptiens sous les Pharaons ou leurs déscendants à l’époque des Grecs et celle des Arabes. Encore aujourd’hui on appelle ainsi les chrétiens d’Egypte que nous designons ordinairement par le nom de coptes, et que descendent d’une race mêlée d’anciens Egyptiens et de Grecs. (Qui il dotto sig. Munk trascrive il testo arabo, e aggiunge.) J’ai fait copier ces mots arabes d’un manuscrit de la Bibliotheque imperiale que j’ai apporté moi même d’Egypte en 1810.» Senza più oltre aggiungere di Onia, è celebre il viaggio di Jeosciuah Ben Perahia, quegli stesso che a detto del Talmud fu precettore di Gesù, il quale insieme al maestro si sarebbe recato pur esso in Alessandria. Il Talmud ci conservò la Epistola che da Gerusalemme fu spedita alla Sinagoga d’Egitto per affrettare il ritorno del prenominato dottore. Ella è così concepita: Da me, Gerusalemme città santa, a te Alessandria. Lo Sposo mio dimora presso di te, ed io me ne sto in solitudine. Il dotto sig. rabbino Rapoport, nel suo Erech Millin altra volta citato (pag. 101), pare volere confermare questo viaggio di Gesù in Egitto con quanto narrano i Vangeli della fuga in quel paese. È noto però come questa avvenisse nella più tenera infanzia del fondatore del Cristianesimo; mentre il viaggio onde si narra nel Talmud sarebbe stato eseguito nella sua gioventù, anzi poco prima della sua rottura colla Sinagoga. Tuttavia non è a tacersi che di questo viaggio eseguito da Gesù nella età virile, narravano i Carpocraziani, antichissimi eretici, quando dicevano: «Que J. C. avait choisi dans ses 12 disciples, quelque fidèles amis, auxquels il avait confié toutes les connaissances qu’il avait acquises dans le Temple d’Isis, ou il etait resté près de treize ans a s’exercer à une étude pratique, dont on lui avait donnée la théorie pendant son enfance instruite et formée par les Prètres egyptiens.» (La Maçonnerie considerée comme le resultat de la Relig. egypt. juive et chrét., par R. D. S.; vol. I, pag. 289). Ciò pone almeno in salvo la buona fede dei Talmudisti, e l’antichità della tradizione di cui si fecero interpreti. Ella è attestata da un documento non meno antico, l’Evangelo di Nicodemo. In questo, tra le altre cose, gli Ebrei accusano Gesù che «arrivé à certain âge fut contraint de chercher fortune en Egypte, ou il apprit quelque secret; qu’il retourna dans son pays en Judée, et que par ce moyen il fit de la magie» (Ibid. vol. I, pag. 445). Il Talmud Gerosolimitano racconta di un altro viaggio posteriore, che Jehouda Ben Tabai ed un suo discepolo intrapresero nell’Egitto. Simone Ben Sciattah, capo dei Farisei, fuggì in Egitto per torsi alla persecuzione del cognato suo, il Re Janneo, amico dei Sadducei. Quindi R. Jeosciuah Ben Hanania, soprannominato lo Scolastico, visitò pur esso l’Egitto; e il Talmud racconta dei colloqui avvenuti colà tra il dottore Palestinese e gli Ebrei ivi stabiliti. Un altro dei più illustri Tanaiti, R. Johanan Asandellar, era di Alessandria (Talmud Gerosolomitano, Haghiga cap. III). Più tardi, troviamo domande in fatto di riti, dirette da Alessandria ai dottori di Palestina (Talmud Gerosolomitano, Kidduscin cap. III), e circolari da questi alle Sinagoghe di Alessandria (Talmud, Irrubin cap. III). R. Abhu, familiare nella Corte di Cesare, vi si recò esso pure e v’introdusse l’uso delle Palme nel primo giorno dei Tabernacoli caduto in Sabato (Ibidem). Tutti questi viaggi, dei quali il più antico è appena contemporaneo a Filone, non possono avere esercitato un’influenza decisiva nè sopra la di lui filosofia, nè sulla istituzione dei Terapeuti, che Filone descrive come da lungo tempo ivi stanziati e stretti in consorteria; e la ignoranza almeno parziale di quanto accadeva in Palestina, è prova in Filone di non aver subìto se non indirettamente l’ascendente palestinese. Forse anche meno probabile è l’altra ipotesi di un’azione qualunque esercitata dalle dottrine alessandrine sulle idee in Palestina, e quindi nella formazione della dottrina cabbalistica e dell’Essenato. Chi rifletta alle rare occasioni di contatto tra i pensatori delle due sinagoghe; all’autorità e preminenza che dovevano avere necessariamente i dottori di Palestina sulle sinagoghe straniere; alle antichissime menzioni che vengono fatte di una scienza acroamatica nei libri talmudici, rappresentandola come già esistente fin dai tempi d’Illel; soprattutto alle antichissime tracce dell’Essenato non solo in Giuseppe Flavio e in Plinio, ma, ciò che più monta, in Filone e forse anco nei Maccabei; agevolmente andrà convinto, che se molte strettissime attinenze, se molte somiglianze parlantissime si rinvengono tra Filone e i Cabbalisti da una parte, e tra Terapeuti ed Esseni dall’altra, si debbono fare risalire a quell’epoca più antica in cui gli Ebrei si staccarono dal centro palestinese per andare ad abitare le sponde del Nilo, ove recarono seco, insieme al Testo della Legge, i germi di quelle tradizioni, che subirono poi sì ricca e rigogliosa vegetazione sul patrio suolo di Palestina.
22
La identità suprema di Esseni e Farisei che la storia presente contribuirà spero in parte a mettere in sodo, e che antichi e moderni autori di buon grado consentirono, non ne toglie di considerare la prima di queste scuole siccome quella parte che per le sue dottrine e le sue tendenze, diede più particolarmente origine alle istituzioni e ai dogmi cristiani; ed anche di questo sembra che la critica indipendente vada sempre più convincendosi. Questa prerogativa degli Esseni-Kabbalisti di aver generato il Cristianesimo da ma diffusamente trattata nel mio Essai sur l’origine des dogmes et de la morale du Christianisme ci porge una naturalissima spiegazione di questi due fatti accennati nel testo; il primo è il nome di Terapeuti preso dai primi Cristiani, il secondo molto più momentoso è il silenzio degli Evangeli intorno la Società degli Esseni, silenzio non altrimenti esplicabile. Ma agevole torna il comprenderlo purchè si ammetta ad un lato che gli Esseni non erano che la parte più eletta, la frazione speculativa del Farisato, e che era quella da cui meno dessentiva la nuova dottrina. Non è nemmeno improbabile che i Dottori della Legge di cui si parla ripetutamente nei Vangeli siano la indicazione di questa parte del Farisato. Nel Saggio sopra rammentato mi sono ingegnato di porgere di questa congettura non pochi nè lievi indizi, tratti dai Vangeli e dai libri rabbinici.
23
Opera infinita, certo non capace di stringersi in una nota noi faremmo, ove noi volessimo tutte riandare le analogie che la Predicazione evangelica e il primitivo cristianesimo ci offrono colla società degli Esseni. Forse ne sarà dato accennarne alcune, e solo di volo nel seguito di questa istoria. Ciò che possiamo sino da ora additare al lettore istruito, sono le numerose figure, immagini, locuzioni, tratte dall’esercizio della Medicina, che ricorrono in bocca al Fondatore del Cristianesimo; le cure che egli prodiga agli infermi, la Salute onde s’intitola la nuova dottrina, indizj tra altri infiniti che persuasero gravissimi autori antichi e moderni a vedere nello Essenato la prima origine d’onde uscì il Cristianesimo Evangelico. Nello scorso secolo Bahrdt e Venturini furono i più eminenti rappresentanti di questo sistema, e gli studi susseguenti nulla valsero a renderlo meno probabile.
24
Questo fatto, segnatamente per ciò che s’attiene a Filone, torna tanto più ammirabile quanto più erano tempi i suoi di gravi dissidenze religiose in Palestina. L’essersi serbato puro il nostro Filone di ogni labe eretica, non è ella nobilissima testimonianza dell’antichità e verità dell’ortodossia farisaica che Filone redò dai suoi maggiori trasportata in tempi più antichi in Egitto? Quanto al fatto stesso, vale a dire l’ortodossia di Filone, ci sembra indisputabile. Può trovarsi qua e colà nelle sue opere alcune, vuoi dottrine o interpretazioni che dissentono dalle dottrine e chiose prevalenti tra i Farisei; ma in primo non si può negare che il Farisaismo stesso era a quei tempi scisso in cento diverse frazioni le quali, tenendosi fra loro in bilico creavano in seno all’uniformità generale una varietà così pronunziata nei particolari, che avrebbe oggi faccia di paradosso e di eresia. In secondo luogo non è lecito pretermettere che Filone vivendo lontano, e ciò ch’è più, sequestrato dal centro religioso di Palestina, non poteva a meno di offrirci nelle opere sue qualche dissonanza colle idee colà dominanti. Nè faremo caso di altre cagioni non meno urgenti che produssero questo cotal disaccordo; la traduzione greca dei sacri libri diversa in gran parte dal Testo ebraico e sola conosciuta da Filone, lo scopo da esso propostosi nel dettare le opere sue, quello cioè da far conoscere le dottrine e la storia ebraica ai Pagani e che ispiravagli tal volta un linguaggio più acconcio a persuadere i suoi lettori pagani, che fedele alle vetuste dottrine degli avi suoi. Nonostante è innegabile che il genio, la sostanza, le tendenze di Filone e delle sue opere sono a dirittura farisaiche. Opera immensa sarebbe il raffronto tra le dottrine dell’uno e quelle degli altri. Momentosissima poi quella che si assumesse l’officio di trovare nelle costui dottrine i principali lineamenti, e non poche volte le formule istesse della teologia farisaica, o acroamatismo (Cabbalà) impresa che il signor Frank tentò in parte nella sua Kabbale, éd. de Paris. Basterà qui che noi facciamo un breve assaggio delle strettissime attinenze che corrono fra Filone, e i Farisei o la tradizione in generale e ciò in una delle meno illustri delle opere filoniane la vita di Moisè che noi preferiamo, trovandosi più agevolmente in mano ad ognuno per le recenti edizioni che ne vennero fatte. Ora noi mostreremo in brevissime note ciò che di singolarmente somigliante si trova in quest’opera tra le nozioni storiche, i giudicj, le dottrine eziandio di Filone, e quelle che suonarono famose tra i Farisei e che solo i loro libri, posteriori di gran lunga a Filone, ci attestano; prova se altra fu mai che la loro data risale molto più alto dei libri che le contengono, e che la lealtà dottrinale e religiosa dei Farisei repugna al supposto di una invenzione e alterazione per parte loro. – Divideremo i nostri rilievi in due parti – prima tutti quelli che si riferiscono a storia – poi quelli che si attengono a dottrine.
A pag. 3. Dice di Moisè «Allora nato questo bambino pareva che dallo aspetto promettesse non so che più dell’ordinario.» Non si dee tacere che idee conformi si leggono nei monumenti tradizionali sul testo che dice E vide, (la madre) ch’egli era bello. Ora si dice, che nacque circonciso; ora che al suo nascere un gran splendore invase la stanza; ora che fu veduta con esso la Schehina. Tob che qui significa probabilmente bello, ha pure il senso di buono, e buono è nome che Dio ha nella teologia riposta dei Farisei, come il Primo e l’uno di Plotino corrispondente al Padre del Cristianesimo, e alla Sapienza o Sofia dei Teosofi ebrei (Kabbalisti) ha esso non meno il nome di Buono (Agathos).
A pag. 18 «Dopo le quali nozze egli incominciò ad essere pastore preparandosi in cotal guisa al principato, perciocchè l’arte pastorale ci dispone al regno, cioè al regime di uomini, greggia mansuetissima; siccome quelli che hanno i loro animi inchinati alle cose della guerra prima si esercitano nella cacciagione… onde il Pastore ha certa somiglianza col Re. Anzi, per quanto io ne sento, non seguendo la comune opinione ma ricercando la verità, e rida chi vuole, solo colui può essere perfetto Re che ottimamente sa quello che si richiede a governare un gregge. Ora chi non resterà sorpreso leggendo nel Scemot Rabbà le parole seguenti. Come fu provato Moisè? Nell’arte sua di Pastore. Così pure fu provato David e fu trovato egregio pastore conciossiachè egli traesse addietro i più forti tra il gregge per dar luogo a’ più deboli di cibarsi; mandava pure innanzi al pascolo le più tenere pecorelle perchè trovassero l’erba più delicata; quindi le vecchie a pascere l’erba mezzana, infine le giovani e forti a cibarsi della parte più dura. Ciò vedendo disse Iddio; questi che sì bene sa appropriare ad ogni età e temperamento il suo cibo sarà pastore del mio popolo. Così Mosè non fu altramente esperimentato. Dissero i nostri maestri: mentre stava Mosè pascolando la gregge di Ietro per i campi, fuggigli un agnello, ed avendolo rincorso lo trovò mentre si dessetava in un laghetto d’acqua. Disse allora Moisè: Non sapeva che tu corressi per la sete che ti molestava. Sei tu stanco? e così detto, lo prese, e messoselo sulle spalle se ne ritornava. Lo che veduto Dio, disse: Poichè tanto hai di pietà nel governo del gregge degli uomini, tu sarai pastore del mio popolo Israel.» e più oltre, «Dio non concede agli uomini grandezze se prima non sono provati nell’infime cose. Così due grandi uomini furono in vili offici esperimentati, e trovati fedeli, salirono a’ più magnifici stati. Fu David esperimentato nella pastorizia, e vedendo come ad ogni poter suo evitasse i colti onde di rapina non si cibassero le sue pecore, fu fatto pastore di popoli. Moisè pur esso, dice il Testo, pascolava le gregge dietro il deserto perchè le pecore sue non vivessero sugli altrui campi; quindi fu chiamato a pascere Israel, essendo scritto: Tu guidasti qual gregge il tuo popolo per mezzo di Mosè e Aaron.» I fenomeni portentosi che accompagnarono il nascimento di Mosè possono essere suggeriti dal desio comune di dare una tinta maravigliosa all’origine di uomini comunemente venerati. Ma il presente raffronto ci sembra ancor più significante.
A pag. 41. Era l’acqua del fiume mutata in sangue, ma non agli Ebrei perciocchè attingendovi questi, diventava buona da bere. Quest’ultima circostanza taciuta dal Testo si trova solo nella Tradizione.
A pag. 78. Perciocchè allora più mostrava di veder la bestia che l’uomo, il quale si dava vanto di vedere non pure le cose mondane, ma esso rettore e creatore dell’universo. Al vanto dl Balamo che si dice conoscitore della Mente di Dio (Veiodea daat Elion) i Dottori domandano or come conosce la Mente di Dio colui che nè anco sa cosa voglia la sua giumenta?
A pag. 108. Quivi (I Dottori interpetri della legge per ordine di Filadelfo) rapiti dallo spirito, profetavano non diversamente, ma tutte colle medesime parole non altrimenti che se alcuno avesse dettato a ciascheduno invisibilmente. Il Talmud parecchi secoli dopo Filone, e ignaro certamente dell’attestato di questi, ripete le stesse cose. Non è prova il deposto di Filone della preesistenza delle medesime tradizioni ai Dottori talmudici e non pone suggello alla loro veracità? Questa esattezza nel riferire le tradizioni storiche ci è arra della dote medesima nel riferire le tradizioni dottrinali. Ognuno comprende come la verità del fatto sia considerazione estranea alle conclusioni che qui si traggono, perocchè la lealtà farisaica rimarrà dimostrata ogni qualvolta le loro narrazioni si palesino concordate dai più valenti scrittori, non pochi secoli vissuti innanzi a loro.



