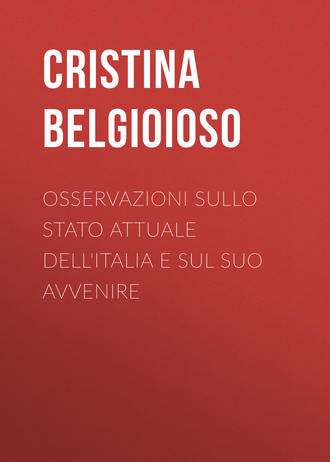
Полная версия
Osservazioni sullo stato attuale dell'Italia e sul suo avvenire
Se occorressero prove di fatto per dimostrare che tanta diffusione di luce intellettuale è cosa assai recente, basterebbe il porre a confronto di quelle 30 mila scuole il numero di analfabeti, che offuscano tanto splendore. Fra un 1,397,924 di giovinetti dai 12 ai 19 anni, cioè della età in cui dovrebbero avere terminati gli studi primarii, ed essere in grado di passare alle scuole tecniche o alle scuole secondarie, 938,637 di essi sono tuttora analfabeti, mentre 61,800 sanno leggere soltanto, e 361,725 sanno leggere e scrivere. – Speriamo che questi infelici 938,637 siano fra i nati prima del 50, ed avessero per conseguenza oltrepassata l'età in cui sogliono i fanciulli essere ammessi alle scuole primarie o comunali, quando il benefizio di codeste scuole fu largito al paese; e speriamo altresì che codesta enorme e vergognosa macchia nel nostro sole vada rapidamente impicciolendosi, e venga in breve coperta dai raggi sempre più splendidi che da esso si diffondono.
Oltre quel numero di scuole primarie, l'Italia contava già nel 63, 81 corpi scientifici ed accademie di scienze, lettere ed arti; 200 biblioteche; 10 osservatorii astronomici; 26 osservatorii meteorologici; 13 musei di archeologia; 13 società per la conservazione e l'illustrazione dei monumenti; 12 deputazioni di storia patria; 20 istituti speciali di belle arti e di musica; 5 alte scuole di perfezionamento; 19 università col corredo di 123 licei; 452 ginnasii pubblici; 177 scuole tecniche; e 65 scuole magistrali pei due sessi; tralasciando ancora di parlare delle scuole serali e delle festive, aperte recentemente in pressochè tutti i Comuni rurali di Lombardia, alle quali concorrono spontaneamente uomini di ogni età, e dove sono loro gratuitamente insegnate dagli uomini più colti del villaggio, come sarebbero il medico, il sindaco, il maestro ed il segretario comunale, le prime nozioni di storia, di geografia, di storia naturale, ecc. ecc.
Giova osservare che alcune delle cifre testè accennate non hanno tutta l'importanza che sembrano avere a primo aspetto. Quel gran numero di università non significa precisamente che il numero degli aspiranti all'insegnamento, che ivi si riceve, sia tale, che non bastino a contenerlo meno di 19 Università. – Questo numero, veramente smisurato, provviene dallo sminuzzamento che fece dell'Italia una agglomerazione di tanti piccoli Stati, gli uni degli altri gelosi e discordi; ognuno dei quali pretendeva di essere completo e perfetto nella sua picciolezza, possedendo ogni forma esterna di istituzioni scientifiche e letterarie, corpi insegnanti, ecc. Il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, la Venezia, i due Ducati, il Bolognese, l'Umbria, la Toscana, e se non m'inganno il Principato di Lucca, la Sardegna, il Napoletano, la Sicilia, e non so se la repubblica di S. Marino, avevano ciascuna non meno di una Università; ed i riguardi con che il governo nostro nazionale ha creduto di dover trattare i pregiudizii autonomici delle provincie italiane sono tali, che non si è peranco accinto a ridurre questo superfluo numero di Università. – Lo stesso può dirsi verosimilmente di alcuni degli osservatorii astronomici e delle accademie letterarie, che erano considerate come un adornamento distintivo di una capitale; ed ora non si tolgono per non far sentire agli abitanti di coteste già capitali ch'essi sono decaduti da ciò che ad essi o ad alcuno di essi può sembrare una situazione assai elevata. Ma tali riguardi eccessivi non possono essere perpetuati, ed il numero degli istituti scientifici o insegnanti sarà messo in armonia coi bisogni del paese, cioè col numero degli studenti di esso.
Certo è però che se quel prodigioso numero di Università non ha tutto il favorevole significato che gli si potrebbe attribuire, ciò non significa per nulla che debba o possa farne arrossire; e se il numero dei nostri corpi insegnanti oltrepassa i nostri bisogni, questo difetto di proporzione non è cagionato dal recente scemarsi del numero degli studenti, bensì dalle cangiate circostanze del paese, dal concentramento nazionale, dalla distruzione di pressochè tutti i confini interni d'Italia, e dal rapido accrescimento delle vie di comunicazione fra le varie Provincie. Il numero delle Università italiane sarà indubitatamente ridotto; dubito però che possa mai esserlo nella misura della Francia e dell'Inghilterra, perchè la topografia e la figura stessa della nostra Italia osta ad un sistema troppo assoluto di concentramento. Se le provincie meridionali d'Italia come le Calabrie, gli Abruzzi, Terra di Bari e di Otranto, la Sicilia, ecc. dovessero mandarci i loro studenti a Pavia o a Padova, temo che finirebbero col rinunziare ai vantaggi di una educazione universitaria.
Prima di procedere alla soppressione di alcune delle nostre Università, conviene ponderare accuratamente quali fra di esse possono essere impunemente tolte, cioè senza che si interrompano e facciano sosta i progressi della pubblica e nazionale istruzione, che è quanto dire del nazionale incivilimento.
Questo rapido esame dell'incremento, ch'ebbero negli ultimi pochissimi anni i mezzi di comunicazione e d'istruzione popolare nel nostro paese, ne presenta in vero molte sorgenti di conforto. Una considerazione però tempra la soddisfazione, che vorremmo ritrarne; ed è questa la influenza, anzi la ingerenza piuttosto accresciuta che scemata del clero negli stabilimenti della pubblica istruzione. Eravamo preparati a codesta preponderanza nelle provincie meridionali; ma i dati statistici, ai quali mi riferisco per questo lavoro, non la mostrano minore nel Piemonte, nella Liguria, nella Lombardia e nella Toscana, che nel Napoletano e nella Sicilia stessa. – Se di tale scoperta non solo mi meraviglio, ma mi rammarico, ciò non proviene da avversione al clero cattolico, e molto meno poi da dispregio per la religione, di cui è detto il ministro; ma soltanto perchè il clero può essere considerato a buon diritto, meno qualche eccezione, irremissibilmente ostile all'ordinamento oggi in vigore in Italia, e perchè tale essendo, i nostri giovanetti a lui affidati non possono ispirarsi ai sentimenti di lealtà, di gratitudine e di rispettosa fiducia verso il nazionale governo, che si richiedono dai cittadini di un paese libero. – Il clero cattolico è naturalmente avverso alle libertà civili, ch'esso confonde talora colla libertà di pensiero e di coscienza, e che in ogni caso esso tiene per indissolubilmente legate fra di loro, e non a torto. Io non discuterò quì se più felice sia il popolo soggiogato civilmente e intellettualmente, ma che non sente il peso del giogo a cui è avvezzo, ed al quale si rassegna confortato da una cieca fede in tutto ciò che gli insegna il suo clero; o il popolo liberale ed indipendente, conquistatore dei proprii diritti e di essi pienamente conscio, ma a cui fu tolto l'intimo conforto, ed il forte sostegno di quella cieca fede. – Sono queste quistioni le mille volte discusse, senza ricevere una soluzione che ponesse fine ad ulteriori dibattimenti. – Ma il nostro popolo ha risoluto il quesito col fatto della sua scelta. Il popolo schiavo ha voluto essere libero ed indipendente a qualsiasi costo; ed ha realizzato diffatti questo suo ardentissimo desiderio. Oggi non si tratta di decidere se a lui convenga di acquistare la libertà, o se sia meglio per lui di rimanere qual era nel medio evo. – Trattasi d'imparare a far buon uso dell'acquistata libertà; di preparare la vegnente generazione al pieno godimento di quei beni che i padri suoi non seppero che imperfettamente sviluppare. Trattasi di riunire, di fondere tutti gli Italiani in un pensiero concorde di gratitudine pei singolari benefizi ricevuti, e nella invariabile risoluzione di sottoporsi ai maggiori sagrifizi, piuttosto che rinunziare alle conquiste fatte, o che mostrarsene poco degni. Tale essendo la parte che spetta all'attuale e alla futura generazione di Italiani, vorrei mi si dicesse che cosa pensano e quale scopo si prefiggono i parenti che affidano la educazione dei loro figli al clero, ed al clero regolare in particolar modo, cioè al nemico delle nostre istituzioni, a quello che vorrebbe ricondurne indietro sino alla servitù materiale ed intellettuale del medio evo, e che ha missione dal suo capo spirituale e temporale, da quel capo riverito e temuto, a cui nessun membro del clero cattolico può sottrarre la menoma parte di sè stesso, ha missione, dico, di non transigere mai coll'attuale ordine di cose in Italia, ma di creargli quanti ostacoli e quanti nemici può. – Molti sono i padri che così pensano e che così parlano del clero; eppure non pochi fra questi affidano i figli loro ai Barnabiti, o a qualche altra corporazione religiosa, specialmente dedita alla istruzione dei giovani. – Di tale singolarità essi si scusano coll'asserire che i collegi tenuti dai laici sono così male diretti, e la istruzione dispensatavi così meschina, che nulla può aspettarsi da educazioni così condotte. Forse non sono senza fondamento tali critiche, e tali osservazioni: tutto il sistema che ne diresse per tanti secoli, e che era basato sul più rigido assolutismo, cadde in un'ora, e diede luogo ad una illimitata libertà ossia ad una generale rilasciatezza. – I primi effetti di così repentino cangiamento non ponno essere che tristi. – Ma se invece di condannarli come tali, e di volgersi a ciò che rimane dell'antico sistema, come se questo potesse convenire ad una nazione libera, i padri di famiglia delle classi educate si applicassero ad emendare i difetti dei collegi tenuti da laici, essi non andrebbero incontro, e non esporrebbero i figli loro ad una serie d'incalcolabili danni, col risospingerli nel passato; e ciò nel momento appunto che questo passato crollò, e che ad esso subentrava un avvenire interamente opposto a quello.
Che che ne sia delle molte imperfezioni ed incapacità nostre, delle nostre impazienze, diffidenze ed inerzia, ecc. abbiamo fondate speranze di un felice e glorioso avvenire. – Mettendo a confronto ciò che abbiamo operato in questi ultimi sette anni, con ciò che operarono durante uno spazio di tempo assai più lungo, cioè dal 1821 e dal 1831 sino ad oggi, altri due popoli meridionali, repentinamente usciti di servitù ed assunti all'onorato seggio di libere nazioni, voglio dire dei Greci e delli Spagnuoli, troviamo occasione di confortarci, e di rinfrancarci nelle nostre speranze. – L'Europa tutta parla dell'Italia come di una nuova potenza di primo ordine, e chi ne avesse predetto dieci anni indietro che di noi si sarebbe oggi portato siffatto giudizio, sarebbe stato tenuto o per pazzo o pel più impudente degli adulatori.
Possano realizzarsi così le nostre speranze, come fu di gran lunga superata sin qui la nostra aspettativa. Poche parole aggiungeremo ancora sulla situazione d'Italia in quanto concerne la sua politica esterna, ossia le sue relazioni colle potenze estere.
Nata o, per meglio dire, rinata, per opera della Francia, col concorso di questa grande e generosa nazione, le altre potenze potevano considerarla come di lei satellite, e trattarla conseguentemente. con poco rispetto e poca benevolenza. Così non accade; e di ciò dobbiamo rendere infinite grazie al nostro governo, e specialmente agli uomini di stato che diressero la nostra rappresentanza diplomatica, e che seppero fare all'Italia un posto nuovo negli annali della storia di Europa, un posto onorevole e degno. Le amicizie politiche sono per lo più di fragile tessitura, mentre le nimicizie, che ad esse corrispondono, hanno profonde e saldissime radici. – Era dunque assai da temere che dopo il 59, o nel corso degli anni che gli succedettero, si allentassero, anzi si rompessero i legami della nostra alleanza colla Francia, e che la vendetta austriaca, trovandoci spogliati della protezione francese, ne perseguitasse sin che ne avesse ridotto nel pristino stato di suoi schiavi. – Se così fosse accaduto, potevamo lottare, e lottare con gloria, ma presto o tardi avremmo dovuto soccombere.
Accadde appunto tutto all'opposto. – Sebbene noi non tenessimo conto alcuno degli impegni assunti in nome nostro dall'Imperatore Napoleone nella pace di Villafranca, la protezione di lui non ne venne mai meno, e per conseguenza la nostra alleanza colla Francia non subì alterazione di sorta. – E tale persistenza non ebbe per effetto di indisporre contro di noi le altre potenze poco benevole verso la Francia o di essa gelose. – L'Inghilterra si manteneva nostra amica nei limiti da essa tracciati sino dal 48, vale a dire in tutto ciò che non implicava il di lei concorso a mano armata. – La Russia, che si astenne dal partecipare ad impresa alcuna che avesse per oggetto il danno nostro, non indugiò lungamente a riconoscere la nostra esistenza come nazione indipendente di diritto e di fatto; la Prussia, versando in gravi emergenze, cercava la nostra alleanza; e quell'Austria stessa che, un anno fa, sosteneva colle armi i pretesi o sognati suoi diritti sopra di noi, oggi costretta a rinunziarvi, li confessa non fondati in ragione, ma protesta di volere in avvenire farsi un'amica di quella Italia che pretendeva testè ridurre in ischiavitù. – Forse non si esprimono così apertamente nè l'Imperator d'Austria, nè i suoi ministri; ma se si leggono i vari periodici austriaci, si vedranno tali sentimenti e tali concetti espressi nei modi per noi più lusinghieri. – Insomma l'Europa intera ne porge oggi la mano. – Quell'Italia soggetta sempre ora dell'uno ora dell'altro, sempre discorde fra le varie sue parti, da tutti derisa e schernita per la sua frivolezza, per le sue vane iattanze, e per la sua impotenza a fare ciò che fecero da moltissimi secoli tutte le altre nazioni, quell'Italia dall'Europa perseguitata e tenuta come un semenzaio di rivoluzionarii assassini ciecamente avversi ad ogni idea di ordine e di autorità, superstiziosi ed empii allo stesso tempo, oggi non solo ha acquistato la libertà e l'indipendenza, cioè la vita, ma ha ottenuto la benevolenza di tutte le civili nazioni, che la accolgono nel loro consesso, e con lei si congratulano delle tante sue venture. Non è guari che l'Europa si credeva vicina ad una guerra che sarebbe stata generale, ed alla quale l'Italia avrebbe avuto verosimilmente a prender parte. – In tale occasione non traspirava in alcuna delle nazioni europee un sentimento di odio o di disprezzo verso l'Italia, e da qualsiasi parte si fosse rivolta coll'offerta della propria alleanza, essa non avrebbe certamente incontrata fredda accoglienza.
Dobbiamo rendere di ciò infinite grazie alla prudenza, alla lealtà e all'abilità del nostro governo, ed in particolar modo ai nostri ministri degli affari esteri; ma esaminando la cosa accuratamente in tutte le sue particolarità, essa ne sembra così portentosa, da doverla attribuire allo speciale intervento di una benefica Provvidenza che volle, in compenso dei tanti mali sofferti, dotarne di tutti quei beni che non abbiamo mostrato di disconoscere, e che non ci siamo resi incapaci di apprezzare e di serbare. Quanto alla parte che a noi stessi possiamo attribuire nell'acquisto di codeste generali simpatie, essa si riduce ad una sola virtù, colla quale abbiamo sorpreso l'Europa che ce ne supponeva intieramente privi. – Intendo parlare della moderazione. – L'Europa era stanca delle enfatiche esagerazioni di molti fra i nostri rifugiati politici; e credeva che gli Italiani tutti parlassero in quello stile, e dividessero quelle opinioni che non avevano per essa neppure il pregio della novità, mentre per molti anni le aveva lette ed udite dalla bocca o negli scritti dei rivoluzionarii francesi del 89, e poscia da quella di tutti i loro imitatori.
Quando le vittorie del 59 resero alle popolazioni italiane la facoltà di esprimere i loro pensieri, e di eseguire le loro volontà, l'Europa vide non senza stupore una nazione sorgere dalle sue stesse ceneri, confessare ed abiurare, aborrendoli, i proprii errori, ripudiare gli odi e le gelosie intestine, le esagerate od impraticabili utopie, e stringersi unanime e concorde sotto una monarchia costituzionale; e sotto tale monarchia rimanersene costante e soddisfatta per tutto quel tempo che è già caduto nel dominio della storia, cioè per tutto il tempo decorso dal 59 sino ad oggi. – L'Europa conobbe allora che gli emigrati italiani non erano tutta la nazione italiana; che l'Italia poteva godere di una saggia libertà, ed assumere l'importanza a cui il numero delle sue popolazioni, l'antica sua storia, ed il carattere de' suoi abitanti le danno diritto, senza che perciò un'orda di rossi sovvertitori si scatenasse sulle vicine contrade e togliesse loro la pace e la civiltà; conobbe che l'Italia riscattata ad un tempo dalla schiavitù, e dalle viete e funeste assurdità rivoluzionarie, doveva sorgere rapidamente al livello delle più colte ed incivilite nazioni; e ciascuna delle nazioni europee pensò di farsela amica, per poi trovarla tale quando il bisogno se ne facesse sentire.
Oggi l'Italia è senza nemici, e possiamo sperare che così rimanga per lungo tempo, imperocchè non v'ha occasione per essa di lottare o di competere colle altre potenze europee. – La nazione italiana non avendo esistito, come nazione, nel passato, non ha assunto impegni nè con sè stessa, nè con altre, che oggi le sieno d'inciampo al consolidamento della pace con l'Europa tutta. – La sola Inghilterra potrebbe vedere in un lontano avvenire l'Italia sua emula e sua rivale sul Mediterraneo; ma la potenza marittima dell'Inghilterra è talmente superiore a quella che noi potremmo acquistare, diciam pure, in un secolo, quand'anche nostra unica cura fosse appunto l'emularla nel mediterraneo, ch'essa può senza imprudenza aspettare almeno un mezzo secolo ad ingelosirsi di noi. – Quanto alle altre potenze europee, l'Italia non scenderà nell'arena per competere con esse. – Non contesterà alla Russia la signoria sopra l'Asia, nè alla Francia la signoria sopra l'Africa settentrionale, nè quella sul Belgio o sulle provincie situate sulla sponda sinistra del Reno, nè alla Prussia il progressivo assorbimento degli Stati germanici; nè all'Austria finalmente contesterà il compenso ch'essa tenterà di ottenere alle molte sue perdite, all'epoca dello smembramento dell'Impero d'Oriente, in alcuna delle provincie più occidentali di questo. E neppure al gran Signore si presenta minacciosa ed ansiosa di affrettare quello smembramento, dal quale nulla spera e nulla ambisce. Solo la Corte di Roma ne considera con timore, sospetto ed avversione; e n'ha ben d'onde, poichè essa e il Regno d'Italia non possono convivere pacificamente sul suolo italiano. Quindi la Spagna ciecamente divota, non dirò solo alla Chiesa di Roma, al suo pontefice ed alla religione cattolica, ma al potere temporale altresì, ne guarda anch'essa di mal occhio, e vorrebbe ricacciarne nel nulla. – Noi non affrettiamo con atti la caduta del potere temporale, ma lo prevediamo non molto distante, e non cospireremo certamente per prolungarne l'agonia.
Da ogni lato vediamo segni di futura pace per la patria nostra; nessun pericolo sembra minacciarla per parte dell'Europa. – Se non fabbrichiamo a noi stessi pericoli, nemici e catastrofi, abbiamo davanti a noi molti anni di tranquillità, nel corso dei quali possiamo procedere al nostro sviluppo e a quello delle nostre libertà.
CAPITOLO SECONDO
INFLUENZA DEL PASSATO
Pressochè tutti gli Stati, e tutte le nazioni europee camminarono sopra linee parallele, e durante un numero quasi identico di secoli, dalla barbarie cioè dei bassi tempi alla odierna civiltà. – Alcune camminarono con più celere passo di altre, aiutate o dalla propria loro indole, o da circostanze favorevoli, alcune rimasero e tuttora rimangono qualche poco addietro: ma tutte hanno la faccia volta verso la stessa meta; tutte incontrarono ostacoli pressochè identici e della medesima natura, li combatterono con armi simili, e ne trionfarono in modo più o meno completo, a prezzo di maggiori o minori sacrifizi. Quelle nazioni o quelli Stati, che ancora non raggiunsero il punto in cui trovasi il più gran numero delle nazioni e degli stati di Europa, sono però assicurate di raggiungerlo esse pure in breve, seguendo i passi delle prime, cioè delle più celeri. Le tappe sono per così dire segnate dalla storia, che ne addita come i popoli si aggrupparono componendo gli Stati, e tendendo per prima cosa ad ingrandirsi a dispendio dei vicini; i piccoli gruppi, essendo come stati assorbiti e trangugiati dai maggiori, scomparvero dalla scena, e come i capi delle nazioni deposero di quando in quando la spada per assestare i loro possessi ed afforzare la loro autorità. Tutti ebbero a combattere il medesimo avversario, il feudalismo. – Quei potenti baroni dell'età media, che avevano aiutato uno dei loro ad accumulare armati e ricchezze sufficienti per mantenersi al di sopra delle altre picciole nazioni, o per incorporarsele, diventarono ben presto rivali del capo da essi scelto e creato. – Allora cominciò la interna lotta delle monarchie contro i feudatarii, lotta lunghissima e tremenda, nella quale le monarchie trionfarono mediante l'abuso della forza unita alla perfidia e alla crudeltà, e di cui, se non tutte, buon numero almeno delle Case regnanti di Europa, porta la pena, nella diffidenza e nella secreta avversione che la loro autorità, e qualche volta il solo nome di Re desta nei popoli che loro obbediscono.
L'Italia sola ha tenuto altre vie; l'Italia sola ha una storia tutta propria. – Mentre le altre nazioni europee, formate di elementi barbarici e di pochi avanzi degli antichi popoli soggetti dell'Impero Romano, muovevano i primi passi verso la civiltà, l'Italia, già signora del mondo allora conosciuto, decadeva e deperiva. – Culla di quel popolo straordinario, che si era fatto una civiltà anzi tempo e prematura, ma grande e bella, l'Italia fu sempre una eccezione nella storia. – Essa non ha mai nè dimenticata nè intieramente abbandonata la romana civiltà; anzi ne serba tuttora quei brani che non contrastano al cristianesimo e alle moderne nozioni del diritto e della morale.
Le arti e le scienze, che le nazioni barbare versate dal Nord e dall'Oriente sulla intera Europa ignoravano assolutamente, furono sempre onorate e coltivate dagli Italiani. – I popoli della nostra penisola non caddero mai in quel profondo abisso d'ignoranza e di servitù necessario alla formazione di un potere assoluto ed iniquo nell'esercizio suo, ma che solo poteva farsi rispettare ed obbedire dalle orde germaniche, elemento predominante delle moderne nazioni. – Agli Italiani mancò la barbarie e le sue sfrenatezze, ma loro fecero difetto altresì la cieca obbedienza a capi avveduti ed ambiziosi, la brutale energia degli odi e della rapacità, la ignoranza dei propri diritti, tutte quelle passioni e quei vizi insomma che la Provvidenza volgeva ad uno scopo benefico, e di cui oggi vediamo e conosciamo i definitivi risultati.
Mentre le nazioni europee si sdegnavano e spogliavano di tutto ciò che non era virtù guerriera, e guerriere come erano divenute, tremavano sotto il giogo dei loro capi, più esperti, più accorti, più crudeli e snaturati delle nazioni stesse; gli Italiani, superbi della loro civiltà e della loro supremazia intellettuale e civile, guardavano ai barbari con disprezzo, e credevano annichilarli con beffe e motteggi.
Più tardi, quando impararono a temerli, impararono altresì a volgerli ai loro fini; e il sentimento nazionale, ai nostri dì sì possente, non essendo ancora svegliato, accadde che gli abitanti di una città italiana invocarono le armi dei nuovi popoli europei, per castigare un'altra delle città italiane, o per trarne vendetta, o per ridurla a non potersi sostenere da sè. – Quella civiltà così generalmente sparsa ed egualmente ripartita in tutta la nostra penisola, e in tutte le classi de' suoi abitanti, si oppose sino da quei primi tempi all'ingrandimento di una parte di esse a prezzo della indipendenza delle altre parti; ed appena un cittadino predominava nella città sua e minacciava le città rivali, queste si riunivano per debellare l'ambizioso; e se a ciò non bastavano da sole, chiamavano le nazioni guerriere dal di là delle Alpi, adescandole con promesse di ricca paga o speranze di bottino e di accresciuto potere. – Il feudalismo stesso, che ebbe sulle prime una così gran parte nella formazione della nuova società politica dell'Europa, non potè svilupparsi in Italia fra quelle numerosissime città, che assorbivano ogni prosperità ed ogni operosità popolare, e riducevano ad inferiori condizioni i comuni rurali, vera e natural sede del potere feudale.
Le campagne italiane ebbero sempre poca parte nella vita politica, e quei signori stessi che dominarono in alcune città, e che corrispondono fra noi ai feudatari del Nord, erano cittadini, vivevano nelle città, dovevano assicurarsi il favore de' loro concittadini; e se fallivano in ciò, erano quasi sempre rovesciati e distrutti, i loro beni confiscati, e le loro famiglie e i loro aderenti mandati in esilio.



