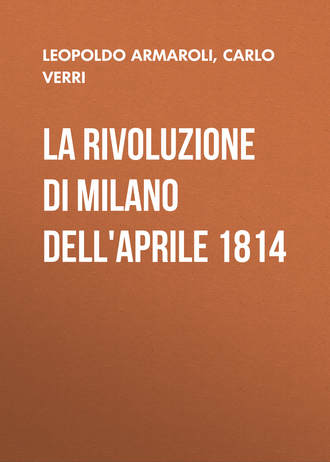
Полная версия
La rivoluzione di Milano dell'Aprile 1814
In forza di un dispaccio del duca di Lodi, cancelliere guardasigilli della corona, fu convocato straordinariamente il Senato nel giorno 17 aprile. È rimarcabile che di un affare, a cui si pretese di attaccare un sommo mistero, se ne parlasse contemporaneamente ne' caffè, e piú nella platea del teatro della Scala, e che i soli senatori ne fossero all'oscuro, come quelli che tali luoghi non frequentavano. Fu letto un messaggio del duca di Lodi in cui, dopo aver fatto un quadro per verità molto vago della situazione del Regno, presentava al Senato un progetto di decreto per autorizzare una deputazione a chiedere a S. M. l'Imperatore d'Austria, e pel di lui organo alle Alte Potenze, la cessazione assoluta delle ostilità, l'indipendenza del Regno ed un re nella persona del Principe. Che non si macchinò, che non si disse, perché a sorpresa si adottasse la deliberazione proposta? Fermi i senatori nella loro massima, vollero che la materia si digerisse prima da una commissione di sette membri, la quale prendesse, siccome fece, i migliori schiarimenti dal duca di Lodi e riferisse. Sul rapporto della medesima fu adottata la deputazione per i due primi oggetti della cessazione delle ostilità e dell'indipendenza del Regno, esclusa la domanda del Viceré in nostro Sovrano, come diffusamente risulta dagli atti di quella seduta espressi nell'allegato num. 1 con gli analoghi documenti A, B, C. Pareva che i patrizi milanesi dovessero esser paghi del contegno dignitoso del Senato e della sua risoluzione. Se la loro volontà era quella dimostrata, che non si ricercasse il Principe in re, il Senato era stato del loro avviso. Indispensabile era la deputazione, per l'effetto della capitolazione col Feld Maresciallo Conte di Bellegarde. Sapevano tutti che a vuoto andarono le pratiche per la nomina de' conti Prina e Paradisi; sapevano che la scelta era caduta nel conte Guicciardi, uomo di Stato non secondo a veruno, il primo ed il piú acerrimo impugnatore del progetto del duca di Lodi; nel conte Luigi Castiglioni milanese, cavaliere di cui il solo nome bastava a giustificare la nomina. Si arrivò a spargere il dubbio, che le istruzioni date ai deputati dal duca di Lodi fossero divergenti dal decreto del Senato, quasi che questi fossero uomini da riceverle tali; quasi che le AA. PP. potessero ammetterle in contraddizione: tutto era artifizio e pretesto. Come i rivoluzionari erano prima de' senatori intesi del messaggio e del progetto del duca di Lodi, cosí mediante lo stesso mezzo conoscevano benissimo le istruzioni del medesimo, le quali a comune intelligenza si danno al num. 2, unitamente alla di lui credenziale per il principe di Metternich, ministro di S. M. l'Imperatore d'Austria, num. 3. La sola intenzione loro fu quella di rovesciare la macchina del governo, di figurare da popolo sovrano, di trattare in piena confidenza con i potentati della terra, di fissar essi i futuri destini del Regno, senza il concorso di tutti i rappresentanti del medesimo, che come forestieri non dovevano entrare a parte degli alti loro consigli, far circolar calunnie, assoldare gente facinorosa, insultare la rappresentanza nazionale, trascorrere rapidamente di delitto in delitto; tutto ciò doveva operarsi, onde giungere allo scopo proposto, e tutto ciò fu maturatamente macchinato nel circolo di alcune primarie famiglie, d'onde partí l'allarme disseminato ne' luoghi pubblici. Le prime sottoscrizioni del foglio che forma l'allegato al num. 5, possono spandere gran luce sull'orditura della presente catastrofe.31
Si farebbe un torto all'accortezza ed ai vasti talenti di chi presiedeva alla polizia dello Stato, se si supponesse che tante pratiche rivoluzionarie sfuggissero alla di lui vigilanza. Non si sa quindi concepire come egli o il Principe non vi provvedessero, mentre, essendo spogliata di truppe la capitale, poteva ottenersene in qualunque numero nella vicina Cremona e forse anche in Lodi. Non si spiega neppure come nel giorno venti, quando cadeva l'ordinaria seduta del Senato, si mandasse contro il solito alla custodia del palazzo, non l'ordinaria guardia, ma un picchetto non piú forte di otto o dieci coscritti, e cresce la maraviglia nell'essersi visto al portone del medesimo il capitano Marini, aiutante di piazza, che disse essere stato spedito per riparare qualche disordine che si temeva: qual riparo poteva opporre un solo uffiziale isolato, e neppur milanese?
Fu piú o meno piovosa la giornata de' venti aprile. Con tutto questo, verso un'ora pomeridiana, quando si radunavano i senatori, si videro nell'esterno del loro palazzo, sotto seriche ombrelle, una nobile corona di soggetti decorati e addetti per la massima parte alla Corte, da' quali tutt'altro poteva temersi che disordine; quivi era un conte Federico Confalonieri, marito di una dama di palazzo; quivi due fratelli Cicogna, l'uno ciambellano e scudiere l'altro; lo scudiere Ciani; quivi un Fagnani, che riuniva all'onore di ciambellano il rango di consigliere di Stato, e che, a spese del governo, aveva poc'anzi fatto il viaggio ed un lungo soggiorno in Russia; quivi, in uniforme, diversi uffiziali della guardia civica, tra li quali si distinse il capitano Benigno Bossi; quivi piú rampolli d'illustri famiglie, e Silva, e Serbelloni, e Durini, e Castiglioni, ed altri diversi. Si notò un uomo di alta statura con alle mani una breve scala, sulla quale uno degli astanti saliva all'arrivo di ogni carrozza, per riconoscere il senatore che era in essa. Si seppe poi esser quegli un domestico travestito di alcuno dei cavalieri surriferiti. All'arrivo de' senatori facevano plauso ad alcuni, accompagnavano altri con urli plebei e con fischi, e precisamente quelli che in Senato avevano nel dí 17 mostrato di aderire al progetto del duca di Lodi; tanto è vero che erano al pieno giorno di ciò che si era parlato e risoluto in quella seduta, e non era che per un indegno pretesto che calunniavano l'intero corpo, accusandolo di quello che con piú di due terzi di suffragi aveva escluso.
Al momento della convocazione, alla quale non erano intervenuti li conti Paradisi e Prina, si erano confusi intorno al palazzo, con gli altri astanti cavalieri, diversi uomini di truce aspetto, che poi si seppe essere sicari stipendiati, e molti altri del popolo chiamati dalla curiosità, e varie indistinte voci cominciarono a sollevarsi. Si riuní nella sua sala il Senato, ove doveva solamente farsi leggere ed approvarsi il processo verbale della seduta antecedente. Prima di procedersi a tale lettura ed all'appello nominale e mentre l'esterno rumore cresceva, partecipò il presidente, non officialmente, ai senatori, che il Podestà di Milano aveva spedito al duca di Lodi ed a lui la copia di un'istanza fatta alla Municipalità, in cui si chiedeva, che nell'attuale posizione del Regno si adunassero i collegi elettorali, per trattare in essi della cosa pubblica. Il Podestà diceva nella sua lettera di attendere su di essa le analoghe deliberazioni del Senato, allegati num. 4 e 5. La prima era firmata da 141 cittadini, e si dicevano per brevità ommesse molte altre firme. Erano firmati i primi il conte Pino generale di divisione, il conte Luigi Porro, il conte Giacomo Trivulzio, il conte Federico Confalonieri, il conte Federico Fagnani con la qualità di consigliere di Stato, il conte Giberto Borromei, Giacomo Ciani. De' consiglieri di Stato non vi era, oltre il conte Fagnani, che il conte Lodovico Giovio col solo carattere di elettore; vi erano il colonnello e molti uffiziali della guardia civica, tra i quali meritano attenzione il capo battaglione Pietro Balabio e il capitano Benigno Bossi: erano pure firmati nello stesso foglio il Podestà ed i Savi municipali.
In questo mentre chiese ed ottenne il permesso, e fu da un usciere introdotto nella sala il capitano aiutante Marini, il quale espose che gli ufficiali della guardia civica esclamavano ad alta voce di voler essi presidiare il Senato e difenderlo. Vi aderí il presidente e ne diede in iscritto l'autorizzazione, non sapendo neppure concepire il sospetto, che discendere si potesse all'infamia di tradire la fiducia dell'unico corpo di rappresentanza permanente del Regno, quando inerme si abbandonava in braccio de' cittadini della capitale, che ultroneamente offerivano assistenza e difesa. Ma il primo loro passo fu di accorrere con una forte e preparata pattuglia, e cacciare bruscamente e con una somma indecenza dai loro posti i soldati di linea, e quelli persino che erano all'immediata porta della sala della seduta.
Prima di quel momento niuno del popolo aveva ardito di penetrare nel palazzo, niuno aveva ardito di sforzare i soldati di linea che erano schierati alla porta. Il solo conte Confalonieri si era appressato piú degli altri, e la sola sua voce si ascoltava esclamando: «Noi vogliamo la convocazione dei Collegi elettorali, e che si richiami la deputazione del Senato!». Tutto che il capitano Marini gli insinuasse che fosse entrato in seduta e senza innalzare in istrada clamori plebei e sediziosi avesse manifestati ai senatori i suoi voti, rispose di non poterlo fare, perché destituito di carattere e di rappresentanza, ma intanto sempre piú sollevava la voce, ripetendo le cose stesse.
Non appena i soldati di linea si ritirarono nell'appartamento del custode, non appena il palazzo fu in balia della guardia civica, che fu dato l'adito indistintamente ai grandi, ai sicari ed alla plebe di penetrare in esso liberamente. Il conte senatore Verri si offrí di perorare al popolo, ed a lui si unirono li conti senatori Massari e Felici. Piú volte andarono e tornarono e riferirono sempre l'inutilità de' loro sforzi, perché non emergeva cosa volesse un popolo tumultuante che sollevava grida confuse. Il conte Verri dette in Senato una carta che disse essergli stata posta in mano da persona incognita e che non si ebbe tempo di leggere. Alcun senatore, che vi gittò sopra una rapida occhiata, vide che era scritta di carattere alterato, e nel primo paragrafo esponeva che, come la Spagna e la Germania avevano dato l'esempio, cosí doveva scuotersi dagli italiani il giogo francese.32 La moltitudine si tratteneva nella gran corte, e niuno si faceva lecito di salire il maestoso scalone del palazzo. Furono i civici ufficiali che la incoraggiarono, la spinsero, e già in un momento il gran portico contiguo alla sala della seduta ridondava di popolo. Di piú, due cavalieri erano alla porta della prima anticamera, e senza entrare in essa si limitarono a prestare il loro nobile officio ed introdurre a forza que' tali che alla medesima si avvicinavano. Finalmente si restituí l'ultima volta in seduta il conte Verri, e palesò che non restavano che due soli minuti a deliberare, o tutto era perduto. Si domandò cosa alla perfine si domandasse dai senatori. Gli uffiziali della guardia civica, e tra essi il capo battaglione Pietro Balabio, erano entrati nella sala con viso pallido, alteratissimo, come di uomini cui non erano famigliari i delitti. Il capitano Benigno Bossi esclamò ad alta voce che si voleva il richiamo della deputazione e la convocazione dei Collegi. Il presidente, sull'insinuazione di qualche senatore e senza alcuna precedente regolare deliberazione, scrisse: «Il Senato richiama la deputazione e riunisce i Collegi». Lo stesso capitano sortí dalla sala con questo foglio, e quindi, senza aver parlato con persona, come attestano gli uscieri del Senato, rientrò esclamando essere intenzione del popolo che si dichiarasse sciolta la seduta, e questo stesso scrisse di nuovo il presidente, con aggiungerlo in altro foglio in questi termini: «Il Senato richiama la deputazione, e riunisce i Collegi elettorali, ed è sciolta la seduta». Piú di trenta copie ne furono all'istante scritte dai segretari, dagli impiegati e dalli stessi uffiziali civici, che dopo averle fatte soscrivere dal presidente le recavano al di fuori.
Ciò conseguito si attendeva che fosse dissipato il tumulto; ma ben altre essendo le viste dei tumultuanti, crebbe anzi il disordine sempre piú. I senatori sortir dovettero da altra porta, e dietro di essi si affollò con impeto il popolo concitato. Il conte Confalonieri fu il primo a scagliarsi contro il ritratto di Napoleone dipinto dal celebre Appiani, che con l'ombrello ruppe e gittò dalle finestre, dalle quali egli il primo cominciò a gettare le suppellettili della sala. Il suo nobile esempio fu avidamente eseguito dalla plebe. Sedie, tavolini, specchi, stufe, persino le persiane, le stesse porte, tutto fu fracassato e gittato in istrada. L'istessa sorte subirono i parati, i tappeti e parte delle carte e dei libri. Non erano ancora tutti i senatori fuori del palazzo che tutto era in preda al saccheggio, da cui fu solo in quel giorno risparmiata la segreteria, e l'appartamento del conte cancelliere. Niuno dei senatori fu offeso nella persona, alcuno solamente fu urlato di nuovo.
Cessò la depredazione e lo spoglio, allorché alcuno dei capi andò spargendo la voce che era tempo di portare la vendetta ed il furore contro il Ministro delle finanze. Tutto il popolo, ed alla testa di esso quelli che si coprivano di seriche ombrelle, corsero al di lui palazzo. Infelicissimo conte Prina! Egli era stato avvertito fino dal giorno innanzi di quanto si macchinava contro di lui; nella mattina fece ogni sforzo un di lui cugino per condurlo a Pavia nella propria vettura: impavido volle rimanere al suo posto, fidato nell'attività della polizia, nella facilità di reprimere una sommossa al suo primo scoppio, e nell'opinione invalsa sempre che l'ardore della plebe milanese fosse fuoco di paglia, ristretto, come si vede giornalmente nelle loro risse, a semplici parole, non estensibili ad eccessi di fatto. Tanto è vero che a niuno è dato di evitare il proprio destino, contro il quale non siamo trattenuti né dalle sollecitazioni di persone sensate, né dalla forza e dalla maturità del raziocinio, né dalla evidenza stessa del pericolo! Non fu che la presenza del medesimo che inducesse il conte Prina a pensare finalmente alla sua salvezza: atterrate le porte, fuggiti i domestici, invaso da ogni parte ed occupato il palazzo, fu allora che si risolvette a nascondersi; ma non era piú in tempo, non vi rimase piú scampo veruno. Inutilmente il mantovano Barone de Peyri, generale di divisione, si cacciò in mezzo alla folla in uniforme e tentò di salvarlo; nulla ottenne se non qualche momento di sospensione, e terminò col farsi strappare le fibbie d'oro dalle scarpe e le catene degli orologi. Il conte Prina fu rinvenuto, fu preso, denudato, percosso, strascinato, e rovesciato a capo in giú da una finestra.
Rifugge l'animo a rammentare la lenta carneficina e il feroce trastullo fatto a sangue freddo di un uomo cui pure niuno niega che fosse per ingegno, per facondia e per dottrina chiarissimo, e della di cui onestà ha fatto fede non dubbia il ristretto patrimonio lasciato. Mentre il basso popolo si è abbandonato al saccheggio del palazzo, dopo averlo spinto gli altri nell'atrio di una casa contigua, gli hanno fatto percorrere tutta la contrada del Marino sino alla piccola piazza del teatro della Scala: questa e quella erano ricoperte di agitate ombrelle vario-colorate. Vicinissimi erano il palazzo della polizia, quello del ministero della guerra, quello dell'intendenza ove un folto numero si era raccolto di guardie di finanza. A tutti fu interdetto di accorrere in suo aiuto; chi solo aveva mezzi ed autorità per salvarlo, se si fosse prestato con un atto di volontà deliberata, e non con ciarle artificiosamente vaghe, anzi allarmanti, passeggiava in una contigua contrada in compagnia del conte Luigi Porro. Un buon negoziante di vino, esso solo ascoltò un sentimento di pietà, ed in un opportuno contratempo lo strappò dalle mani della moltitudine e nella sua cantina il nascose. Furenti erano gli ammutinati sul timore di averlo perduto. Scoprirono l'asilo, minacciarono d'incendio il mercante, finché l'infelice Prina, visto il pericolo del suo benefattore e non isperando per sé altra risorsa qualunque, si offerí in istrada alla ferocia de' suoi assassini, e «sfogatevi, disse, sfogatevi pure sopra di me, poiché sono già immolato alla vostra rabbia; ma fate almeno che sia l'ultima questa vittima». Estreme, memorande parole, dopo le quali non ebbe piú lena di proferirne. Fu allora che in mezzo agli scherni ed agli insulti volle ciascuno la sua parte di gloria nel percuoterlo coi puntali delle loro ombrelle. Per circa quattro ore gli fu fatto desiderare un colpo decisivo, che terminasse lo strazio. Egli è morto e strascinato per la città con torchi accesi, e trasfigurato tanto che aveva perdute le forme e l'effigie. È fama che il giudice di pace, nell'ispezione fatta del suo cadavere, non trovasse chi lo riconoscesse, come che non trovassero i professori tra le tante contusioni una ferita, una offesa veramente mortale: egli è morto d'angoscia e di spasimo.
Intanto chi può descrivere lo spoglio totale del suo palazzo, e la veemenza e la prontezza della rapina? In poche ore non vi erano piú suppellettili non meno ordinarie che preziose, non una porta, non una finestra, non una pianta, non una persiana, un vaso, un utensile nell'amenissino giardino annesso. Tant'oltre si spinse la depredazione e la devastazione che tutte furono schiantate e rubate le moltissime ferrate, e cosí i calcani delle porte, i chiodi, i condotti, i canali dei tetti. I tegoli stessi furono sollevati tutti e scomposti, per la smania d'indagare nel tetto alcun tesoro nascosto. Insomma, un ampio, maestoso e ricco palazzo pubblico fu ridotto in brevi istanti uno scheletro trasparente, che il governo ha poi giudicato miglior partito di far demolire e formarci una piazza, la quale offrirà maggior comodo alle carrozze affluenti al vicino teatro.
Il Podestà di Milano, in mezzo all'imponenza di tanta sciagura, non trovò altro compenso che far stampare ed affiggere il decreto estorto al presidente del Senato, e successivamente pubblicare egli stesso un proclama, in cui dichiarò che il generale Pino andava ad assumere il comando delle forze della capitale, che i Collegi elettorali de' dipartimenti non occupati dalle armi delle AA. PP. coalizzate si sarebbero riuniti in una sola camera, al piú tardi nel giorno 22 dello stesso mese, e che il Consiglio comunale della capitale si radunava nell'indomani, tenendosi in seduta permanente sino a che le circostanze lo esigessero, e che i reclami tutti si dirigessero alla Municipalità che li avrebbe fatti pervenire ai Collegi.
La giornata del ventuno fu una forse delle piú allarmanti e terribili, che abbia mai veduto Milano. Il folto popolo, allo spuntar del giorno, era in aspetto sedizioso per le contrade tutte della città. Le botteghe chiuse nella maggior parte, le guardie della finanza avevano abbandonate le porte della città ed i cosí detti dazî, un immenso numero di gente di campagna, armati altri di bastone, altri di lunghi chiodi resi acutissimi, scorreva d'ogni intorno, designando con lo sguardo la preda, e ne' complotti le persone de' proscritti e le case da saccheggiare. Si è detto che alcuni siano stati trovati muniti di pugnali, chi di ben organizzati capestri. Invano il Consiglio municipale pubblicò di avere nominata una Reggenza provvisoria, composta de' signori generale Pino, Carlo Verri, Giacomo Mellerio, Giberto Borromei, Alberto Litta, Giorgio Giulini e Bazzetta; invano il generale Pino pregò, in un suo proclama, che si avesse fiducia in lui e che si stesse pacifici spettatori delle determinazioni che si andavano a prendere dalle AA. PP.; invano il corpo municipale si espresse, in altra stampa, che il popolo poteva darsi quella forma di governo che piú desiderava, che la sua libera volontà fosse partecipata ai Collegi, i quali avrebbero adottati quei mezzi, che il popolo stesso avesse giudicati piú opportuni alla sua felicità; invano il Vicario capitolare esortava nelle viscere di G. C. alla tranquillità, ordinava pubbliche preci con un triduo; invano lo stesso generale Pino, per salvare la forse minacciata persona del duca di Lodi, espose quelle dei senatori, avendo dichiarato in altro proclama che il duca non aveva avuto parte alcuna negli affari seguiti in Senato, poiché era in quei giorni gravissimamente infermo, e che le carte andate in Senato erano state fatte da tutt'altre persone, e neppure firmate da lui; invano il direttore delle privative e dei dazî di consumo, in un suo avviso che di concerto fu fatto col generale Pino, col cavaliere Podestà e col Consiglio comunale, aveva ridotto alla metà il prezzo dei sali e dei tabacchi e la tariffa dei dazî consumo; invano il primo atto della Reggenza fu quello di abolire la tassa del registro.
Tutto fu inutile: non era opinione politica, non desiderio di una piuttosto che di un'altra forma di governo, non animosità contro il medesimo o contro il Principe, non sentimento di pubblico bene, che animasse la moltitudine.33 L'unico centro del voto generale era la rapina e la depredazione, e già si era tornato a compiere il guasto del palazzo del ministro e si era tentato in quello del Senato; fortunatamente il rimedio del male emerse dal male stesso. Emporio ricchissimo in merci, in derrate, in danaro era la dogana generale, ossia il cosí detto Dazio grande nel palazzo del Marino, ove e fondachi e doviziosi depositi erano affidati dal commercio milanese, essendovi pure gli uffici del ministero delle finanze e di varie sue direzioni generali. Vi si diressero gli ammutinati, sotto pretesto di disperderne e distruggerne le scritture. Fu allora soltanto che, nell'affannosa trepidazione del loro cuore, si mossero ad un tratto i negozianti, con una energia imperiosissima. L'unirsi a tal voce i padri, i figli, i giovani, i garzoni, gli amici, i conoscenti, il correre ai quartieri, l'armarsi di fucili e il dividersi in numerose pattuglie, fu pressoché un punto solo. Il presidente del Consiglio comunale ed il generale Pino, con altri proclami, chiamarono all'armi tutti i cittadini indistintamente. Il Consiglio credette di aggiungere eccitamento, con accordare un distintivo nazionale in una coccarda rossa e bianca. Di egual saccheggio era minacciato il palazzo della Corte. La guardia reale, i cannoni e lo stesso generale Pino la difendevano debilmente. Il generale fu insultato, la guardia forzata piú volte ed astretta a ritirare dalla piazza i cannoni e nel palazzo celarli. La stessa milizia civica marciava pavida ed incerta. Si fecero sbarrare le strade che conducevano al palazzo del Marino, ma le sbarre erano a gran pena difese.
Un'accidentale combinazione presentò alla milizia un vantaggio decisivo sul popolo. Andavano le pattuglie, per un certo riguardo, colla punta della baionetta rivolta verso la canna del fucile, ma una di esse aveva i fucili tanto dalla ruggine investiti che non gli fu possibile di togliere dalle canne le baionette. Presentatasi in piazza s'intese un subitaneo fremito popolare, nel quale si distinguevano le parole: «a basso le baionette.» Il che non ottenutosi, furono tratti de' sassi sulla pattuglia; la quale essendo forte in numero, fattosi coraggio, abbassò le armi e corse a passo di carica sugli ammutinati, che si dissiparono all'istante. Questo primo esperimento felice fu efficace, perché si vedessero subito in aria le punte delle baionette di tutte le pattuglie, perché si disperdessero i crocchi, perché i piú rivoltosi pertinaci nella loro insolenza si arrestassero. Molti e ben molti arresti seguirono nel rimanente del giorno e durante la notte; molti la polizia trovò tra questi che, facinorosi e debitori di delitti anche gravi, eludevano da piú anni la sua vigilanza e che, fidati allora nell'anarchia e nell'impunità, erano accorsi, e forse stipendiati, al bottino. Cosí terminò, senza altri orrori, quella nera giornata, in cui ebbe luogo soltanto il saccheggio di altra casa di campagna del conte Prina. Frattanto arrivò nella notte un corpo di cavalleria italiana, parte della quale salvò dal proclamato spoglio la regia villa di Monza e parte rinforzò l'efficacia della milizia.
Cessato lo spavento per il temuto disastro, di cui massimo bersaglio sarebbero stati i ricchi, tra' quali entravano quelli stessi che il primo impulso gli dettero, riavutisi questi appena dall'allarme, riammessero nel giorno 22 di aprile la marcia rivoluzionaria, e tutto lo studio loro rivolsero a distruggere la costituzione ed a sollevarsi ad una chimerica sovranità. In quel giorno ebbe luogo la prima sessione dei Collegi elettorali, illegalmente convocati, piú illegalmente costituiti. I soli elettori milanesi, compresi alcuni pochissimi appartenenti ai dipartimenti non invasi i quali erano in Milano per funzioni governative, essi soli, in numero di circa settanta, disponendo della sorte del Regno come di una loro proprietà baronale, approvarono la Reggenza, a cui si riserbarono di aggiungere altri individui per li detti dipartimenti, dichiararono il general Pino comandante in capo delle forze dello Stato, sciolsero tutti i sudditi e tutte le autorità civili e militari dal giuramento verso il sovrano, ordinando che altro se ne prestasse giusta gli ordini della Reggenza. Dichiararono come non avvenuta la deputazione del Senato, che cessato dissero; ordinarono la dimissione dei detenuti per motivi di opinione, di coscrizione, di finanza; ed accordarono amnistia ai disertori e refrattarî. Situatisi quindi al livello dei governi del piú alto rango ed assunto il tuono ed il linguaggio de' primi gabinetti, decretarono che «si avvertissero non meno i Comandanti delle Alte Potenze, che l'Armata Italiana della nomina fatta del general Pino, e che un indirizzo si facesse alle stesse Alte Potenze, pregandole a voler concorrere alla felicità del paese».

