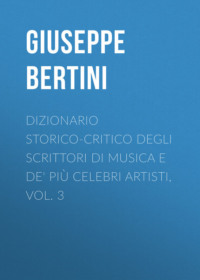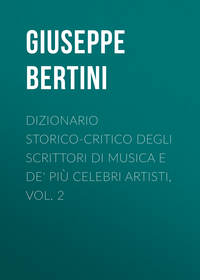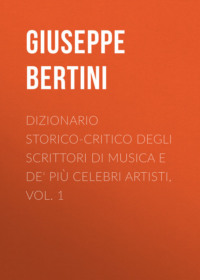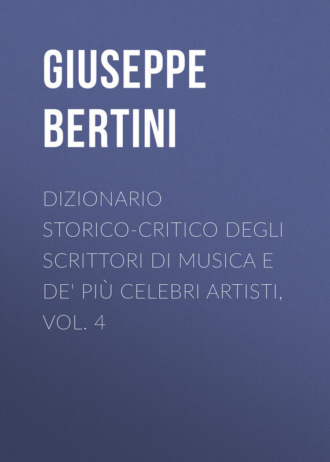
Полная версия
Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 4
Say (Samuele), ecclesiastico di Londra, ivi morto nel 1745, si distinse per le sue virtù, e per le vaste sue cognizioni: era molto perito delle mattematiche, e buon letterato aveva sommo gusto per la musica e la poesia. Egli avea scritto alle preghiere di Richardson due Saggi sull'armonia, sulla varietà e 'l potere de' numeri, che furono pubblicati dopo la di lui morte in un volume in 4º, Londra 1749.
Scarlatti (cavalier Alessandro), nato in Napoli, fu allievo in Roma del Carissimi, maestro della cappella pontificia. Egli si rese cel. come compositore in tutti i generi: fu il primo che più contribuì a fissare e perfezionare nel contrappunto la chiarezza, l'espressione e le grazie, conservandovi sempre la nobiltà e semplicità convenevoli, onde dagli italiani veniva chiamato l'onor dell'arte, e il capo de' compositori. Fu egli altresì il primo a tentar di ritorre all'infanzia de' secoli la musica instrumentale. Prima di lui non si sentivano sui teatri d'Italia altre ouverture o sinfonie che quelle di Lulli: Scarlatti scosse il giogo, uscì in campo con ouverture di suo conio, e rispondendo il successo all'impresa, fu riputato un genio. Fu alla corte di Baviera, e in quella di Vienna dove scrisse delle opere italiane per que' teatri con esito felicissimo: venne poi in Roma e dopo aver molto composto pel teatro e per la chiesa, divenne cavaliere, e maestro di cappella della corte di Napoli, ove passò tranquillamente il resto de' suoi giorni, ed impiegò i suoi talenti a formare degli allievi degni di lui. Tra questi distinguonsi il Sassone, il Durante, ed altri rinomati maestri. Scarlatti, fu singolarmente il compositore più fecondo, e più originale di cantate per camera. Il suo genio era effettivamente creatore; alcune collezioni manoscritte, notate di sua mano con la data di ciascun pezzo, provano ch'egli ne componeva assai volte una per giorno. Ad eccezione di alcuni periodi, che hanno di già invecchiato, la sua cantilena ha nondimeno la freschezza della novità; e vi si riconosce la più parte de' motivi e de' tratti di melodia, di cui si sono serviti dopo di lui i migliori compositori de' primi 40, o 50 anni dello scorso secolo. Durante ne ha formati de' duetti; Sacchini se ne serviva per dare scuola di canto nel conservatorio di Venezia, ed al fine di ogni lezione, baciava rispettosamente il libro che le conteneva. Tutti i gran maestri hanno avuta sempre somma stima per lo Scarlatti. Hasse parlando di lui diceva, che in riguardo ad armonia egli era il più gran maestro dell'Italia; Jommelli riguardava la sua musica di chiesa come la migliore in questo genere: le sue messe sorpassano il numero di 200. Nel 1725 Quanz trovò Scarlatti in Napoli, che scriveva ancora per chiesa all'età di 75 anni, e che sonava molto bene di arpa. A Roma se gli attribuisce il merito di aver molto perfezionata la scuola di canto. A lui si deve altresì l'invenzione de' recitativi obbligati. Alessandro aveva una figlia per nome Flaminia, che cantava egregiamente: il cel. pittore Franc Solimena la ritrasse per amicizia frequentando la sua casa, insieme con suo padre al cembalo, con tal grazia ed evidenza involta in una veste da camera, che si mostra il di lei ritratto per maraviglioso a' forestieri. (V. Signorelli Coltura delle due Sicilie, t. 6).
Scarlatti (Domenico), figlio del precedente, nato in Italia nel 1683, fu mandato da suo padre a studiar musica in Roma sotto Francesco Gasparini compositore e cembalista assai celebre, di cui aveva alta opinione il vecchio Scarlatti. Domenico trovandosi in Venezia nel 1709, mentre eravi il cel. Hendel, restò così preso de' suoi talenti, che venne seco in Roma per godere più lungamente del piacere di sentirlo. Venne egli di poi chiamato alla corte di Madrid per dar lezioni di musica alla principessa dell'Asturie, che continuò ancora divenuta essa regina di Spagna. Compose e dedicò alla medesima le sue opere di sonate per cembalo che furono impresse a Venezia, e divenne cavalier di S. Giacomo. Egli viveva sino nel 1757, e brillava in quella corte come gran sonatore di cembalo e compositore insieme. Il Sassone, che lo aveva conosciuto in Napoli, ne parlava ancora cinquant'anni dopo con molto entusiasmo, ed ammirava sopra tutto la sua grande attitudine e l'abbondanza della sua immaginazione. Giuseppe Scarlatti suo figlio, nato in Napoli verso il 1718, passò la più gran parte di sua vita a Vienna, ove fu stimatissimo, sì come compositore, che pel suo talento straordinario nell'insegnare il cembalo. Differente dagli altri Scarlatti, il di lui stile si distingue per la sua facilità e grazia. Egli ha scritto la musica di più drammi italiani, e serj e burleschi, pel teatro di Vienna, ove morì nel 1776.
Scarmiglioni (Guido Ant.), di Foligno, professore di filosofia e medicina in Vienna, morì nella sua patria nel 1620. La sua dissertazione De sonis gli dà il dritto di essere compreso nel numero degli autori di musica.
Scheibe (Giov. Adolfo), figlio di un cel. costruttore di organi a Lipsia, sino dall'età di 9 anni si diè allo studio della musica, senza tralasciare in seguito di coltivare le altre scienze. Ad una grande abilità sul cembalo e l'organo unì egli lo studio degli autori di teoria musicale, e delle antiche partizioni, aspirando ad un posto di organista o di compositore; ma non avendo potuto nè l'un, nè l'altro ottenere, cercò di far fortuna almeno come autore. Cominciò a pubblicar dunque il suo Musico-critico, opera periodica, di cui dava un foglio per settimana. Mitzler e Schroeter gli suscitarono delle dispute per aver sostenuto, che le matematiche erano assolutamente inutili nell'arte della composizione. Alcun tempo dopo ottenne egli il posto di maestro di cappella del re di Danimarca, e nel 1745, pubblicò a Lipsia la seconda edizione in 4 vol. accresciuta di tutte le quistioni, che gli era stato d'uopo discutere. Vi si trovano in essa alcune nuove dissertazioni, del Recitativo; dell'Origine progresso e natura del moderno gusto in musica; la Critica di Mitzler con la sua risposta e note; Progetto d'una divisione della musica, ec. L'arrivo di Sarti a Coppenague fe' perdere a Scheibe in gran parte la sua riputazione come compositore. La musica leggiera e brillante di Sarti dovea necessariamente far cadere il genere grave, e pesante di Scheibe, e finì con perdere il suo posto, conservando nondimeno sino alla morte una pensione di 400 scudi. Poco prima di morire intraprese egli ancora un'opera sulla composizione musicale, che doveva contenere quattro volumi in 4º, ma egli morì immediatamente dopo la pubblicazione del primo, a Coppenague nel 1776, di 68 anni. Le altre opere di costui sono: Degli intervalli e generi in musica, Amburgo 1729, Sull'antichità e l'origine della musica, principalmente della vocale, Lipsia 1754, Sulla Composizione in musica, 1 vol. contenente la teoria della melodia e dell'armonia, Lipsia 1773, in 8º. La chiarezza e la profondità sono gli ordinarj pregi delle opere di Scheibe.
Schlick (Rodolfo) è autore di un'opera latina impressa a Spira nel 1588 col titolo: Dell'origine, cultura ed importanza della musica, di cui fa menzione Christ. Aug. Heumann alla p. 270 del suo Prospetto di storia letteraria (Hannover 1746).
Schmidt (Tobia), di Nassau, è l'inventore del piano-harmonica. Quest'instromento è composto d'un piano-forte, che occupa un'estremità, e dall'altra di un'harmonica ad arco doppio e continuo, i di cui tasti sono i medesimi, che quei del cembalo: esso fila tutti i suoni a piacere, secondo la maggiore o minor pressione che riceve la tastiera. Mediante la continuità del movimento dell'arco, imita perfettamente il violino, la viola, il contrabbasso e l'organo. Il suo meccanismo è semplicissimo; gli effetti vengono espressi senza confondersi, e permettono ad un abile suonatore di disporne a suo arbitrio. La tastiera ha tutta l'arrendevolezza, che esige una mano avvezza a' più leggieri piano-forti (V. Annuaire de l'industrie française, 1811, et Archive des découvert. t. 2, 1810).
Schott (Gaspare), gesuita alemanno, fu per più anni professore di mattematica nel collegio di Palermo, e quindi a Wirzburgo, ove morì nel 1666. Il nono libro del suo Organum mathematicum pubblicato dai gesuiti dopo la di lui morte nel 1668, tratta della composizione musicale ne' due primi capitoli: nel terzo della definizione e divisione della musica, de' suoni, degli intervalli, e de' sistemi e generi musicali; nel 4º Della musica de' latini, e la moderna; nel 5º Di quel che si richiede per l'una e l'altra; ne' cap. 6 e 7 Della melopea, e sue regole; ne' cap. 8 e 9 Della composizione pratica del contrappunto. Si trova altresì la maniera di costruire molti stromenti automati di musica nella sua Mechanica hydraulico-Pneumatica par. 3.
Schroeter (Cristoforo) fu allievo a Dresda del maestro di cappella Schmidt, e dell'italiano Lotti, che quivi era venuto a scrivere per teatro. Schroeter veniva da costui impiegato a mattere in bello le sue partizioni, e a supplirvi le voci intermedie che aveva omesse. Dopo aver viaggiato per la Germania, l'Olanda e l'Inghilterra, si rese a Jena per istudiarvi più a fondo le belle-lettere. Ben presto essendosi fatto conoscere assai profondo nella musica, gli studenti di quell'università lo impegnarono a dar corso pubblico della teoria e pratica di quest'arte. Egli aderì al loro invito facendo uso della Teoria matematica della musica e della composizione di Mattheson. Dopo alcun tempo egli ottenne il posto di maestro di musica della chiesa principale di Nordhausen, dove terminò i suol giorni assai vecchio nel 1782. Le sue profonde ed estese cognizioni, e 'l zelo con cui si applicò alla sua arte, avrebbero meritato una miglior fortuna. Un monocordo, ch'eragli stato dato da Beguisch in Dresda diegli occasione di far delle dotte ricerche su questo strumento, e i suoi calcoli di musica, di cui fè uso allorchè divenne membro della Società musicale di Mitzler. L'accordo de' clavicembali, e le riparazioni ch'era uso a fare sui medesimi, gli diedero l'agio d'inventare il forte-piano, benchè non avesse avuto nemmeno l'onore di esserne riconosciuto come il primo inventore. Egli si è reso più celebre come autore di opere teoriche: eccone i titoli: Esame del Musico critico di Scheibe, t. 2, 1746, 1754. Il numero e i rapporti degli intervalli in musica, 1752. Esame del sistema degli intervalli di Telemann, 1753. Riflessioni sulla disputa cominciata da Sorge contro le idee di Marpurg, sulla derivazione de' temi armonici, 1763. Descrizione esatta d'un cembalo nuovamente inventato, e sul quale può suonarsi a piacere il forte ed il piano, con rami 1763. Istruzione sul basso continuo, Halbesstadt 1772. Hiller riguarda quest'opera come la più importante tra quelle di Schroeter. Le mie ultime occupazioni in musica con sei piani di temperamento ec. 1783. Egli ha scritto altresì la sua Biografia, e la Storia dell'armonia, nella quale fa molte ricerche sull'epoca, il luogo, da che, e in quale occasione l'armonia è stata arricchita di un nuovo intervallo o di un accordo sino allora incognito. Nulla diremo delle sue composizioni, perchè non sono conosciute in Italia.
Schuback (Giacomo), sindaco della città di Amburgo, alle sue estese cognizioni nel dritto unì uno squisito gusto per la musica. Egli sonava non solo con estrema abilità molti stromenti, e sapeva ben destramente regolare un'orchestra, ma si è ancora distinto come compositore ed autore di musica. La musica di Amburgo a lui deve l'idea della sala del concerto, di cui regolò eziandio la costruzione. Egli terminò quivi i suoi giorni nel 1784. Tra le opere che ha lasciate sulla musica, la più interessante è quella della Declamazione musicale, Gottinga 1775 di cui Forkel dà un estratto nel t. 3 della sua Biblioteca.
Schubart (Daniele), uno de' più distinti poeti dell'Alemagna, e direttore della musica della corte e del teatro di Stutgard nacque nel 1741. Egli è di un'abilità straordinaria sul forte-piano, e a giudicar dalle sue composizioni, egli è meno compositore e contrappuntista che teorico profondo, luminoso e di gusto. Nella sua Cronica Alemanna ha egli inserite molte dissertazioni sopra diversi soggetti di musica. Nel 1783 pubblicò ad Ausburgo Complaintes addressées a mon clavecin, e nel 1790 Aesthetick der Tonkunst, ossia l'Estetica della musica, opera assai dotta, e citata con lode dal Dr. Lichtenthal. Saggio è il giudizio, che reca Schubart in questo libro dello stile di chiesa dell'Haydn. “Il suo stile, egli dice a carte 79, è focoso, pieno e nobile, e l'esultanza de' suoi alleluja e de' suoi amen si distingue singolarmente, se non che talvolta propende al gusto austriaco anche negli abbellimenti delle sue messe. Questi sono troppo affollati, e diminuiscono l'effetto: simili frascherie rassembrano al vario pinto abito d'arlecchino, e contaminano lo stile di chiesa.”
Schultes (Gio. Paolo), secretario perpetuo della classe delle belle-arti dell'Accademia italiana in Livorno; nacque a Techeim nel 1748. Apprese i primi elementi della musica sì vocale che stromentale da suo padre, ed ebbe lezioni di cembalo e di composizione a Erlanghen da Kehl, e da Emman. Bach. Nel 1773 venne a stabilirsi in Italia, ove i suoi talenti presero una consistenza, che sorprese lui stesso, e gli procacciò l'incoraggiamenti degli Haydn, Mozart, Paesiello, del P. Mattei, Forkel, Reichardt, ec. Nel 1782 fu chiamato dalla corte di Toscana per esservi sentito. Il gran duca Leopoldo, e l'arciduchessa sua sposa, il ricolmarono di doni, e di elogi. Egli è in commercio co' più illustri musici della Francia, dell'Italia, e della Germania. Abbiamo di lui 14 opere di musica stromentale impresse a Livorno, a Londra, a Firenze ec., di sonate per piano forte, di quartetti, di variazioni, tra le quali è da rimarcarsi la Riconciliazione di due amici, tema con variazioni per forte-piano, op. XII, dedicato ad Haydn, che l'aggradì moltissimo, e lodonne l'autore. Schultes è altresì autore di un Trattato della musica di chiesa, in 8º, Livorno 1809.
Schulz (Pietro), di Luneburgo, dopo avere studiato il contrappunto a Berlino sotto il cel. Kirnberger, entrò al servigio di una principessa della Polonia, con cui ebbe l'agio di viaggiare per la Francia e l'Italia, e conoscervi lo stato della musica, e sentire i migliori virtuosi. Di ritorno a Berlino nel 1774 compilò tutti gli articoli relativi alla musica nel 2º vol. della teoria delle Belle-Arti di Sulzer, travaglio che riunì in suo favore i suffragj degli intendenti. Poco dopo fu direttore dell'orchestra del teatro francese a Berlino, e nel 1780 il principe Enrico lo nominò suo maestro di cappella; pubblicò allora la più parte delle interessanti sue opere. Nel 1787 divenne maestro di cappella della corte di Coppenhague. Gli articoli della teoria di Sulzer fanno fede delle profonde sue cognizioni in musica: ma chi vuole perfettamente conoscerlo studii le sue opere pratiche per il canto, e rimarrà convinto, che niun maestro esiste, che com'egli abbia saputo prendere in tutte le gradazioni il senso del testo, dalla canzonetta burlesca sino al canto serio della chiesa: quest'è l'opinione di M. Gerber. Le sue opere teoriche sono, oltre i sullodati articoli, Progetto d'una intavolatura nuova, ed intelligibilissima in musica, ec. Berlino 1786. Idee sull'influenza della musica per rapporto alla civilizzazione delle nazioni, Copenhague 1790. Vi ha inoltre di lui molta musica per teatro, ed instrumentale impressa a Lipsia, a Berlino e a Copenhague.
Schuster (Giuseppe), uno de' più graziosi compositori della Germania, nacque a Dresda nel 1748; suo padre, musico della camera e cappella del re di Polonia, gli diede Schurer per maestro, ma per vieppiù perfezionarsi nell'arte, fece egli col maestro di cappella Naumann nel 1765 un viaggio in Italia, ove studiò il contrappunto in Venezia sotto il cel. Girolamo Pera, profittando nel tempo stesso delle lezioni e de' consigli di Naumann. Lo stile gajo e brioso, che caratterizza le sue composizioni, gli valse ne' tre anni che vi dimorò la più favorevole accoglienza su molti teatri dell'Italia. Se gli rese l'istessa giustizia al suo ritorno in Dresda, e l'elettore nel 1772 lo nominò suo compositore per chiesa, e per camera. Sul pensiero di conoscere intimamente la maniera del cel. P. Martini di Bologna, nel 1774 fece un secondo viaggio in Italia, e compose allora più opere per i teatri di Napoli, e di Venezia. In questo viaggio fu che il nostro sovrano Ferdinando lo nominò suo maestro di cappella, e compose egli la sua cel. Didone. Un nuovo invito lo ricondusse nel 1778 per la terza volta in Italia: oltre gli onori e le ricompense per le sue composizioni, egli vi godè il commercio del cel. Hasse, che in un' età decrepita viveva nel ritiro in Venezia. Nel 1781 a lui consegnò il Sassone l'ultima opera che aveva composta, cioè una messa a 4 voci per offerirla all'Elettore. Nel 1787 questo principe nominò Schuster suo maestro di cappella, e affidogli, a vicenda con Naumann e Seydelmann, la direzione della musica sì del teatro, che della chiesa. Le sue composizioni per teatro sono l'Alchimista, l'Isola deserta in un atto, Il marito indolente; Gli due avari, 1787; Amore e Psiche; la Didone; le lodi della musica, cantata che contiene tra le altre, sette arie sublimi, e di cui ve n'ha un estratto per cembalo, 1784. Per gli stromenti: Sei divertimenti per il cembalo con violino; Un concerto pel forte-piano; Recueil de petites pièces pour le clavecin a 4 mains, Dresda 1790; Alcune sinfonie. Le opere di Schuster sono pregevoli per molta vivacità ed immaginazione, e per uno stile animato e brillante. Vi s'incontrano assai volte delle idee talmente comiche, che riesce malagevole il trattenersi sul serio: così è che le sue composizioni sono oltre ad ogni credere in somma stima presso i tedeschi.
Schutz (Francesco), pittore e musico cel. nacque a Francfort nel 1751. Suo padre, rinomato pittore del pari, gl'insegnò la sua arte sin dalla più tenera età, e tai progressi vi fece, che un viaggiatore di qualità seco il menò nella Svizzera nel 1777, affinchè vi dipingesse le viste assai pittoresche che offre quel paese. Da Basilea, egli portossi in Ginevra nel 1780, ove morì l'anno di appresso a motivo degli eccessi d'ogni genere, a cui abbandonossi. Il suo biografo, nelle Miscellanie di Meusel, f. 14, così dice di lui: “La sua passione per la musica era all'estremo, ed io non sapeva giudicare il più delle volte, s'egli amava più la pittura, o la musica. Il violino era il suo favorito: egli suonava a prima vista le parti più difficili, ed era in istato di proseguire per più ore senza comparirne stanco. Gl'intendenti eran di accordo ch'egli aveva il colpo d'arco fermo, nitido, e pien di vigore. Il suo suono aveva qualche cosa di particolare, che i più abili musici non potevano non ammirare.”
Schwanberger (Giov.), maestro di cappella del duca di Brunswick prese da principio Graun per suo modello, e si era reso di già familiare il suo stile, allorchè si determinò di portarsi in Italia. Studiò quindi la composizione in Venezia sotto la direzione di Latilla, e in appresso di Saratelli, maestro del conservatorio dei Mendicanti, e della chiesa di S. Marco. Dimorò quivi otto anni, e profittò così bene delle lezioni di questi gran maestri, che al suo ritorno fu generalmente stimato in Germania come uno de' primi compositori per teatro. Egli era altresì gran virtuoso sul forte-piano: il suo suono era leggiero, dilicato ed armonioso. Tra i drammi, che ha posto in musica, sono da rimarcarsi specialmente Giulietta e Romeo, l'Olimpiade nel 1782. Le sue 36 sonate per cembalo sono capi d'opera nel loro genere.
Schwarz (Giorgio), dottore in filosofia e professore nell'università di Altorff pubblicò nel 1765: De musicæ morumque cognatione in 4º.
Sciroli (Gregorio) fu per qualche tempo maestro di musica del Conservatorio de' figliuoli dispersi di Palermo, verso la prima metà dello scorso secolo. Egli era della buona scuola di Napoli sua patria, ma non sortì dalla natura un gusto delicato ed originale che distingue i grandi artisti. Nel 1770 fece imprimere in Parigi sei trio per violini.
Scorpione (Domenic.), frate conventuale da Rossano nel regno di Napoli, fu maestro di cappella in Roma e nel Duomo di Messina. Abbiamo di lui Riflessioni armoniche, Napoli 1701.
Senocrito, di Locri nella Magna Grecia, nato cieco, fu poeta e musico eccellente, di cui favella Eraclide (de Polit.). Fioriva egli otto secoli innanzi l'era cristiana. (Signorelli Colt. delle due Sicil. t. 1).
Senofane, di Colofone nella Jonia, poeta musico, e fondatore della scuola filosofica d'Elea, esiliato dalla sua patria, venne a stabilirsi in Sicilia, dove per sostenere la sua famiglia, non ebbe altro mezzo che la musica. Egli andava cantando e suonando per le piazze le sue poesie, come facevano i primi filosofi. Visse sei secoli prima di G. C. (V, Laert. lib. 9. Bruker. Hist. Philos t. 1).
Seré (M. de) è autore di un Poema sulla musica, cui diè per titolo: Les Dons des enfans de Latone, Paris 1734, in 8º. Esso è diviso in quattro Canti: il suo autore ha avuto l'arte di farvi entrare di una maniera sì ingegnosa che naturale tutto ciò che la musica ha di più profondo ed astratto. Non trascura altresì la parte didattica onde vi spiega i principj dell'arte, e vi unisce alcune regole della composizione. Per render queste più sensibili, egli ha fatto imprimere molti rami, dove veggonsi in dettaglio gli elementi della modulazione, e dell'armonia. Nel terzo e quarto Canto egli espone il gusto, e 'l carattere della musica italiana, ch'egli preferisce alla francese, e fa l'elogio de' gran maestri in quest'arte, come Scarlatti, Bononcini, Hendel, che sebbene tedesco, merita di essere annoverato tra gli italiani. Il Poeta, dopo avere dimostrato come il gusto italiano sparso in Francia ha contribuito a migliorare la musica, finisce con formar de' voti per la riunione delle Due Sorelle, la musica italiana e la francese. La musique n'est qu'une et ces mêmes accords par tout doivent former de semblables transports. Questo Poema ha meritato la stima e gli elogj degli intendenti, e possiam dire l'autore un degli apostoli del buon gusto, e della musica italiana in Francia.
Serre (Jean-Adam), cittadino di Ginevra, profondo nella fisica e dotto musico, era grande antagonista delle teorie di Rameau e di Tartini. Avendo viaggiato in Italia, ebbe quivi cognizione degli sperimenti del Tartini; e trovato avendo insufficienti a molti riguardi i principj del Rameau, inventò un altro Sistema misto, che non vale più, a dir vero, degli altri due. Egli pubblicò in Parigi nel 1753: Essai sur les principes de l'harmonie e nel 1763 a Ginevra: Observations sur les principes de l'harmonie, occasionées par quelques écrits modernes sur ce sujet, et particuliérement par l'article de M. d'Alembert basse fondamental dans l'Encyclopédie, le Traité de Théorie musicale de M. Tartini, et le Guide harmonique de M. Geminiani, in 8vo.
Sesto Empirico, medico e filosofo celebre per il suo pirronismo, che non bisogna confondere con Sesto di Cheronea filosofo Stoico, e nipote di Plutarco, come sull'autorità di Suida ha fatto l'illustre Requeno. Egli è autore di una grande opera contro gli mattematici, o coloro che professano le scienze, Istituzioni Pirroniche in sei libri, nell'ultimo de' quali attacca la musica considerata come scienza, che tratta de' suoni, delle modulazioni e del ritmo. Egli si dichiara contro i maravigliosi effetti della musica, narrati dagli antichi scrittori, ed armato unicamente dell'acutezza del suo ingegno, e delle idee, che gli presentava in quel tempo di decadimento quest'arte, dichiara doversi avere in conto di favole le narrazioni degli antichi armonici. “Sesto Empirico, dice il sullodato Requeno, era uno di quei letterati, con cui può più la vanagloria e la cupidigia che l'amore del giusto e della verità.” (Saggi t. 1. p. 287). Egli avrebbe dovuto tacersi intorno alla musica (come ben riflettè un moderno filosofo,) pretendendo che non ve ne fosse, e che l'armonia sia una pura chimera. Nulla offende tanto quanto il carattere di un uomo che contraddice tutto per fare il bello spirito. Non si dee mai contendere contro il testimonio de' sensi, allorchè si sono prese le necessarie precauzioni per non restarvi deluso. (M. le Clerc, Bib. anc. et mod. t. 14).