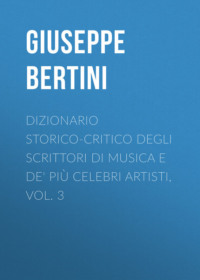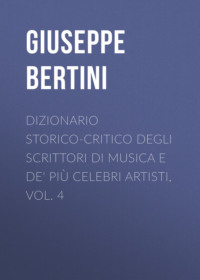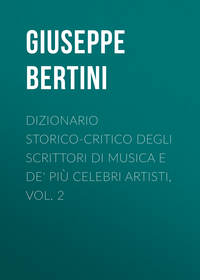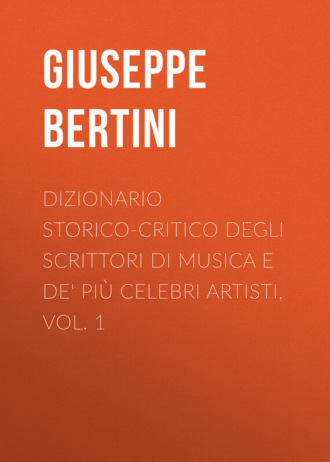
Полная версия
Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 1
9
“La variazione dei tempi, dice il dotto Arteaga, la diversità de' gusti, che tanto influisce su le cose musicali, e forse ancora l'eccessivo lusso della musica presente farebbero in oggi comparir quella assai povera e rozza. In fatti scarseggia di note, il senso non vi si comprende abbastanza, abbonda poco di varietà… ma in contraccambio regna in quelle composizioni una certa semplicità preferibile a molti riguardi alla sfoggiata pompa della nostra… Maestri e musici del nostro tempo, che col fasto proprio dell'ignoranza vilipendete le gloriose fatiche degli altri secoli, ditemi se alcun si trova fra voi che sappia tanto avanti nei principj filosofici dell'arte propria quanto sapevano quegli uomini, che voi onorate coll'urbano titolo di seguaci del rancidume ec.” Rivoluz. t. 1, p. 257.
10
Per questa ragione ho omesso più articoli di Compositori di musica madrigalesca Siciliani, che riferiti vengono dal Mongitori nella sua Biblioteca Sicola, ove, chi avrebbe tale curiosità, può ben soddisfarsela. Ho creduto dovere avvertirlo, affinchè una tale omissione non mi si attribuisca a freddezza e disinvoltura per le cose patriottiche. Non ho trascurato per altro di far menzione di molti tra' nostri nazionali che han reso un particolar servizio alla Musica o come Scrittori, o come Artisti.
11
“Alla Musica è avvenuto lo stesso che a tutte le altre Arti inventate dagli uomini; il caso da principio ha imparati alcuni fatti; l'osservazione e la riflessione ne ha ben presto scoverti degli altri; e da questi differenti fatti, combinati e messi insieme, non han tardato i Filosofi di formare un corpo di Scienza, che quindi si è per gradi accresciuto.” M. d'Alembert, Elém. de Mus. etc.
12
L'Acustica è la teoria del suono, ed ha per oggetti: 1. i rapporti numerici delle vibrazioni, 2. le vibrazioni proprie de' corpi sonori, 3. le vibrazioni comunicate ossia la propagazione del suono, 4. la sensazione del suono, o l'udito. Il num. 1 forma la parte aritmetica, i num. 2 e 3 la parte meccanica, e il num. 4, la parte fisiologica dell'Acustica. La parte meccanica è molto utile per l'invenzione di nuovi stromenti musicali, e per la perfezione di que' già ritrovati: come ancora per il loro temperamento.
13
L'erudito ab. Andres ha tessuto colla sua solita precisione e chiarezza la Storia dell'Acustica nel 4º tomo, ove tratta di quella delle Mattematiche. Ed ecco qual giudizio egli reca degli antichi coltivatori della medesima. “Ma potremo dir nondimeno (sono le sue parole), che ad alto grido fosse realmente venuto il loro sapere in questa materia? Veramente le loro cognizioni meccaniche nella formazione del suono non possono dirsi molto avanzate. Nicomaco lungamente ci spiega la dottrina de' pitagorici, e lo strepito e suono, che volevano prodursi da tutti i corpi moventisi, e le acustiche proporzioni de' suoni musicali, che credevano poter didurre dal moto circolare de' sette pianeti… ma confesso che non so vedervi che somma scarsezza d'astronomiche cognizioni, ed ignoranza nelle meccaniche ed acustiche. Questa ignoranza ci viene in oltre mostrata in tutti i Greci dagli spacciati e creduti racconti de' martelli, de' bicchieri, de' piatti, quali provano nondimeno, che qualche confusa idea pur v'era de' principj del suono, e degli elementi di lunghezza, grossezza, e tensione, che deono entrare nel suo calcolo. Aristotele, Eliano e Porfirio sono gli unici antichi, ch'abbiano trattato della meccanica del suono; ma que' profondi filosofi altro non seppero discoprire, se non che il moto dell'aria è la cagione del suono che grave producesi col moto tardo, acuto col celere, e che perciò le corde più lunghe e più grosse daranno un suono più grave, grossolanamente sbagliando nel farne l'applicazione agli stromenti da fiato, e generalmente poco sapendo della meccanica del suono.”
14
V. il vol. 7 dell'antica Enciclopedia, p. 62.
15
Il P. Sacchi nella sua dotta lettera al Sig. Pichl sulle Quinte successive nel Contrappunto ec., dopo avere riferite queste medesime parole dell'Alembert p. 73, così soggiunge: “Un recentissimo Scrittore (il Sig. Testori), il quale per altro nella pratica è stato a ragione in questi tempi molto celebre, ha voluto procedere per l'antica via; e di più insulta all'avviso del dottissimo filosofo, e matematico dicendo: scherzi per tanto a suo talento quel bello spirito: se ne faccia pure scudo il pratico Professore: e se ne formi scimitarra quel tal Matematico per tutto distruggere, e far della Musica un Caos; mentre noi seguendo le traccie di Cl. Tolomeo, di Severino Boezio, e d'altri simili Autori, ci adopereremo a stabilire ed a conservar la Musica nel suo diritto di scienza matematica. Io vorrei, che l'illustre Autore avesse preso altro cammino, che ben poteva e sapeva: e che da queste parole, con troppa confidenza dette, si fosse astenuto. Certamente la Musica, cioè la sua prima parte, l'Acustica, appartiene alla Matematica, secondo ch'io penso; ma se noi ci contenteremo di esprimere le vere misure delle corde, e delle voci, e le vere proporzioni delle consonanze, ben pochi numeri ci basteranno.”
16
Terminiamo questa materia con l'autorità di un altro dotto spagnuolo, e filosofo-musico: egli è l'ab. Requeno. “Un altro pregiudizio, egli dice, non solo è stato comune a' grandi ed a' piccioli professori, ma a tutte eziandio le persone di studio e fin anco alla plebe; ed è, che, per parlare a fondo della Musica antica o moderna, fosse di bisogno la Matematica, la scienza del numero pel calcolo delle corde armoniche: contro della quale preoccupazione ardente e coraggioso si dichiarò il primo a ragione lo spregiudicato Eximeno, da cui è dimostrata nella moderna armonia l'insufficienza del calcolo. Noi, per dimostrarla nell'antica, ci rimettiamo a' più rispettabili de' greci armonici, in cui non è bisogno d'altro calcolo oltre quello di saper contare sino a dodici, come faremo palese nel proprio luogo ec.” Saggi sul ristabilim. dell'Arte armonica de' greci, ec. Prefaz. Tom. I. p. XXVIII.
17
“Noi non dubitiamo punto di asserire, dice il dotto Mr. Choron, che questo prurito di applicare la fisica e la geometria alla musica, e di pretendere dedurne le regole d'un'arte unicamente fondata sull'organizazzione e la natura dell'uomo, non sia il più caratteristico contrassegno dell'ignoranza e falsità di spirito. Non già che la cognizion della fisica o della geometria sia del tutto inutile al musico; ma fa d'uopo di molto discernimento per conoscere precisamente l'uso che farne conviene.” (V. art. Rameau) Egli promette ancora di mostrar ciò con più estensione, e con argomenti i più decisivi, in un trattato che è presso a dare al pubblico.
18
Tale è il sistema o la teoria di Rameau, della quale così ragiona Mr. Framery uno degli autori della nuova Enciclopedia metodica. “La più parte delle sue regole, egli dice, in contraddizione con la pratica, producono almanco tante eccezioni quanti sono i casi, ai quali si applicano, e quindi non servono che ad inviluppare lo spirito. Questa difficoltà di accordare la pratica col suo sistema ha trascinato Rameau in molti errori.” (Préf. à l'Encycl. method. de la Musique, a Paris 1791, in 4º.) Tale è il sistema del per altro pregevolissimo Tartini, il quale per testimonianza medesima del suo intimo amico il P. Colombo, ignorando fin anco l'aritmetica semplice, volle ciò non ostante fare gran pompa di calcoli, e darsi così l'aria di un profondo teorico. Gran violinista, eccellente compositore, ma niente geometra; debole fisico e più cattivo logico, ebbe la smania, come Rameau, di fare un sistema così involuto ed oscuro, che nè il lettore, nè potè egli stesso nulla intendervi: non era in fatti possibile, se non a forza di oscurità il dare un'apparenza di realità a siffatte chimere (Veggansi Forkel, Musikalisk Almanac; e Scheibe, Tratt. di Composiz.) Bastino questi due esempi come de' più celebri per giudicare del resto.
19
Il primo di costoro nell'eccellente Opera dell'Origine ec. nel cap. V, del I libro: e l'altro nell'Esame del sistema musico di Mr. Rameau, stampato nel 1779. V. il Gior. de' Letter. d'Italia in Modena, tom. 21.
20
“Rameau, dice Mr. Choron, ebbe in Francia assai comentatori del tutto stranieri per l'arte, ma che ebbero il talento di persuadere il pubblico, ch'egli era il creatore d'una scienza di cui ne rovesciava i principj.” (V. Esquisse historique des progrès de la Composition, pag. 29.) Ben può a lui applicarsi quel che di Ronsard disse Boileau:
… par autre méthodeRéglant tout, brouilla tout, fit un art à sa mode. Art. Poet.21
Nel tempo stesso in cui i Francesi impazzavano per il sistema di Rameau, le scuole più celebri dell'Italia e della Germania non ne fecero verun conto, e conoscendone i difetti e l'inutilità insieme, si accinsero a confutarlo. Venuto meno col progresso del tempo in Francia l'entusiasmo e lo spirito di partito, cadde ancora colà. Ecco come ne ragiona uno Scrittore classico di questa nazione. “Rameau, egli dice, non ostante tutti i suoi sforzi, è a ciascun passo in contraddizione con la pratica della scuola: ed altro risultato non produce che l'avere introdotto nell'atto della composizione la considerazione assai disagiosa e per altro del tutto inutile dei rivolti d'armonia. Quest'è la ragione per cui il suo sistema, che mai è stato ricevuto nè in Italia, nè in Alemagna, è oggidì universalmente rigettato fin anco in Francia.” (Choron, Princip. de Composit., a Paris 1808.) E pure chi il crederebbe? un recente scrittore sedicente filarmonico, che forse non sortì altro dalla natura che uno sterile amore per l'armonia, in una delle sue lettere, o per dir meglio in una delle sue rapsodie misarmoniche vuol darci a credere che fosse il Rameau un altro Prometeo che furò a Giove il fuoco dal cielo, e furando egli medesimo le stessissime parole dell'Alembert e d'altri entusiasti francesi ci ripete la vecchia loro nenia, cioè che “prima del celebre Rameau una cieca esperienza era l'unica bussola degli artisti: e ch'egli il primo ha fatto divenir la Musica una scienza degna di occupare i filosofi, ec.” Ma chi non sa che sommi uomini prima di Rameau fatto avean della Musica una scienza che meritevole la resero dell'attenzion de' filosofi? Tali furono e Galileo, e Doni, e Cavalieri, e Gassendi, e Mersenne, e Cartesio, e Wallis e cento altri. Risum teneatis amici? Dopo così smodati elogj profusi al suo caro Rameau, pretende sin anco inbeccarci il di lui sistema del basso fondamentale e de' rivolti, come esatto e facile e nuovo e 'l migliore che sia possibile. Quel ch'è peggio, si è che al dir di Boileau,
Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire22
Ben vero è però, che sebbene il Rousseau lodi alle volte ed esponga nel suo Dizionario il sistema di Rameau, perchè più generalmente conosciuto e in gran voga allora presso la sua nazione, a pro della quale destinava egli principalmente il suo libro, tuttavia così si protesta in sul principio: Quoique ce systême imparfait et défectueux à tant d'égards, ne soit point, selon moi, celui de la Nature et de la verité (Préf. p. VIII).
23
A chi ha cognizione dell'economia, del commercio dell'anima e del corpo, e singolarmente delle sensazioni che si sveglian in noi per via di tremori, facile in vero è l'immaginare la forza e gli effetti fisici della Musica. Imperciocchè l'armonia stessa non è che tremor potentissimo pria nel corpo sonoro, e quindi nell'aria eccitato, e comunicato finalmente ai nervi dell'udito. Laonde a questa forza è dovuta la sensazion potentissima che si sveglia nell'anima, siccome il mostran le anime ancor irragionevoli delle bestie, or ammansate, or dalla musica ridotte a maggior furore, ma molto più quelle ragionevoli degli uomini, giacchè di questi leggiamo e li vediamo ancor noi alle volte tratti fuor di se non potere agire che a seconda degli affetti dalla Musica inspirati.
24
Questa idea, dice il Dr. Lichtenthal, non fu onorata sinora secondo la sua eccellenza, e raramente ha potuto gloriarsi di alcuni paragrafi presso gli autori. Egli cercando di spargere più di lume su questo punto diè al pubblico nel 1806, primieramente in lingua tedesca e quindi da lui stesso nell'italiana tradotto il suo Trattato dell'influenza della Musica sul corpo umano, e del suo uso in certe malattie, Milano 1811, in 8vo. Anche il Dr. Mojon italiano, professore di medicina in Genova, celebre per più dotte opere in questa facoltà date alla luce, pubblicò quivi una Memoria sull'utilità della Musica sì nello stato di sanità, che in quello di malattia, tradotta poi nel francese dal Dr. Muggetti, e impressa in Parigi nel 1803, in 8vo.
25
Anche i Cinesi vantano qualche Scrittore della loro musica. Nel Giornale Straniero dell'ab. Arnaud nel mese di Luglio 1761 si trova l'estratto di una produzione ms. di un libro intorno all'Antica Musica Cinese composta da Ly-Koang-Ty dottore e membro del primo tribunale di lettere di quell'impero. Su la musica de' Cinesi possono anche consultarsi le Memorie del P. Amiot, e l'articolo ben lungo di M. Ginguené nella nuova Enciclopedia, Musique des Chinois.
26
Veggansi più luoghi della divina Scrittura, come nel Genesi, nell'Esodo, nei libri de' Re, e de' Paralipomeni, ed il cap. 44, dell'Ecclesiastico.
27
Intorno all'origine della musica presso i Greci, puossi leggere con profitto la Storia che con fior di erudizione e di senno ne tesse il dotto ab. Requeno. Egli ne fa derivar loro la cognizione dagli Egizj, ed a questi dai figli di Noemo, che appreso l'avevano dai discendenti de' primi inventori del suono e del canto Jubal ed Enoch. Saggi ec. Tom. 1, cap. 2, e. 4.
28
Leggasi l'esposizione di questo strano sistema nell'opera classica dell'Eximeno, e la dotta confutazione insieme ch'egli ne ha fatta nel cap. 1, del primo libro. “I moderni letterati credono, che Pitagora perfezionasse l'arte armonica, e che la cavasse dall'antica rozzezza; ma basta vedere il piano dell'arte musica anteriore a Pitagora, e l'altro da lui introdotto nella Grecia, per capire quanto danno arrecassero i Pitagorici all'armonia.” Requeno Saggi t. 1, part. 2, cap. 1.
29
Ecco le sue parole: “Ci starebbe molto a cuore che per rischiarare, per quanto sia possibile, questo punto importante della Storia delle Scienze, qualche uomo di lettere, versato del pari nella lingua greca e nella musica, si accingesse a riunire e discutere in una stessa opera le opinioni più verisimili stabilite o proposte dai dotti sopra un argomento sì curioso e difficile. Questa Storia ragionata dell'antica Musica è un'opera che manca alla nostra letteratura.” Disc. prélim. aux Elém. de Mus.
30
Brown, dissert. sull'origine, unione ec. della poesia e della musica, Londra 1763.
31
Nell'Enciclopedia Metodica all'articolo Arabes si dà un Saggio della musica specolativa e pratica di questa nazione.
32
C'est aux Italiens que l'Europe doit la renaissance de la musique comme de tous les arts. Mr. Suard, au mot Académie dans l'Encyclop. method.
33
Sotto il glorioso governo e la protezione de' generosi nostri Sovrani Carlo e Ferdinando, esistevano in florido stato questi Conservatorj di Napoli. La provida cura e 'l zelo per gli avanzamenti di questa bell'arte mossero l'attuale nostro Monarca a formar sin anche per quello detto della Pietà nel 1792; una copiosa Biblioteca di libri teorici, non che di carte d'ogni genere di Musica antica e moderna, di cui ne affidò l'impegno al celebre letterato D. Saverio Mattei. Ma, da che questa città cadde sotto la dominazione francese, si sa che i tre Conservatorj furon ridotti a un solo, la di cui organizazzione, per confession medesima di M. Choron, non ha riuniti i suffragj di tutti.
34
Una pia fondazione di un Conservatorio vi ha anche in Palermo sin dal 1618, detto de' figliuoli dispersi, ai quali facevansi solo da prima apprendere le arti meccaniche. Pensò quindi saggiamente il Governo nel 1747 di aggiungervi la musica ed altri studj per migliorarne l'educazione. Prosperi ne furono i principj, e non pochi allievi ne sortirono virtuosi per la composizione, per il canto e la parte strumentale, che non solo si sparsero in tutto il regno, ma portatisi alcuni di loro in Germania, in Francia, in Spagna, in Inghilterra ed altrove, o vi si stabilirono con onore ed ottimo successo, o ritornarono nella patria dopo di avervi riscossi e meritati degli applausi. Moltissimi potrei annoverarne se non me l'impedisse la brevità d'una nota. Coll'andar però del tempo, per le angustie del paese, più non bastando le rendite a mantenere il necessario numero de' maestri, ed un sufficiente numero di allievi per tutti i rami dell'Arte, questo Conservatorio di Musica è venuto meno a segno che corresi rischio di non esservi di quà a pochi anni più musica in Sicilia. L'anno scorso volendovi provvedere il Governo, diè a me e al Sig. Guerra l'ordine di formare un Piano di Scuola di Musica per una nuova organizazzione del Conservatorio: si ebbe la bontà di approvarlo; ma altre più interessanti cure gli sono state sinora d'ostacolo, perchè non si sia potuto mettere in esecuzione.
Il Conservatorio di Milano è d'una data assai recente: egli non fu stabilito che nel 1808, il cel. maestro Bonifacio Asioli ne ebbe allora la direzione. Egli è formato di 14 professori e di 60 allievi tanto pensionarj che esteri, e ha dati già de' soddisfacenti risultati. Di ciò ne sia un picciol saggio, che dopo men di quattro anni della sua istituzione si fu in istato di farvi eseguire con esattezza la cel. musica della Creazione e delle quattro stagioni di Haydn da' suoi allievi, come glie ne rende pubblica testimonianza il Sig. Carpani nelle sue Haydine, Lett. 11, nella nota p. 186.
35
La scuola italiana, dice quest'ultimo, è la migliore che esiste, tanto per la composizione che per il canto; la melodia degli Italiani è semplice e bella… Con qual piacere io mi trovai in un colpo nelle praterie smaltate di fiori, dove si sarebbe detto che un Genio benefico mi avesse trasportato dalla terra ai cieli! Ma quale fu la mia sorpresa allorchè intesi per la prima volta i canti italiani… questa fu la prima lezione di musica che io ricevetti in un paese ove io correva per instruirmene. Le contrade settentrionali di Europa non han mai prodotto Artisti segnalati, che non abbiano fatto un soggiorno più o meno lungo nell'Italia. Sembra al certo, che questo sia un tributo da pagarsi a quel clima privilegiato, che in ricompensa ne assicura la loro riputazione. Gretry, Essai de Musique, p. 131 seg. edit. de Paris.
36
Non solo gli Imperatori ma la più parte eziandio de' Principi della Germania sono stati in ogni tempo i più zelanti e più generosi Mecenati di un'Arte che essi medesimi per lo più non isdegnavano di coltivare. L'elettor Palatino, la di lui sorella l'elettrice di Sassonia, a cui si fè gloria di dedicar l'Opera sua l'Eximeno, il duca di Wittenberga, senza escluderne il gran Federico re di Prussia sono stati compositori di musica. Si sa che quest'ultimo, il quale regolava da se stesso tutti gli affari di un gran regno, trovava il tempo di sonar di flauto ciascun giorno, per levarsi di noja, con Quantz suo maestro, e che compose un minuetto nella sua tenda dopo aver perduta la battaglia di Collin.
37
Il dotto ab. Lami, che per più anni in un foglio periodico di Firenze proccurò di spargere de' lumi e del buon gusto nell'Italia, mostrava un dì a un forestiero le curiosità di quel paese. Nel vedere il palazzo Pitti, ecco, disse il forestiero, la culla delle arti; ed eccone la sepoltura, gli rispose Lami, nel mostrargli la casa de' Gesuiti che era dirimpetto a quel palazzo.
38
In Berlino vi ha uno stabilimento per mantener 24 figliuoli, che sono instruiti nella musica, vestiti in uniforme, e vanno così a cantar per le strade.
39
Les françois sont celui des peuples qui paroissent avoir l'oreille la moins musicale (M. Suard).
40
Questo è il titolo dell'opera: Dictionnaire Historique des Musiciens Artistes & Amateurs, morts ou vivans, qui se sont illustrés en une partie quelconque de la Musique et des Arts qui y sont relatifs, tels que Compositeurs, Ecrivains didactiques, Théoriciens, Poëtes, Auteurs lyriques, Chanteurs, Instrumentistes, Luthiers, Facteurs, Graveurs, Imprimeurs de musique, etc. Par Al. Choron et F. Fayolle, tom. 2, in 8vo a Paris 1810, e 1711.
41
La santé de M. Choron ayant éprouvé un dérangement assez long et assez violent, M. Fayolle resta seul chargé du travail, et le fit presqu'en entier; en sorte que, si l'on excepte l'introduction et un très-petit nombre d'articles, cet ouvrage est devenu le sien. Avant-Propos p. 1.